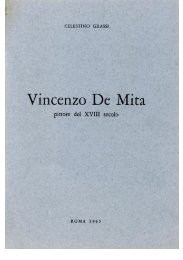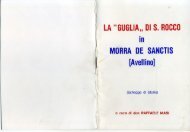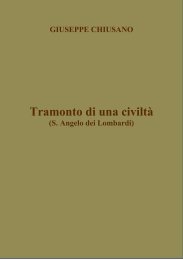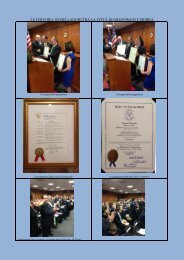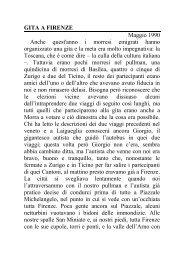Atti dei seminari di studi desanctisiani - Morreseemigrato.Ch
Atti dei seminari di studi desanctisiani - Morreseemigrato.Ch
Atti dei seminari di studi desanctisiani - Morreseemigrato.Ch
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
fine.<br />
Subito dopo anche per il protagonista due aggettivi, la prima consapevole descrizione:<br />
EGOISTA, GIOVANE. L’aggettivo GIOVANE è emblematico <strong>di</strong> un contrasto che si<br />
viene a creare con il titolo del romanzo: GIOVANE-SENILITA’, dove il giovane è un<br />
vecchio “cauto”. Non appena è entrata in scena la sorella (c’è da notare che finora nessun<br />
personaggio ha un nome, come se non ci fosse ancora una forma per loro), Svevo descrive<br />
la relazione tra i due. Non si serve <strong>di</strong> immagini, ma usa parole come “vita, responsabilità,<br />
destino” che concorrono ad “invecchiare” il personaggio; e ancora “cauto”, quasi a<br />
rallentare nuovamente la narrazione, passando dal tempo del presto al tempo dell’andante.<br />
Lei è la donna-madre, anche se più giovane. E’ come se Svevo, per raccontare della<br />
“vecchiezza” del protagonista, si servisse <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> allusioni.<br />
Il protagonista è il GIOVANE, ma la sorella è più giovane <strong>di</strong> lui. Lui si sente le spalle<br />
“gravate dal senso <strong>di</strong> responsabilità”, anche se la sorella gli fa da madre. Si vanno ad<br />
intrecciar fattori che determinano sempre una maggiore mancanza <strong>di</strong> linearità. La<br />
punteggiatura scan<strong>di</strong>sce il tempo della lettura, ma essa rimane col fiato sospeso al<br />
momento dell’enunciazione della relazione protagonista-sorella, così come nel primo<br />
<strong>di</strong>scorso <strong>di</strong>retto della parte iniziale. Anche qui un gancio, soluzione stilistica determinata<br />
da “go<strong>di</strong>mento, felicità”. La prima informazione vera e propria che abbiamo del<br />
protagonista si ha subito dopo: “a 35 anni”. Il rapporto col titolo si fa sempre più ambiguo.<br />
Trentacinque anni è l’età in cui, probabilmente, Dante fa il suo “VIAGGIO”. “Nel mezzo<br />
del cam- min <strong>di</strong> nostra vita”. L’elemento informativo non dà una caratterizzazione<br />
temporale, non sappiamo dove siamo, né quando, ma sappiamo che c’è un personaggio <strong>di</strong><br />
trentacinque anni, sua sorella, un’altra donna. La scelta <strong>di</strong> Svevo è precisa e determinata.<br />
Solinger, qualche decennio dopo parlerà dell’ “uomo dai capelli grigi” (scegliendo un<br />
elemento fisico come carattere), Pilnjack della cameriera col grembiule bianco. Questa<br />
informazione fa da ponte e serve per calare il personaggio nell’ambito del “go<strong>di</strong>mento e<br />
della felicità”. Egli è insod<strong>di</strong>sfatto e debole. Questo secondo paragrafo, “SVILUPPO”,<br />
potremmo <strong>di</strong>re, è fatto <strong>di</strong> sensazioni più che <strong>di</strong> sentimenti e <strong>di</strong> ascolto più che <strong>di</strong> immagini.<br />
Soltanto verso la metà il personaggio prende forma: ci viene presentato, ci viene detto il<br />
nome: Emilio Brentani. E Svevo lo fa sottovoce, facendolo scivolare, mentre parla della<br />
sua carriera, anche questa volta bipartita: due occupazioni e due scopi. Svevo, quando va<br />
ad approfon<strong>di</strong>re e racconta delle occupazioni, utilizza per lo più <strong>dei</strong> <strong>di</strong>minutivi:<br />
“impieguccio, famiglinola, reputazioncella”, come se il personaggio avesse un che <strong>di</strong><br />
negativo. Tutto è essenziale, il “giusto denaro” e l’altra carriera che lo “affaticava ancor<br />
meno”. Come contrapposizione ai <strong>di</strong>minutivi c’è il superlativo “lodatissimo”; riferito al<br />
romanzo, che dà luce alla scena. E’ questo forse l’unico elemento positivo del<br />
personaggio, smorzato, però, dalla descrizione successiva del romanzo. La carta su cui è<br />
stampato è “cattiva e ingiallita”. Questo rientra nell’ambito della corrispondenza bellobuono,<br />
brutto-cattivo che rimane archetipo <strong>di</strong> una società ingessata che vedrà, solo più<br />
tar<strong>di</strong>, una ROTTURA, a cui contribuisce anche la produzione cinematografica. Subito<br />
dopo un elemento <strong>di</strong> tempo: “Alla sua pubblicazione” e “ora”, quasi a voler creare questa<br />
idea del tempo che passa con una velocità quasi vertiginosa. Ne consegue l’evoluzione<br />
nella fama dello scrittore, chiuso nell’ambito della città. Il giu<strong>di</strong>zio è ironico, è il segno<br />
che il tempo lascia, tempo dell’evoluzione dello scrittore. La carta ingiallita è segno<br />
dell’anzianità del libro, un modo semplice per parlare del logorio delle cose e delle<br />
persone, del cambiamento, ma in modo particolare del loro deterioramento. Si chiude qui<br />
la seconda parte e inizia la “RIPRESA”. La narrazione, in questa seconda parte, è ferma,<br />
per poter dare rilievo al protagonista, per metterlo in relazione con la famiglia e con la