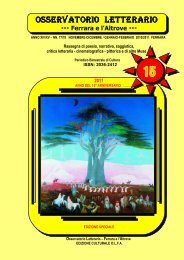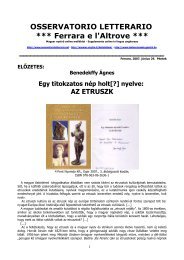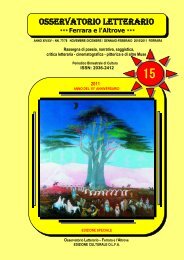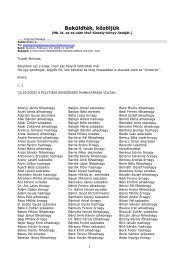OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l'Altrove ANNO XIII â NN ...
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l'Altrove ANNO XIII â NN ...
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l'Altrove ANNO XIII â NN ...
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
potrebbe aver affermato implicitamente una continuitàfra i pittori del Trecento e Aspertini che, vissuto fra il1474 ed il 1552, irruppe sulla scena incurantedell’“umanesimo dolce dei bolognesi” Francesco Franciae Lorenzo Costa, ai quali oppose la sua visione popolaree sanguigna.In un altro saggio del catalogo, Una pazzia…mescolata di tristitia: il ritratto di Amico Aspertinisecondo Vasari, l’autrice, Vera Fortunati, riporta ancoral’accanimento da pubblico ministero con cui lo storicoaveva bollato di follia e incapacità razionale il pittore,rifacendosi ad una malattia mentale che aveva colpitol’Aspertini, limitatamente, però, agli anni 1534-6. Tantoche la Fortunati non esclude che tale durezza potessederivare dalla necessità di eliminare un avversario che,non attenendosi alle regole, era difficilmentecontrollabile e che, per di più, riscuoteva l’approvazionealmeno dei concittadini. In un altro scritto, Antiraphael.Tre contrasti circa la lingua italiana dell’Arte, EugenioRiccomini mostra come Aspertini conoscesse l’opera diRaffaello e quella di Michelangelo. Forse proprio perquesto motivo e non nonostante esso, il pittorebolognese, comprendendo come quell’orizzonte fossedel tutto chiuso da quei nomi, seguì una stradacompletamente diversa, lontana dalla ricerca della purabellezza classica e attenta, invece, a cogliere nellefigure da lui ritratte il realismo espressivo.Fra le numerose chiavi interpretative suggerite daicritici nei loro saggi, abbiamo trovato particolareconsonanza nelle parole di Daniela Scaglietti Kelescianquando, nel saggio Amico Aspertini, protagonista dellacultura artistica bolognese della prima metà delCinquecento, rivendica all’Aspertini “una forteautonomia espressiva, che si palesa principalmentenell’accentuare il suo interesse verso larappresentazione dei sentimenti, sull’onda delleinnovative interpretazioni della psicologia umana cheLeonardo andava conducendo”. Assecondando proprioquest’ottica, abbiamo adottato un’opera che, a torto,potrebbe passare quasi inosservata fra le pur nonnumerose altre rimasteci del pittore, La sacra famiglia.Ad un primo sguardo istintivo e libero da connotazionicritico/storiche, la tela sembra negare l’assunto stessoimplicito nel nome e pare, semmai, riallacciarsipsicologicamente e, se ci è concesso,etimologicamente, al nome di battesimo del suo autore.Di sacro non ha quasi nulla, infatti, a differenzadell’affresco frammentario dallo stesso titolo, presentestabilmente nella Pinacoteca.Là vediamo, infatti, una Madonna in atteggiamentoorante, collo sguardo conscio del grande compitoaffidatole e in adorazione non del suo bambino, madella sacra figura che egli incarna; qua abbiamo unamadre piena di premure e tenerezza verso il figliolettoche sfiora amorevolmente e che la ricambia, quasirapito. Alla figura ‘assente’ di San Giuseppe, relegato –nell’affresco della Pinacoteca – in un sonno che loestrania dalla sacralità dell’evento, di cui lui non haparte alcuna, si contrappone qui un San Giuseppe chepartecipa eticamente ed emotivamente della gioia e delsenso di tenerezza che pervadono il quadro. La manosinistra con cui egli stringe il bastone, più che rivelarci ilclassico bisogno d’appoggio, ci suggerisce e cicomunica lo stesso fremito emotivo che scorre nei suoiocchi, in ‘laica’ adorazione del bambino. I colori, densima morbidi, accentuano questa sensazione di calorefamigliare. Al sacro ci rimandano le aureole e la piccolarappresentazione, in alto a sinistra, della Fuga in Egitto,che, però, proprio per questo, sembra quasi una cosaaltra, tale che non debba turbare la gioiosa centralitàdell’umana vicenda che ci viene raffigurata.In mostra non si sarà certo mancato di ammirareopere che non possono sfuggire all’attenzione di unpubblico attento: La “Pietà” della Cappella Garganelli inSan Petronio; la “Madonna col Bambino e i Santi Lucia,Nicola di Bari e Agostino” ritratti insieme con alcunecommittenti che paiono impegnate in unaconversazione. La tempera su tela è proveniente dallachiesa di San Martino, là allocata in un’ala del transetto.Notevole, ancora, “Madonna col Bambino in gloria e isanti Giorgio, Giuseppe, Giovanni Evangelista eSebastiano” gentilmente prestato dal Museo Nazionaledi Villa Guinigi in Lucca. Un particolare di quest’ultimoquadro è stato utilizzato a simbolo della mostra.A Bologna si possono vedere ulteriori opere di AmicoAspertini presso la Basilica di San Petronio : unadeposizione nella lunetta del portale destro in cui lefigure del Niccodemo con Cristo sono contorniate dadue statue opera del Tribolo e del Seccadenari; leStorie di San Petronio nelle ante del vecchio organo.Presso la chiesa di San Martino, nel primo altare subitoa sinistra, appena entrati, una Deposizione.Nell’Oratorio di Santa Cecilia, in via Zamboni, alcunidegli affreschi che raffigurano le Storie della Santa. AMinerbio, poi, si può finalmente ammirare il ciclocompleto di raffigurazioni a tema mitologico, dato cherecentemente è stato scoperto e restaurato anchel’ultimo prezioso tassello nella Sala di Marte della RoccaIsolani.Dei due poli comparativi proposti nel titolo dellamostra, abbiamo già accennato a Raffaello. Molto piùincisivo è il raffronto con Dürer – presente a Bolognaagl’inizi del Cinquecento- con gli incisori tedeschi e lapittura fiamminga. Ancora il Longhi, infatti, definìAspertini il Cranach bolognese.Se non potrà essere negato che l’anticonformismo diAspertini abbia dato luogo a opere certamenteeccentriche, bisognerà tener conto di come questa suacaratteristica non fosse frutto di limitatezza d’orizzontio, peggio, d’incapacità di mestiere, ma, invece fosse ilprodotto di una strada intrapresa con cognizione dicausa.En. Vi.– Conselice (Ra) –OGGETTO MISTERIOSO...Focus, novembre2008, p. 123Sopra sull’immagineun lettore anonimodomanda: A chideve rivolgersi persapere che cosa siaquesto oggettomisterioso trovato iun mercatino dell’antiquariato.104<strong>OSSERVATORIO</strong> <strong>LETTERARIO</strong> <strong>Ferrara</strong> e l’Altrove <strong>A<strong>NN</strong>O</strong> <strong>XIII</strong> – <strong>NN</strong>. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 2009