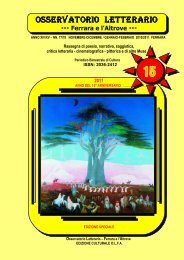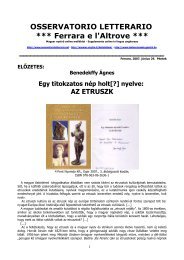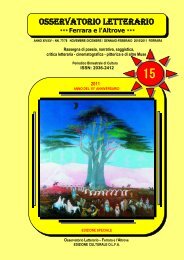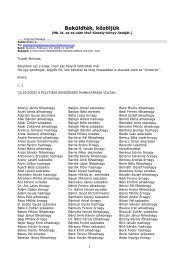gloria eterna, anche se, egli esercitò un’influenzaconsiderevole sulla politica di Sigismondo diLussemburgo agli inizi del XV secolo per far usciredall’ombra che ancor oggi lo nasconde sia nella storiad’Italia che di quella d’Ungheria.L’talianista ungherese, Florio Banfi negli anni ’30-’40del Novecento, più di tutti ne esalta il genio militare; lodefinisce «un eroe antiturco, insostituibile figura dellasua epoca – ma anche sottolineo – un antesignano delRinascimento […] che ha introdotto in Ungheria ilculto del genio italiano [e] che per un secolo ha influitosulla stessa vita spirituale magiara.» Filippo Scolari nonfu infatti soltanto un genio nel campo militare e unaccorto politico ediplomatico, maanche un patronodelle arti e unfondatore dichiese, monasteri,ospedali e castelli.La Dr.ssa GizellaNémeth tra lealtre dice nella suarelazione al convegnotenuto in Udinedal 7 all’8 novembre2002, intitolataFilippoScolari, un esempiodi condottieroe mecenate allacorte di Sigismondodi Lussemburgo:«…era nato nel 1369 a Tizza-no, nei dintorni diFirenze; apparte-neva a una nobile famiglia ghibellinadecaduta che discendeva dal casato dei Buondelmonti.Abile come si era rivelato fin da bambino nel far diconto, Filippo fu affidato all’età di tredici anni almercante fiorentino Luca del Pecchia, il quale esercitavala professione in Ungheria, come moltissimi altriartigiani e imprenditori toscani dell’epoca. Il giovaneFilippo, notato dal tesoriere del re Miklós Kanizsai,cliente di Luca del Pecchia, venne affidato al serviziodell’arcivescovo di Esztergom, János Kanizsai. Mal’abilità di conto dello Scolari attirò anche l’attenzionedello stesso re Sigismondo di Lussemburgo, che loassunse alla sua corte nominandolo nel 1401governatore delle miniere di sale [sókamaraispán] (magià nel novembre del 1399 Filippo dirigeva le miniered’oro di Körmöcbánya, oggi Bánska Kremnica inSlovacchia) e nel 1407-08 addirittura sommo tesoriere.In breve tempo Filippo divenne uno dei più fidati eintimi consiglieri del re e sali molto rapidamente nellascala sociale ungherese. Filippo fu ispán (da cui deriva ilsuo soprannome ‘Spano’), cioè governatore dellecontee di Temes, Csanád, Keve, Krassó, Arad e Fejér;nel 1408-1409 fu anche bano di Szörény. Esercitavainoltre una notevole influenza sull’episcopato di Várad esull’arcivescovado di Kalocsa, in genere diretti oamministrati da parenti o amici e delle cui renditepoteva usufruire personalmente nei periodi di sedevacante. Per dare un’idea della rapida scalata di FilippoScolari alle più alte cariche del regno si pensi che già il29 ottobre 1402 occupava il quarantottesimo posto tra i110 “praelati, barones, nobiles, proceres” che,accompagnarono il re Sigismondo a Pozsony (oggiBratislava in Slovacchia odierna) in occasione dellastipula del contratto che designava il duca d’AustriaAlberto IV erede di Sigismondo al trono magiaro,mentre lo troviamo già al nono posto nell’elenco deimembri dell’Ordine del Drago, fondato dal sovrano edalla regina Barbara di Cilli nel 1408 dopo la vittoriosacampagna di Bosnia. In effetti, nel 1408 Filippo Scolariè già tra i quattro-cinque grandi dignitari del Regnod’Ungheria. Egli non fu soltanto un abile amministratoree uomo politico, ma soprattutto un eccellentecondottiero militare: le sue diciotto o ventitre vittoriosecampagne militari contro i Turchi lo avrebbero resofamoso anche in Italia, tant’è che divenne uno deiprincipali modelli di capitano, fiorentino; prova ne è ilsuo ritratto in atteggiamento spavaldo, con le bracciatese, le gambe divaricate, l’armatura da torneo, laspada arcuata sopra le ginocchia: il capolavoro diAndrea del Castagno (v. l’immagine a sinistra, fonte:Internet) che secondo Mario Salmi ispirò il David delPollaiolo, il San Michele del Perugino e il San Giorgio delDonatelle. Filippo non fu invece fortunato nelle duecampagne condotte contro gli ussiti nel 1420 e 1422,mentre le sue campagne militari in Italia, anche sepraticamente vittoriose, hanno dato adito a qualchesospetto di tradimento e corruzione.Filippo fu anche un ricco proprietario terriero: ebbepossessi in diversi comitati ungheresi, molti dei qualiperò erano in comproprietà con la moglie BorbálaOzorai e col fratello Manco, che lo aveva seguito inUngheria. Ma fu il villaggio di Ozora, portategli in dotedalla moglie Borbála, a divenire la residenza ufficiale diFilippo, che appunto da Ozora avrebbe preso il nomecon cui si faceva chiamare e con cui è ancora oggiricordato in Ungheria. A Ozora Filippo fece costruireattorno al 1416 uno splendido castello, oggicompletamente ristrutturato e trasformato, che avevaperò più i requisiti di un palazzo cittadino che di unafortezza di campagna, come si usava a quei tempi inUngheria. Anzi, il dongione ricordava molto da vicinoproprio i palazzi italiani, ben noti al suo proprietario; lemura invece evidenziavano lo stile tardogoticointernazionale, tipico degli altri simili fabbricati dellaprima metà del XV secolo. Nell’edificio principale c’eraanche una cappella dedicata a San Filippo e a SantaBarbara, in onore ai proprietari. Insomma si trattava diun fabbricato molto più evoluto rispetto a quelli coevi.Molto probabilmente il progetto del castello è operadell’architetto italiano Manette Ammannatini, ilprotagonista della Novella del Grasso Legnaiuolo cheverosimilmente fu sul posto invitato da Filippo adirigerne i lavori.Filippo Scolari fu mecenate, prodigo elemosiniere efinanziatore di opere civili e religiose, anche se uno deisuoi biografi, l’Anonimo fiorentino, esageraattribuendogli la costruzione di ben 180 cappelle, chearricchì a proprie spese anche degli arredi e deiparamenti sacri. Nel 1418 chiese al papa Martino V ilpermesso per la fondazione di un monastero diosservanti francescani a Ozora, già abitabile nel 1423.Secondo Jacopo di Poggio e Domenico Mellini, Filippofinanziò la costruzione dell’ospedale di Santa Elisabettaa Lippa (oggi Lipova, in Romania), che nel 1426 era già60<strong>OSSERVATORIO</strong> <strong>LETTERARIO</strong> <strong>Ferrara</strong> e l’Altrove <strong>A<strong>NN</strong>O</strong> <strong>XIII</strong> – <strong>NN</strong>. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 2009
pronto e abbellito con gli affreschi di Masolino daPanicale, che sembra abbia appunto frequentato lacorte di Filippo e il suo castello di Ozora.È verosimile quindi che Masolino abbia ritrattoFilippo, il quale è stato riconosciuto in un personaggiocon la barba bianca e un cappello a colbacco dipinto nelBanchetto di Erode, l’incantevole affresco del pittore diPanicale eseguito su commissione del cardinale Brandache si trova nel battistero di Castiglione Olona. Questaipotesi è stata sostenuta da Diego Sant’Ambrogio eappoggiata dallo stesso Florio Banfi, mentre JolánBalogh ha riconosciuto Filippo Scolari nell’ospite piùgiovane rappresentato nella stessa scena delbanchetto: il giovane ha i capelli e i baffi come il Filipporitratto dal Castagno, ma è sprovvisto di barba; nellafigura del giovane Florio Banfi ha invece individuatoJános Hunyadi, il padre di Mattia Corvino. Per contro, lastessa Balogh e Maria Lucia Eika Wakayama hannoriconosciuto nel vecchio con la barba biancal’imperatore Sigismondo di Lussemburgo.Nell’individuazione dei personaggi raffigurati daMasolino nell’affresco di Castiglione Olona sia DiegoSant’Ambrogio che Florio Banfi erano partiti dalpresupposto secondo cui le fogge degli abiti deipersonaggi dell’affresco ricordano nelle vestaglie azimarra e nei copricapi di pelo i costumi ungheresi coevie dal fatto che il paesaggio di montagna riprodotto alcentro della scena di Erode ed Erodiade è molto simile aquello raffigurato nella veduta della città di Veszprém,pure attribuito a Masolino, che si può ammirare nelpalazzo del cardinale Branda di Castiglione Olona.Dunque, nell’esecuzione degli affreschi di CastiglioneOlona Masolino deve essersi lasciato suggestionare eispirare dai ricordi del suo soggiorno ungherese allecorti dello Scolari e del cardinale Branda.Il cardinale Branda, nato nel borgo di Castiglionenel 1350, aveva iniziato la carriera; ecclesiastica comevescovo di Piacenza sotto il papa Bonifacio IX dopoessersi laureato a Pavia in diritto canonico e civile. Nelluglio del 1410 aveva conosciuto a Bologna lo Scolari,con cui non tardò a entrare in amicizia; e grazie proprioall’intercessione dello ‘Spano’ presso il nuovo papaGiovanni X<strong>XIII</strong>, il Branda ottenne l’incarico di legatopontificio in Ungheria, insieme con un mandato diriforma volto alla costruzione di nuove chiese neiterritori di confine con l’impero turco e alla fondazionedi uno ‘Studium generale’ a Óbuda con finalitàantiussite. Il cardinale Branda, entrato anche nellegrazie del re Sigismondo che aveva fatto aderire alpartito del papa Giovanni X<strong>XIII</strong>, amministrò primal’arcivescovado di Kalocsa, poi quello di Sirmio, quindifu nominato ispán della contea ecclesiastica diVeszprém; a Buda si fece anche costruire uno splendidopalazzo. Servì Sigismondo come diplomaticonegoziando la pace tra il re d’Ungheria e quello diPolonia ed esercitò un ruolo importante nellanegoziazione della tregua di Castellutto in Friuli, del1413 tra l’Ungheria e la Repubblica di Venezia. Everosimile che il cardinale Branda Castiglione sia statoun valido collaboratore dello Scolari nell’attuazione delsuo programma di fondazione di chiese e istituzionireligiose, dal momento che lo stesso Masolino come si èdetto lavorò sia per lo Scolari a Lippa e moltoprobabilmente a Ozora che per il cardinale a CastiglioneOlona. Filippo aveva quindi invitato alla sua cortediversi artisti fiorentini perché amava l’arte, e inparticolare l’arte italiana, e perché senz’altro volevacontribuire allo sviluppo culturale della sua patriad’adozione, l’Ungheria. Fu inoltre in contatto e collaboròcon insigni uomini di cultura e umanisti: oltre al BrandaCastiglione, conobbe anche Poggio Bracciolini, il padredel suo biografo Jacopo, con cui s’incontrò a costanzanel 1415, durante i lavori del concilio.Nel 1425 fece costruire una cappella aSzékesfehérvár accanto a quella dei re d’Ungheria, chescelse come luogo di sepoltura. Finanziò anche lacostruzione di opere militari come la fortezza di Orsovasul Danubio e di opere di utilità pubblica come unacquedotto che doveva portare l’acqua dal lago Balatonad Ozora. Infine, con l’eredità ricevuta dal fratelloMatteo e dal cugino Andrea, vescovo di Várad, finanziòla costruzione dell’Oratorio degli Scolari agli Angeli,“acciocché qualche monumento e ricordo delle cose suefabbricato appresso a’ discendenti nella patriarestasse”. Anche Andrea Scolari fu un grandemecenate, che continuò a Várad l’attività culturale deisuoi predecessori del XIV secolo. Conosciamo moltedelle sue fondazioni proprio sulla base del suotestamento: fece costruire una cappella di famiglia, chefu pronta nel 1422;. Arricchì una cappella vicino aVárad per i frati paolini, cui lasciò un arazzo su cui èdipinta la storia di Santa Apollonia; lasciò un’ingentesomma di denaro per l’altare della chiesa paolina diSanta Apollonia, nonché 400 fiorini per la ricostruzionedella chiesa di S. Michele. Infine fece costruire unnuovo altare per la cattedrale di Várad. Tutto è andatoperò perduto, tranne la lapide sulla sua tomba cheesiste ancora.L’Oratorio, noto anche come la Rotonda delBrunelleschi, sarebbe dovuto diventare una delle piùsingolari costruzioni architettoniche di Firenze: “untempio bizzarissimo – scrive il Vasari – vicino alla chiesadegli Agnoli, non finito altrimenti, ma condotto fino amezzo, d’una fabbrica in otto facce”; il suo progetto erastato addirittura affidato al grande Filippo Brunelleschi.Sarebbe stato il capolavoro del Brunelleschi. A ognimodo, la costruzione è la più antica a pianta centraledel Rinascimento: si tratterebbe dunque di unmonumento non indifferente alla storia dell’arte. Ilprogetto – come detto – non fu però realizzato perchénel frattempo Firenze aveva dichiarato guerra a Luccaed era stata quindi costretta a usare i soldi ricevuti perla costruzione dell’edificio per scopi di guerra.L’Oratorio, i cui lavori ebbero effettivamente inizio dopoil 1434, doveva ricalcare il tipo di costruzioni classicoromane:doveva essere una costruzione rinascimentalea pianta centrale, con la cupola, anziché rotonda comequella del Pantheon di Roma, ottagonale come quelladel Duomo di Firenze. Anche la bellezza dei materialiimpiegati richiamava la semplicità delle costruzionigreco-romane. L’Oratorio venne però innalzato fino alcornicione, quindi fu lasciato in completo abbandono,tant’è che venne chiamato il ‘Castellaccio’, dando così ilnome alla via dove oggi sorge il monumento,finalmente completato e, oggi, adibito a sede delCentro Linguistico dell’Università di Firenze.Filippo Scolari morì a Lippa, nel Banato, il 27dicembre 1426, dopo aver appena concluso la sua<strong>OSSERVATORIO</strong> <strong>LETTERARIO</strong> <strong>Ferrara</strong> e l’Altrove <strong>A<strong>NN</strong>O</strong> <strong>XIII</strong> – <strong>NN</strong>. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 200961
- Page 1:
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l
- Page 4 and 5:
esclamativo o dubitativo, dall'uso
- Page 7 and 8:
dove il passo dell’uomosi confond
- Page 10 and 11: leggere il biglietto. Lo sfilai dal
- Page 13 and 14: fiducia dei due vecchi coniugi. Sol
- Page 15 and 16: e illumina i mali dei mortipasqua v
- Page 17 and 18: Végtelen imádság lett az életü
- Page 19 and 20: István Monok*QUESTIONI APERTE NELL
- Page 21 and 22: Szamosközy, tranne il curriculum d
- Page 23 and 24: confronto armato con il potere degl
- Page 25 and 26: 45 A. MIKÓ, Mathias Corvinus - Mat
- Page 27 and 28: assolutamente vincolante e univoca
- Page 29 and 30: esperienziale che, indubbiamente, n
- Page 31 and 32: Emerge un tardo ottocento più prop
- Page 33 and 34: limita all’analisi stilistica del
- Page 35 and 36: Ecco un brano del Poema della Croce
- Page 37 and 38: e proprie trappole disseminate sia
- Page 39 and 40: Poi Mater Fabula raccontò che i ri
- Page 41 and 42: TRADURRE - TRADIRE - INTERPRETARE -
- Page 43 and 44: fájdalmat hallotta dobogni a mellk
- Page 45 and 46: Mozart zenéje behatolt az ereibe,
- Page 47 and 48: che scendonoper le tempieil mare de
- Page 49 and 50: MILLENNIUM TERTIUM, Opera eseguita
- Page 51 and 52: panchine sotto i pergolati e nei pa
- Page 53 and 54: cielo che infiamma di azzurro il mo
- Page 55 and 56: quello dei Caracciolo. Gli ultimi a
- Page 57 and 58: anti-ungheresi. La religione predom
- Page 59: (1378-1388, 1411-1415), Re d’Ungh
- Page 63 and 64: dell’epoca (Poggio Bracciolini, L
- Page 65 and 66: Guarino da Verona, la cui scuola di
- Page 67 and 68: icompensa — perché venissero res
- Page 69 and 70: http://www.osservatorioletterario.n
- Page 71 and 72: del Segre, mentre le tendenze più
- Page 73 and 74: in qualche nuovo modo”. Quel “n
- Page 75 and 76: calcolare, pena il tocco delle sue
- Page 77 and 78: 1909 (in collaborazione con G. Vail
- Page 79 and 80: ventre/ rabbia e umiliazione,/ dall
- Page 81 and 82: Petrocchi applica lo stesso process
- Page 83 and 84: Questo intermezzo intorno all’ess
- Page 85 and 86: sono rispettivamente quella di Giul
- Page 87 and 88: cercare di mantenerlo quanto più p
- Page 89 and 90: versione di Quasimodo, unica nel su
- Page 91 and 92: in parte nel Basso Medioevo, lo si
- Page 93 and 94: numerica potrebbe essere qui la Mon
- Page 95 and 96: miniera nel mondo, localizzata prop
- Page 97 and 98: veda Kersten[46]. Mosè alla fine d
- Page 99 and 100: MENZIONI SPECIALI:BALASTIERA# 186by
- Page 101 and 102: «sforzo», di un «impegno»: spes
- Page 103 and 104: Ritratti, storie, percorsiScrittori
- Page 105 and 106: Il lettore in questione sicuramente
- Page 107 and 108: dall'uno all'altro dio o semidio, c
- Page 109 and 110: modello bronzeo inscritto, che fung
- Page 111 and 112:
William Hawking, il fisico britanni
- Page 113 and 114:
(vincitori: Silvana Aurilia - Napol
- Page 115 and 116:
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l
- Page 117 and 118:
APPENDICE/FÜGGELÉK____Rubrica del
- Page 119 and 120:
érnem csak egyszer? Sosem adatott.
- Page 121 and 122:
ajzott szerelmesek enyhülést kerg
- Page 123 and 124:
kis ironikus árnyalatot éreztem k
- Page 125 and 126:
volt, amikor egyszerre három láb
- Page 127 and 128:
hagysz itt bennünket? Meddig bírj
- Page 129 and 130:
diplomát kapván, az állam által
- Page 131 and 132:
tapasztalták meg. Azokban az élm
- Page 133 and 134:
szőr a hátunkon. Sajnos nem volt
- Page 135 and 136:
Most pedig következzenek a felvét
- Page 137 and 138:
Nos, induljunk tovább, mert van m
- Page 139 and 140:
számítógépes tájékoztató út
- Page 141 and 142:
idézné: A szkíták valaha igen b
- Page 143 and 144:
Mindenesetre a megnevezett kutatók
- Page 145 and 146:
A maga egészében különös szell
- Page 147 and 148:
E gondolatokkal foglalkozva eszembe
- Page 149 and 150:
látható titokzatos tárgy, amelye
- Page 151 and 152:
HASZNOS HÍREKtéged ígért a vár
- Page 153 and 154:
az említett munkáidról a híreid
- Page 155 and 156:
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l