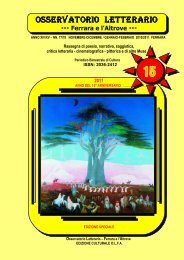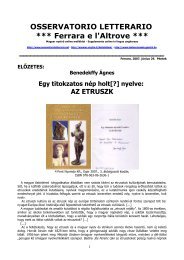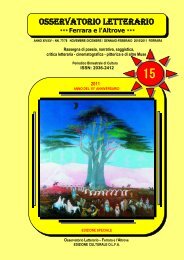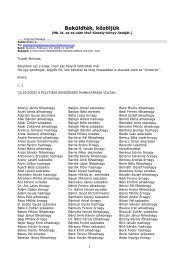seconda delle circostanze, momenti di intimaintrospezione con momenti di descrittivismo pittorico”(p.209). Un giudizio positivo quindi quello di Petrocchi,che inoltre sottolinea come Napolitano sia riuscito arimanere fedele non solo al lirismo dell’operashakespeariana in generale, ma anche al lavoroinnovativo di Oliver e, allo stesso tempo, a dare allaversione italiana spessore e soprattutto scorrevolezza.Doveroso, perché spesso ignorato, è il soffermarsi diPetrocchi sulla figura del doppiatore in generale e suGino Cervi in particolare, il quale fu attore di teatro etelevisione e doppiatore di Oliver per l’Hamlet. Agiudizio di Petrocchi, il lavoro di Napolitano hapermesso a Cervi di evitare ciò che succedeva a moltidoppiatori del periodo postbellico, il cui lavoro eradivenuto meccanico e spersonalizzato.Il quarto capitolo chiude la seconda parte e il libro. Inesso Petrocchi riporta preziosi informazioni riguardantila vita e il background culturale e letterario in cui simuoveva Napolitano che fu scrittore, giornalista,corrispondente estero e traduttore. L’esperienza delconflitto bellico assieme a quelle letterarie,giornalistiche e personali sembrano aver acuito in modoparticolare la sensibilità di Napolitano riguardo atematiche care al personaggio di Amleto: il travagliointeriore, l’indecisione e le atrocità di cui gli uomini sirendono capaci. Il filo rosso che sembra quindi unire letre tipologie traduttive in analisi è riassuntoi nelcommento conclusivo di Petrocchi. In esso l’autriceafferma che, nel rimanere fedele all’originale, ognitraduttore, ‘incoscientemente opera alla luce del propriostream of consciousness’ (p.214) lasciando la sua firmaindelebile sul testo tradotto.Di indubbio valore dal punto di vista metodologicoper il suo rigore e coerenza espositiva, questo librodimostra ciò che sembra spesso essere dimenticato, ecioè che il traduttore è un essere umano che, in quantotale, viene influenzato della società e cultura in cui vivee opera. Il traduttore è capace di creare un testod’arrivo conservando la bellezza stilistica e letteraria diquello di partenza. Ad ogni modo, il testo d’arrivo èsempre il risultato di un processo su cui agisconomolteplici fattori e la sua analisi descrittiva ci consente,come si è visto, una sua profonda comprensione.Inoltre, essa ci fa capire quanto di umano e creativo viè nel tradurre, purtroppo declassato spesso a purolavoro meccanico.© Dr. Margherita DoreinTRAlinea 2005 [online] http://www.intralinea.it/OSSERVAZIONE SULLA TRADUZIONEBemerkung zum Übersetzen di Martin Heidegger HölderlinsHymne ‘Der Ister’, Klostermann, Frankfurt a. M., pp. 74-76Chi decide e come si decide intorno all’esattezza diuna “traduzione”? La nostra conoscenza del significatodelle parole di una lingua straniera ce la “procuriamo”dal “dizionario”. Tuttavia ci dimentichiamo troppo infretta che le indicazioni di un dizionario riposanogeneralmente già su un’interpretazione anteriore deicontesti linguistici, dai quali sono tratti le singole paroleed i loro usi. Un dizionario fornirà nella maggior partedei casi un’esatta indicazione sul significato delleparole, ma non garantisce ancora, attraverso taleesattezza, una visione perspicua [Einsicht] della veritàdi ciò che la parola significa e può significare, nelmomento in cui incominciamo ad investigare il dominioessenziale [Wesensbereich] nominato nella parola. Un“dizionario” può fornire indicazioni utili allacomprensione delle parole, ma non è maisemplicemente e a priori un’istanza vincolante. Ilrichiamo ad un dizionario rimane pur sempre unrichiamo ad un interpretazione, per lo più difficilmenteafferrabile e nel suo modo e nei suoi limiti, di unalingua. Non appena consideriamo il linguaggioesclusivamente come mezzo di comunicazione, allora ildizionario, concepito per la tecnica della circolazione edello scambio, è “senz’altro” “a posto” e vincolante. Invista, al contrario, dello spirito istoriale[geschichtlichen] di una lingua nella sua totalità, adogni dizionario manca l’immediato carattereparadigmatico e vincolante.In realtà ciò vale tuttavia per ogni traduzione, inquanto questa deve necessariamente compiere iltrapasso dallo spirito di una certa lingua in quello diun’altra. Non c’è in generale traduzione nel senso in cuisia possibile o anche solo lecito far combaciare unaparola di una certa lingua con quella di un altra lingua.Tale impossibilità non deve altresì indurre a screditarela traduzione come semplice fallimento. Al contrario: latraduzione può portare alla luce addirittura connessionipresenti nella lingua tradotta, ma non esplicite. Da quiriconosciamo che ogni tradurre dev’essereun’interpretazione. Al tempo stesso però vale anche ilcontrario: ogni interpretazione e tutto ciò che è al suoservizio è un tradurre. Allora la traduzione non si muovesolamente tra due lingue diverse, ma c’è traduzioneall’interno di una stessa lingua. L’interpretazione degliInni di Hölderlin è un tradurre all’interno della nostrastessa lingua tedesca. Lo stesso vale perl’interpretazione che ha per tema la “Critica della ragionpura” di Kant o la “Fenomenologia dello spirito” diHegel. Riconoscere che qui si tratta necessariamente diuna traduzione o di un tradurre comporta laconstatazione che tali “opere” sono richiedonotraduzione per la loro stessa essenza. Tale necessitàperò non è una mancanza, bensì il loro intimo pregio.In altre parole: rientra nell’essenza della lingua di unpopolo storico, al pari una montagna, di degradare perlo più nella pianura e nel piano e contemporaneamentedi innalzarsi con rare vette ad altezze altrimentiirraggiungibili. In mezzo ci sono “le mezze altezze” e i“gradi”. Interpretare come traduzione è sì un rendercomprensibile – tuttavia non come lo intende il sensocomune. Per restare alla nostra immagine, la vetta diun’opera linguistica, poetante o pensante, non puòessere abbassata e l’intera la catena montuosa non puòessere schiacciata sulla pianura della superficialità. Alcontrario: la traduzione deve dislocare sul sentiero chesale verso la vetta. Render comprensibile non deve maisignificare assimilare una poesia o un pensiero ad unqualsivoglia ritenere ed al suo orizzonte dicomprensione; rendere comprensibile significarisvegliare la nostra disponibilità a spezzare edabbandonare la cieca ostinazione del senso comune, sela verità di un’opera deve dischiudersi.82<strong>OSSERVATORIO</strong> <strong>LETTERARIO</strong> <strong>Ferrara</strong> e l’Altrove <strong>A<strong>NN</strong>O</strong> <strong>XIII</strong> – <strong>NN</strong>. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 2009
Questo intermezzo intorno all’essenza dellatraduzione vorrebbe ricordarci che la difficoltà di unatraduzione non è mai meramente tecnica, ma che inessa ne va del rapporto dell’uomo con l’essenza dellaparola e con la dignità della Lingua. Dimmi cosa pensidel tradurre e ti dirò chi sei._________________________NOTA: Questa breve riflessione sulla traduzione è prelevatada un corso che Heidegger tenne all’Università di Friburgo nelsemestre estivo del 1941 (proprio quando sotto il suo nasoimperversa la guerra, lo sterminio nei campi…ma questa èun’altra storia. O, forse, no?!) ed ora pubblicata nel Volume53 della Gesamtausgabe con il titolo Hölderlins Hymne ‘DerIster’. Il corso appartenente al ciclo delle letture che in queglianni Heidegger dedica agli inni di Hölderlin. Heideggerinserice questo breve intermezzo sulla traduzione, quando sitratta di interpretare (e quindi, in qualche modo, di tradurre)il significato del deinon, evocato nel primo canto dell’Antigonedi Sofocle che in una delle tante traduzioni italiane suonacosì:“Molti sono i prodigi (deina)e nulla è più prodigioso (deinoteron)dell’uomo,che varca canutosospinto dal vento tempestoso del sud,fra le ondate penetrandoche infuriano d’attorno,e la più eccelsa fra gli dei,la Terra imperitura infaticabile,consuma volgendo l’aratroanno dopo annoe con l’equina prole rivolta.”(Sofocle: Antigone; Tr. It di Franco Ferrari, BUR, pp. 83-85)Ebbene quello che qui viene reso con “prodigi” (traduzionecanonica) viene “tradotto” da Heidegger con Unheimlich(termine divenuto famoso dopo Freud e che apre ad un“ventaglio di sensi”, direbbe Mallarmé, quasi incontrollabile:spaesamento, perturbante, non-familiare etc.). Proprio pergiustificare questo gesto di violenza filologica, Heidegger sisente costretto ad inframezzare, nel corso della sua letturainterpretazione,questo breve excursus sulla traduzione.Chi ha un pò di esperienza con le letture heideggrianericonosce subito un certo stile nel trattare le questioni intornoal linguaggio. Il linguaggio non è semplicemente unostrumento a nostra disposizione e con cui comunichiamo,esprimiamo etc., ma è essenzialmente “qualcosa” di piùradicale ed originario, nel senso che qui “linguaggio” è il nomedi un’apertura da qui ogni atto di significazione divienepossibile. Il linguaggio, in sostanza, è l’evento che ci faapparire le cose, vincolandoci a dirle nel modo in cui le faapparire. Perché io dica in generale qualcosa, bisogna, comedire, che il linguaggio sia già qui; e questo semplice assioma,forse, lo si dimentica troppo spesso.Traduzione di © Daniele GalassoinTRAlinea 1998 [online] www.intralinea.itRITO E SACRIFICIO NELLE TRADUZIONI DIOTELLOL’importanza delle scelte interpretative del traduttorein rapporto all’individuazione di chiavi di lettura deltesto originaleL’argomento principe di questo articolo vuole esserel’assoluta importanza dell’interpretazione del testo daparte del traduttore. In particolare il contributo sisofferma sull’analisi di tre versioni italiane dell’Othello diShakespeare. La prima ad essere considerata è laversione di Carcano, la seconda è quella di Piccoli el’ultima è la versione di Quasimodo. Partendo dallapossibilità di una lettura in chiave rituale dell’Otelloshakespeariano, evidenziata e delimitata da due parolein particolare, “rite” e “sacrifice”, pronunciaterispettivamente da Desdemona nel primo atto e daOtello nel quinto, passo a considerare la possibilità diquella stessa lettura nelle traduzioni italiane. Ciascuntraduttore traduce un testo in base alla propriainterpretazione e alle proprie scelte personali, sicchéogni traduzione evidenzierià elementi che invece altreversioni non avevano considerato.IntroduzioneChe l’Otello sia la tragedia della gelosia lo hannosottolineato in molti. Sergio Perosa, per esempio,notava come: “L’Othello è una tragedia della gelosia,[…]”. La tragedia della gelosia “perché i personaggiparlano con codici diversi, che si incontrano solo sottomentite spoglie” (Shakespeare, 1990: L); Lessingaffermava che nessun dramma può avere sulle nostrepassioni un’influenza maggiore (in proposito vediShakespeare, 1958) ed anche Guido Ferrando, altrotraduttore shakespeariano, introducendo la versione delPiccoli notava come negare la gelosia di Otello sianegare l’evidenza[1]. Certamente è difficile negare chequesta non sia una delle tematiche che emergono daltesto shakespeariano, tuttavia essa è appunto solo unadelle tante letture che il testo suggerisce, letture che lesuccessive rappresentazioni della tragedia hanno via viamostrato sulla scena, evidenziandone di volta in volta,in maniera assolutamente tangibile, ora un aspetto oraun altro. Uno degli aspetti che con altrettantaprepotenza si fa spazio tra le pagine della tragedia èsicuramente quello della ritualità, ritualità dei gesti edelle parole dei protagonisti, tema questo che percorretutta la tragedia e che emerge dalla superficie del testoparticolarmente in alcuni punti. In effetti, sono stati iprotagonisti stessi del dramma a suggerirmi il titolo diquesto breve intervento:è Desdemona a pronunciareper prima la parola “rito”, quando nel primo atto chiedeal Doge di poter seguire suo marito a Cipro invocando“the rites for which I love him”[2] (Atto I, III, 258) ed èa sua volta invece Otello a parlare di “sacrifice”, quandonell’ultimo atto dice “makest me call what I intend to doa murder, which I thought a sacrifice” (Atto V, II, 64-65). Shakespeare ci fornisce, dunque, una chiave dilettura all’inizio del dramma, che si sviluppa e si riveleràa pieno solo alla fine. Naturalmente dal rito iniziale alsacrificio finale, ci sono ancora tutta una serie dielementi “rituali” che si presentano nella tragedia,elementi che via via si sviluppano e prendono corpofino alla rivelazione finale, suggerita da Otello stesso:non è più un “sacrificio” quello che si sta compiendosulla scena, ma piuttosto un “assassinio”. Il passaggio èdecisivo e si sviluppa per gradi fino alla rivelazioneconclusiva, concretizzandosi nella ripetizione dellaparola “murder”, che compare più volte concentratanelle ultime scene. Sono dunque i protagonisti stessi<strong>OSSERVATORIO</strong> <strong>LETTERARIO</strong> <strong>Ferrara</strong> e l’Altrove <strong>A<strong>NN</strong>O</strong> <strong>XIII</strong> – <strong>NN</strong>. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 200983
- Page 1:
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l
- Page 4 and 5:
esclamativo o dubitativo, dall'uso
- Page 7 and 8:
dove il passo dell’uomosi confond
- Page 10 and 11:
leggere il biglietto. Lo sfilai dal
- Page 13 and 14:
fiducia dei due vecchi coniugi. Sol
- Page 15 and 16:
e illumina i mali dei mortipasqua v
- Page 17 and 18:
Végtelen imádság lett az életü
- Page 19 and 20:
István Monok*QUESTIONI APERTE NELL
- Page 21 and 22:
Szamosközy, tranne il curriculum d
- Page 23 and 24:
confronto armato con il potere degl
- Page 25 and 26:
45 A. MIKÓ, Mathias Corvinus - Mat
- Page 27 and 28:
assolutamente vincolante e univoca
- Page 29 and 30:
esperienziale che, indubbiamente, n
- Page 31 and 32: Emerge un tardo ottocento più prop
- Page 33 and 34: limita all’analisi stilistica del
- Page 35 and 36: Ecco un brano del Poema della Croce
- Page 37 and 38: e proprie trappole disseminate sia
- Page 39 and 40: Poi Mater Fabula raccontò che i ri
- Page 41 and 42: TRADURRE - TRADIRE - INTERPRETARE -
- Page 43 and 44: fájdalmat hallotta dobogni a mellk
- Page 45 and 46: Mozart zenéje behatolt az ereibe,
- Page 47 and 48: che scendonoper le tempieil mare de
- Page 49 and 50: MILLENNIUM TERTIUM, Opera eseguita
- Page 51 and 52: panchine sotto i pergolati e nei pa
- Page 53 and 54: cielo che infiamma di azzurro il mo
- Page 55 and 56: quello dei Caracciolo. Gli ultimi a
- Page 57 and 58: anti-ungheresi. La religione predom
- Page 59 and 60: (1378-1388, 1411-1415), Re d’Ungh
- Page 61 and 62: pronto e abbellito con gli affresch
- Page 63 and 64: dell’epoca (Poggio Bracciolini, L
- Page 65 and 66: Guarino da Verona, la cui scuola di
- Page 67 and 68: icompensa — perché venissero res
- Page 69 and 70: http://www.osservatorioletterario.n
- Page 71 and 72: del Segre, mentre le tendenze più
- Page 73 and 74: in qualche nuovo modo”. Quel “n
- Page 75 and 76: calcolare, pena il tocco delle sue
- Page 77 and 78: 1909 (in collaborazione con G. Vail
- Page 79 and 80: ventre/ rabbia e umiliazione,/ dall
- Page 81: Petrocchi applica lo stesso process
- Page 85 and 86: sono rispettivamente quella di Giul
- Page 87 and 88: cercare di mantenerlo quanto più p
- Page 89 and 90: versione di Quasimodo, unica nel su
- Page 91 and 92: in parte nel Basso Medioevo, lo si
- Page 93 and 94: numerica potrebbe essere qui la Mon
- Page 95 and 96: miniera nel mondo, localizzata prop
- Page 97 and 98: veda Kersten[46]. Mosè alla fine d
- Page 99 and 100: MENZIONI SPECIALI:BALASTIERA# 186by
- Page 101 and 102: «sforzo», di un «impegno»: spes
- Page 103 and 104: Ritratti, storie, percorsiScrittori
- Page 105 and 106: Il lettore in questione sicuramente
- Page 107 and 108: dall'uno all'altro dio o semidio, c
- Page 109 and 110: modello bronzeo inscritto, che fung
- Page 111 and 112: William Hawking, il fisico britanni
- Page 113 and 114: (vincitori: Silvana Aurilia - Napol
- Page 115 and 116: OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l
- Page 117 and 118: APPENDICE/FÜGGELÉK____Rubrica del
- Page 119 and 120: érnem csak egyszer? Sosem adatott.
- Page 121 and 122: ajzott szerelmesek enyhülést kerg
- Page 123 and 124: kis ironikus árnyalatot éreztem k
- Page 125 and 126: volt, amikor egyszerre három láb
- Page 127 and 128: hagysz itt bennünket? Meddig bírj
- Page 129 and 130: diplomát kapván, az állam által
- Page 131 and 132: tapasztalták meg. Azokban az élm
- Page 133 and 134:
szőr a hátunkon. Sajnos nem volt
- Page 135 and 136:
Most pedig következzenek a felvét
- Page 137 and 138:
Nos, induljunk tovább, mert van m
- Page 139 and 140:
számítógépes tájékoztató út
- Page 141 and 142:
idézné: A szkíták valaha igen b
- Page 143 and 144:
Mindenesetre a megnevezett kutatók
- Page 145 and 146:
A maga egészében különös szell
- Page 147 and 148:
E gondolatokkal foglalkozva eszembe
- Page 149 and 150:
látható titokzatos tárgy, amelye
- Page 151 and 152:
HASZNOS HÍREKtéged ígért a vár
- Page 153 and 154:
az említett munkáidról a híreid
- Page 155 and 156:
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l