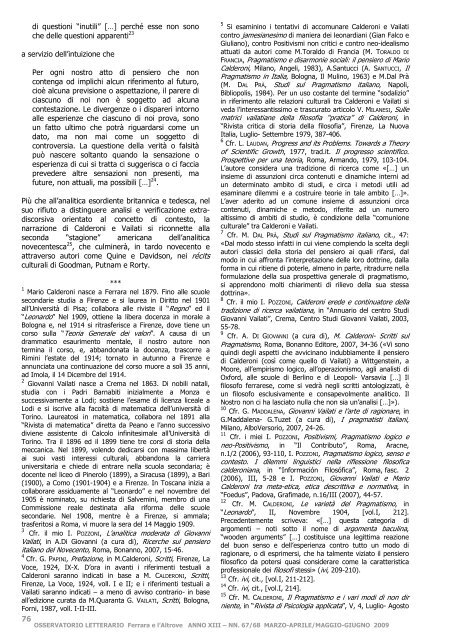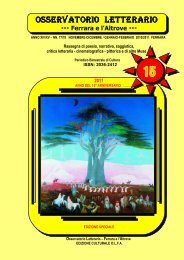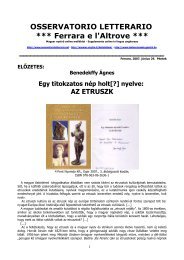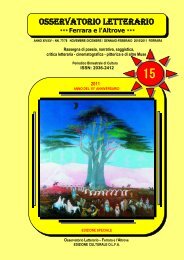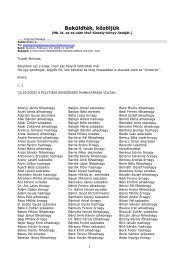di questioni “inutili” […] perché esse non sonoche delle questioni apparenti 23a servizio dell’intuizione chePer ogni nostro atto di pensiero che noncontenga od implichi alcun riferimento al futuro,cioè alcuna previsione o aspettazione, il parere diciascuno di noi non è soggetto ad alcunacontestazione. Le divergenze o i dispareri intornoalle esperienze che ciascuno di noi prova, sonoun fatto ultimo che potrà riguardarsi come undato, ma non mai come un soggetto dicontroversia. La questione della verità o falsitàpuò nascere soltanto quando la sensazione oesperienza di cui si tratta ci suggerisca o ci facciaprevedere altre sensazioni non presenti, mafuture, non attuali, ma possibili […] 24 .Più che all’analitica esordiente britannica e tedesca, nelsuo rifiuto a distinguere analisi e verificazione extradiscorsivaorientato al concetto di contesto, lanarrazione di Calderoni e Vailati si riconnette allaseconda “stagione” americana dell’analiticanovecentesca 25 , che culminerà, in tardo novecento eattraverso autori come Quine e Davidson, nei récitsculturali di Goodman, Putnam e Rorty.***1 Mario Calderoni nasce a <strong>Ferrara</strong> nel 1879. Fino alle scuolesecondarie studia a Firenze e si laurea in Diritto nel 1901all’Università di Pisa; collabora alle riviste il “Regno” ed il“Leonardo” Nel 1909, ottiene la libera docenza in morale aBologna e, nel 1914 si ritrasferisce a Firenze, dove tiene uncorso sulla “Teoria Generale dei valori”. A causa di undrammatico esaurimento mentale, il nostro autore nontermina il corso, e, abbandonata la docenza, trascorre aRimini l’estate del 1914; tornato in autunno a Firenze eannunciata una continuazione del corso muore a soli 35 anni,ad Imola, il 14 Dicembre del 1914.2 Giovanni Vailati nasce a Crema nel 1863. Di nobili natali,studia con i Padri Barnabiti inizialmente a Monza esuccessivamente a Lodi; sostiene l’esame di licenza liceale aLodi e si iscrive alla facoltà di matematica dell’università diTorino. Laureatosi in matematica, collabora nel 1891 alla“Rivista di matematica” diretta da Peano e l’anno successivodiviene assistente di Calcolo infinitesimale all’Università diTorino. Tra il 1896 ed il 1899 tiene tre corsi di storia dellameccanica. Nel 1899, volendo dedicarsi con massima libertàai suoi vasti interessi culturali, abbandona la carrierauniversitaria e chiede di entrare nella scuola secondaria; èdocente nel liceo di Pinerolo (1899), a Siracusa (1899), a Bari(1900), a Como (1901-1904) e a Firenze. In Toscana inizia acollaborare assiduamente al “Leonardo” e nel novembre del1905 è nominato, su richiesta di Salvemini, membro di unaCommissione reale destinata alla riforma delle scuolesecondarie. Nel 1908, mentre è a Firenze, si ammala;trasferitosi a Roma, vi muore la sera del 14 Maggio 1909.3 Cfr. il mio I. POZZONI, L’analitica moderata di GiovanniVailati, in A.Di Giovanni (a cura di), Ricerche sul pensieroitaliano del Novecento, Roma, Bonanno, 2007, 15-46.4Cfr. G. PAPINI, Prefazione, in M.Calderoni, Scritti, Firenze, LaVoce, 1924, IX-X. D’ora in avanti i riferimenti testuali aCalderoni saranno indicati in base a M. CALDERONI, Scritti,Firenze, La Voce, 1924, voll. I e II; e i riferimenti testuali aVailati saranno indicati – a meno di avviso contrario- in baseall’edizione curata da M.Quaranta G. VAILATI, Scritti, Bologna,Forni, 1987, voll. I-II-III.5 Si esaminino i tentativi di accomunare Calderoni e Vailaticontro jamesianesimo di maniera dei leonardiani (Gian Falco eGiuliano), contro Positivismi non critici e contro neo-idealismoattuati da autori come M.Toraldo di Francia (M. TORALDO DIFRANCIA, Pragmatismo e disarmonie sociali: il pensiero di MarioCalderoni, Milano, Angeli, 1983), A.Santucci (A. SANTUCCI, IlPragmatismo in Italia, Bologna, Il Mulino, 1963) e M.Dal Prà(M. DAL PRÀ, Studi sul Pragmatismo italiano, Napoli,Bibliopolis, 1984). Per un uso costante del termine “sodalizio”in riferimento alle relazioni culturali tra Calderoni e Vailati siveda l’interessantissimo e trascurato articolo V. MILANESI, Sullematrici vailatiane della filosofia “pratica” di Calderoni, in“Rivista critica di storia della filosofia”, Firenze, La NuovaItalia, Luglio- Settembre 1979, 387-406.6 Cfr. L. LAUDAN, Progress and its Problems. Towards a Theoryof Scientific Growth, 1977, trad.it. Il progresso scientifico.Prospettive per una teoria, Roma, Armando, 1979, 103-104.L’autore considera una tradizione di ricerca come «[…] uninsieme di assunzioni circa contenuti e dinamiche interni adun determinato ambito di studi, e circa i metodi utili adesaminare dilemmi e a costruire teorie in tale ambito […]».L’aver aderito ad un comune insieme di assunzioni circacontenuti, dinamiche e metodo, riferite ad un numeroaltissimo di ambiti di studio, è condizione della “comunioneculturale” tra Calderoni e Vailati.7 Cfr. M. DAL PRÀ, Studi sul Pragmatismo italiano, cit., 47:«Dal modo stesso infatti in cui viene compiendo la scelta degliautori classici della storia del pensiero ai quali rifarsi, dalmodo in cui affronta l’interpretazione delle loro dottrine, dallaforma in cui ritiene di poterle, almeno in parte, ritradurre nellaformulazione della sua prospettiva generale di pragmatismo,si apprendono molti chiarimenti di rilievo della sua stessadottrina».8 Cfr. il mio I. POZZONI, Calderoni erede e continuatore dellatradizione di ricerca vailatiana, in “Annuario del centro StudiGiovanni Vailati”, Crema, Centro Studi Giovanni Vailati, 2003,55-78.9 Cfr. A. DI GIOVA<strong>NN</strong>I (a cura di), M. Calderoni- Scritti sulPragmatismo, Roma, Bonanno Editore, 2007, 34-36 («Vi sonoquindi degli aspetti che avvicinano indubbiamente il pensierodi Calderoni (così come quello di Vailati) a Wittgenstein, aMoore, all’empirismo logico, all’operazionismo, agli analisti diOxford, alle scuole di Berlino e di Leopoli- Varsavia […] Ilfilosofo ferrarese, come si vedrà negli scritti antologizzati, èun filosofo esclusivamente e consapevolmente analitico. IlNostro non ci ha lasciato nulla che non sia un’analisi […]»).10 Cfr. G. MADDALENA, Giovanni Vailati e l’arte di ragionare, inG.Maddalena- G.Tuzet (a cura di), I pragmatisti italiani,Milano, AlboVersorio, 2007, 24-26.11 Cfr. i miei I. POZZONI, Positivismi, Pragmatismo logico eneo-Positivismo, in “Il Contributo”, Roma, Aracne,n.1/2 (2006), 93-110, I. POZZONI, Pragmatismo logico, senso econtesto. I dilemmi linguistici nella riflessione filosoficacalderoniana, in “Información Filosófica”, Roma, fasc. 2(2006), III, 5-28 e I. POZZONI, Giovanni Vailati e MarioCalderoni tra meta-etica, etica descrittiva e normativa, in“Foedus”, Padova, Grafimade, n.16/III (2007), 44-57.12Cfr. M. CALDERONI, Le varietà del Pragmatismo, in“Leonardo”, II, Novembre 1904, [vol.I, 212].Precedentemente scriveva: «[…] questa categoria diargomenti – noti sotto il nome di argomenta baculina,“wooden arguments” […] costituisce una legittima reazionedel buon senso e dell’esperienza contro tutto un modo diragionare, o di esprimersi, che ha talmente viziato il pensierofilosofico da potersi quasi considerare come la caratteristicaprofessionale dei filosofi stessi» (ivi, 209-210).13 Cfr. ivi, cit., [vol.I, 211-212].14 Cfr. ivi, cit., [vol.I, 214].15 Cfr. M. CALDERONI, Il Pragmatismo e i vari modi di non dirniente, in “Rivista di Psicologia applicata”, V, 4, Luglio- Agosto76<strong>OSSERVATORIO</strong> <strong>LETTERARIO</strong> <strong>Ferrara</strong> e l’Altrove <strong>A<strong>NN</strong>O</strong> <strong>XIII</strong> – <strong>NN</strong>. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 2009
1909 (in collaborazione con G. Vailati), [vol.II, 160]; costuiscrive: «E invece appunto perché il non senso, come l’errore,tendono a rinascere continuamente come le erbe nei campi,che il pensatore e lo scienziato, simili in questo a falciatori,sentono ad intervalli il bisogno di sospendere il loro lavoro perrispianare e riaffilare i loro strumenti che, dal lavoro stesso,sono resi di tanto in tanto incapaci di servir al loro scopo».16 Cfr. M. CALDERONI, Le varietà del Pragmatismo, cit., [vol.I,74-75]. Nel 1909, il nostro autore asserisce «Questi vantaggiconsistono nella possibilità di ottenere dei modi di espressionedelle credenze nostre od altrui, atti più di qualunque altro amettere in luce quali siano le operazioni o le ricerche a cuidovremmo ricorrere per provarle o confutarle; in secondoluogo nella maggior facilità di distinguere, tra le nostreasserzioni, quelle che sono effettivamente capaci di essereprovate o confutate, da quelle che si sottraggono a ognispecie di prova o di confutazione […]» (M. CALDERONI, IlPragmatismo e i vari modi di non dir niente, cit., [vol.II,133]).17 Cfr. M. CALDERONI, Le origini e l’idea fondamentale delPragmatismo, in “Rivista di psicologia applicata”, V, 1,Gennaio- Febbraio 1909 (in collaborazione con G. Vailati),consultino R. RORTY (a cura di), The Linguistic Turn, Chicago,University of Chicago, 1968 e G. BORRADORI (a cura di),Conversazioni americane, Roma-Bari, Laterza, 1992.PRAGMATISMO E DEMOCRAZIA LIRICAPoeti e canzoni del secondo millennioIvan Pozzoni– Monza –Se volessi scegliere un simbolo augurale per l’affacciarsi alnuovo millennio, sceglierei questo: l’agile salto improvviso delpoeta-filosofo che si solleva sulla pesantezza del mondo,dimostrando che la sua gravità contiene il segreto dellaleggerezza, mentre quella che molti credono essere la vitalitàdei tempi, rumorosa, aggressiva, scalpitante e rombante,appartiene al regno della morte, come un cimiterod’automobili arrugginite.(Calvino)[vol.II, 104-105].18Cfr. M. CALDERONI, Variazioni sul Pragmatismo, in“Leonardo”, III, Febbraio 1905, [vol.I, 240].1. Poesia moderna: stato dell’arte19 Cfr. M. CALDERONI, Le origini e l’idea fondamentale delPragmatismo, cit., [vol.II, 123].Da molte voci, nella critica moderna, è evidenziato un20 Cfr. M. CALDERONI, Variazioni sul Pragmatismo, cit., [vol.I, irreversibile meccanismo d’entrata in crisi della cultura239-240]. Calderoni continua, scrivendo: «Vi sono delle umanistica tradizionale, vittima di uno scontro assaipersone che hanno una ripugnanza invincibile a servirsi del duro con i nuovi canoni umanistici connessi a consumotermometro quando hanno la febbre, perché hanno paura di di massa, mercato, ed economia. Poesia, teatro,sapere che temperatura hanno. Chi potrebbe dar loro torto narrativa, tecniche comunicative destituite di mandatosenz’altro? Non sapere può essere un fine altrettanto pratico sociale in stato di remissività confusionale, nell’ultimoquanto sapere. Ora il pragmatismo della prima specie trentennio del secolo scorso sono state messe allepresuppone risolta la questione in favore della consultazionecorde dalla tattica audace ed assimilante dei c.d. massdel termometro; l’altro, quello del Will to Believe, ci dice – emedia (cinema; televisione; musica; internet), e sonopuò essere anche cosa giustissima – che talora il consultare iltermometro fa peggiorare l’ammalato, e che spesso la miglior uscite sconfitte dal terreno di combattimento, senzacondizione per guarire da un male è di non conoscerne la resistenza effettiva, chiudendosi nell’elitarismo,gravità. Qualunque cosa si possa pensare di questi due nell’introversione artistica, nel tecnicismo; in tal senso,pragmatismi, è incontestabile che essi non stanno sullo stesso è molto interessante un’asserzione di Pier Vittoriopiano […]» (ivi, ).Tondelli, secondo cui i moderni versatori «[…] si21 Cfr. ivi, cit., [vol.I, 246-247].nascondono dietro le loro scrivanie e i loro libri.22 Cfr. ivi, cit., [vol.I, 249-250]. Per Calderoni «Esso (il primo Mescolano e affinano parole e rime. Si applaudono frapragmatismo) ci addita il principio da cui i pensatori della loro e si complimentano, premiandosi a vicenda per lecosiddetta “scuola inglese”, il Locke, Hume, Berkeley, etc., venti copie vendute. Hai la sensazione che oltre lafurono quasi istintivamente guidati nelle loro ormai classichecapacità combinatoria, oltre la perfezione formale nonricerche sui “concetti” di sostanza, realtà, materia, causa, etc.esista un’anima». L’esito dello scontro tra vecchia e[…] questi autori si domandarono: che cosa intendiamo direquando adoperiamo tali parole? Quali sono le esperienze che nuova cultura umanistica conduce – a detta di Guidoci aspettiamo quando diciamo che la tal cosa “esiste”, o è la Mazzoni- a due accadimenti radicali, riletti in chiave di“causa” o la “sostanza” di un’altra?».decadence crociata: «moltiplicazione incontrollata degli23 Cfr. M. CALDERONI, Le origini e l’idea fondamentale del scrittori dilettanti» e «marginalità sociale dei poetiPragmatismo, cit., [vol.II, 101]; successivamente, nella affermati». Perché «dilettantismo» e «marginalità»commemorazione di Giovanni Vailati stilata nel 1911, il nostro sono considerati – a torto- indizi di decadenza dellaautore osserva: «Ed in ciò consiste precisamente l’elemento cultura umanistica tradizionale? «Quotidianeità»caratteristico e distintivo del pragmatismo vailatiano di fronte estrema («Bluffando, senza/ assi nella manica,/ o nellead altri sistemi […] Laddove questi muovono guerra ad alcunemutande,/ m’accendo, nella vita,/ a mani giunte,/ comedelle più ardite ipotesi che il pensiero umano abbia tentate, eun cero,/ dalle immagini contorte, / acceso allanon distinguono a sufficienza tra un’ipotesi, per quanto ardita,e un’assurdità, i pragmatisti non riconoscono nessun nostalgia/ di menti morte.») [«Cera bollente»],problema, riguardante un’ipotesi qualsiasi, come nell’accezione riconosciuta da Roberto Galaverni ai versiirrevocabilmente insolubile, e l’insolubilità congenita di certi di Dario Bellezza, rottura romantica della Stiltrennungproblemi attribuiscono soltanto al cattivo modo di porli» (M. antica, rincrudimento dell’Erlebnislyric (Feldt) sono iCALDERONI, Intorno al Pragmatismo di G. Vailati, in “L’Anima”, tratti salienti d’una situazione di dilettantismo metrico,I, 3, Marzo, 1911, [vol.II, 356-357]).caratteristica di inizio secondo millennio, in cui a tutti24 Cfr. M. CALDERONI, Le origini e l’idea fondamentale del diviene accessibile il medium simbolico dellaPragmatismo, cit., [vol.II, 103-104].strutturazione in versi dell’esistenza, idoneo ad25 Per una visione dettagliata in merito alla storia della assicurare ad estesi settori della società moderna unseconda “stagione” americana dell’analitica novecentesca siefficace metodo di comunicazione dell’emozione77<strong>OSSERVATORIO</strong> <strong>LETTERARIO</strong> <strong>Ferrara</strong> e l’Altrove <strong>A<strong>NN</strong>O</strong> <strong>XIII</strong> – <strong>NN</strong>. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 2009
- Page 1:
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l
- Page 4 and 5:
esclamativo o dubitativo, dall'uso
- Page 7 and 8:
dove il passo dell’uomosi confond
- Page 10 and 11:
leggere il biglietto. Lo sfilai dal
- Page 13 and 14:
fiducia dei due vecchi coniugi. Sol
- Page 15 and 16:
e illumina i mali dei mortipasqua v
- Page 17 and 18:
Végtelen imádság lett az életü
- Page 19 and 20:
István Monok*QUESTIONI APERTE NELL
- Page 21 and 22:
Szamosközy, tranne il curriculum d
- Page 23 and 24:
confronto armato con il potere degl
- Page 25 and 26: 45 A. MIKÓ, Mathias Corvinus - Mat
- Page 27 and 28: assolutamente vincolante e univoca
- Page 29 and 30: esperienziale che, indubbiamente, n
- Page 31 and 32: Emerge un tardo ottocento più prop
- Page 33 and 34: limita all’analisi stilistica del
- Page 35 and 36: Ecco un brano del Poema della Croce
- Page 37 and 38: e proprie trappole disseminate sia
- Page 39 and 40: Poi Mater Fabula raccontò che i ri
- Page 41 and 42: TRADURRE - TRADIRE - INTERPRETARE -
- Page 43 and 44: fájdalmat hallotta dobogni a mellk
- Page 45 and 46: Mozart zenéje behatolt az ereibe,
- Page 47 and 48: che scendonoper le tempieil mare de
- Page 49 and 50: MILLENNIUM TERTIUM, Opera eseguita
- Page 51 and 52: panchine sotto i pergolati e nei pa
- Page 53 and 54: cielo che infiamma di azzurro il mo
- Page 55 and 56: quello dei Caracciolo. Gli ultimi a
- Page 57 and 58: anti-ungheresi. La religione predom
- Page 59 and 60: (1378-1388, 1411-1415), Re d’Ungh
- Page 61 and 62: pronto e abbellito con gli affresch
- Page 63 and 64: dell’epoca (Poggio Bracciolini, L
- Page 65 and 66: Guarino da Verona, la cui scuola di
- Page 67 and 68: icompensa — perché venissero res
- Page 69 and 70: http://www.osservatorioletterario.n
- Page 71 and 72: del Segre, mentre le tendenze più
- Page 73 and 74: in qualche nuovo modo”. Quel “n
- Page 75: calcolare, pena il tocco delle sue
- Page 79 and 80: ventre/ rabbia e umiliazione,/ dall
- Page 81 and 82: Petrocchi applica lo stesso process
- Page 83 and 84: Questo intermezzo intorno all’ess
- Page 85 and 86: sono rispettivamente quella di Giul
- Page 87 and 88: cercare di mantenerlo quanto più p
- Page 89 and 90: versione di Quasimodo, unica nel su
- Page 91 and 92: in parte nel Basso Medioevo, lo si
- Page 93 and 94: numerica potrebbe essere qui la Mon
- Page 95 and 96: miniera nel mondo, localizzata prop
- Page 97 and 98: veda Kersten[46]. Mosè alla fine d
- Page 99 and 100: MENZIONI SPECIALI:BALASTIERA# 186by
- Page 101 and 102: «sforzo», di un «impegno»: spes
- Page 103 and 104: Ritratti, storie, percorsiScrittori
- Page 105 and 106: Il lettore in questione sicuramente
- Page 107 and 108: dall'uno all'altro dio o semidio, c
- Page 109 and 110: modello bronzeo inscritto, che fung
- Page 111 and 112: William Hawking, il fisico britanni
- Page 113 and 114: (vincitori: Silvana Aurilia - Napol
- Page 115 and 116: OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l
- Page 117 and 118: APPENDICE/FÜGGELÉK____Rubrica del
- Page 119 and 120: érnem csak egyszer? Sosem adatott.
- Page 121 and 122: ajzott szerelmesek enyhülést kerg
- Page 123 and 124: kis ironikus árnyalatot éreztem k
- Page 125 and 126: volt, amikor egyszerre három láb
- Page 127 and 128:
hagysz itt bennünket? Meddig bírj
- Page 129 and 130:
diplomát kapván, az állam által
- Page 131 and 132:
tapasztalták meg. Azokban az élm
- Page 133 and 134:
szőr a hátunkon. Sajnos nem volt
- Page 135 and 136:
Most pedig következzenek a felvét
- Page 137 and 138:
Nos, induljunk tovább, mert van m
- Page 139 and 140:
számítógépes tájékoztató út
- Page 141 and 142:
idézné: A szkíták valaha igen b
- Page 143 and 144:
Mindenesetre a megnevezett kutatók
- Page 145 and 146:
A maga egészében különös szell
- Page 147 and 148:
E gondolatokkal foglalkozva eszembe
- Page 149 and 150:
látható titokzatos tárgy, amelye
- Page 151 and 152:
HASZNOS HÍREKtéged ígért a vár
- Page 153 and 154:
az említett munkáidról a híreid
- Page 155 and 156:
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l