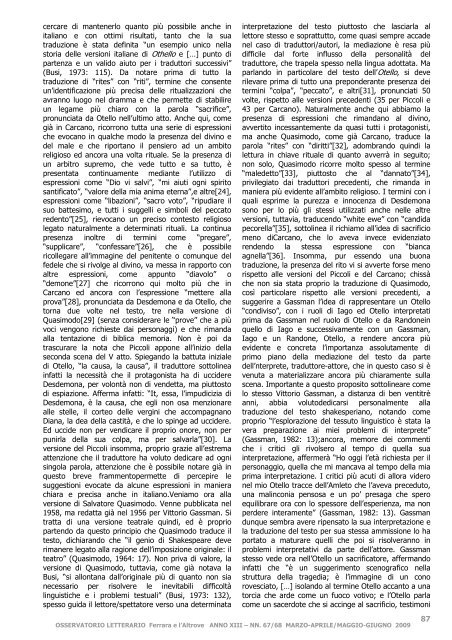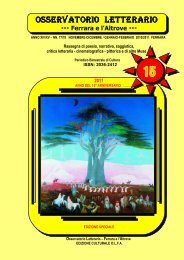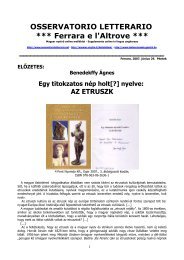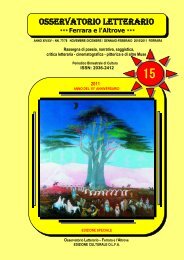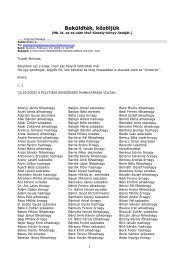allora che Carcano viene ad assumere un ruolo di primopiano: a lui infatti spetterà il difficile compito non solodi tradurre Shakespeare, ma di tradurlo nel rispetto deigusti del pubblico italiano dell’epoca. A tale scopo, purconsiderando principio inderogabile l’assoluto rispettodel testo originale, decide di operare, come diceDuranti, una sorta di “ingentilimento” (1979: 90) deldramma, dovuto essenzialmente all’uso del versoesteso a tutte le parti della tragedia, che viene così adassumere un “tono alto e declamatorio che appunto vaincontro al gusto del pubblico non abituato, anzi ostile,alle continue variazioni di tono ed agli intrecci tracolloquiale ed aulico così caratteristici del linguaggioshakespeariano” (Duranti, 1979: 84). Nonostante talelimite comunque, la traduzione del Carcano si presentaabbastanza vicina al testo originale e pur nonconservando i “riti” iniziali pronunciati da Desdemona,che diventano “diritti”[12], permette comunque dileggere nel dramma la manifestazione del rito e lasuccessiva trasformazione del sacrificio in assassinio,grazie alla presenza di termini ricorrenti anche initaliano e alla resa di “sacrifice” con “sacrificio”appunto. Del resto una lettura in termini di rito dipurificazione dell’uccisione di Desdemona doveva giàessere stata individuata sia da Rossi che da Salvini.Ernesto Rossi infatti, ricordando il successo della suaprima interpretazione di Otello, scriveva: “Il pubblicouscì commosso per la triste fine di Desdemona; mapiangeva alla sciagurata sorte di Otello, ed io procuraidi fare in lui più che l’assassino ed il carnefice,l’inevitabile sacrificatore”[13], mentre Tommaso Salviniaffermava: “Non può sopportare che com’ella ingannò ilpadre, e quindi il marito, possa altri tradire; perciò sierige giudice e giustiziere; è un sacrificio dovuto allasocietà. Egli credesi nell’obbligo di compierlo; e neldiritto di non occultarlo”[14]. Nonostante le parole delRossi, sembra tuttavia che la sua interpretazione diOtello sottolineasse più che altro il lato passionale,barbaro e selvaggio del protagonista, aspettoevidenziato soprattutto nella scena dell’uccisione diDesdemona, dove più che in un “sacrificatore” Otello sitrasforma in un vero e proprio assassino crudele,decidendo non di soffocare, ma piuttosto di strangolarela moglie sulla scena, prolungandone addirittural’agonia e destando l’orrore del pubblico (in proposito siveda Busi, 1973: pp. 175). Salvini invece, fedele allesue dichiarazioni, vede in Otello soprattutto un uomoinnamorato, non un selvaggio, convinto di compiere unvero e proprio sacrificio nell’uccisione di Desdemonainterpretazione che porterà l’attore a modificare alcunescene del dramma, decidendo di non rappresentaresulla scena il soffocamento di Desdemona e dimodificare la scena del suicidio di Otello, che si toglie lavitatagliandosi la gola. Bisogna comunque ricordareche, sebbene entrambi gli attori abbiano sicuramenteutilizzato la versione di Carcano per le lororappresentazioni, i rimaneggiamenti “che gli stessigrandi attori erano andati operando sulle versioni‘grossolane’ del Carcano” (Bragaglia, 1973: 25)dovevano essere molti. Sappiamo inoltre che la censuraintervenne sui testi tradotti con “alcuni ridicoli tagli”(Duranti, 1979: 103). Non solo, Carcano stesso lavorò avari adattamenti e “riduzioni per la scena” nei qualiappunto le esigenze teatrali dovevano essere antepostea quel criterio di assoluto rigore filologico che inveceaveva voluto seguire nelle traduzioni stampate. Comeriferisce Riccardo Duranti, Carcano in pochi annipropose almeno sei riduzioni per la scena a Salvini, ma“purtroppo è difficile giudicare con esattezzal’intervento effettivo del Carcano sui testi perché questiin genere ci sono pervenuti sotto forma di copioni (il piùdelle volte stampati all’estero ed in data moltoposteriore) e cioè dopo che essi erano già statisottoposti ad ulteriori tagli e modifiche a cura degliattori stessi: è perciò pressoché impossibile discernerela paternità dei vari interventi” (Duranti, 1979: 104).Duranti ritiene comunque probabile che “gli attoridelegassero quasi completamente a Carcano il tessutoverbale del testo, […]. In realtà essi si riservavano poidi “eseguire” le indicazioni in esso contenute affidandoil senso alle proprie capacità espressive” (Duranti,1979: 107). Naturalmente sia le interpretazioni di Rossiche quelle di Salvini nascono tutte, comunque, dallostesso dramma e anche se le rappresentazioni che nesono nate sono evidentemente diverse, tuttavia èimportante sottolineare come entrambe rilevino lapresenza del sacrificio/assassinio. In effetti, analizzandola versione del Carcano, si nota la presenza di terminiche ricorrono più volte e che permettono di interpretareil testo in tal senso. Prima di tutto la presenzaossessiva di termini quali “peccato” “colpa”, “reo”,“fallo”[15] , presenti nel testo 43 volte, il ricorso aparole come “confessare”, “contaminare”,“corrompere”[16], atte ad evidenziare la trasformazionedi Desdemona da pura a corrotta. Non solo, ricorronotermini quali “dannato”, “dannarsi”[17], “carnefice” e“assassino”[18]. Il letto di Desdemona inoltre verrà“lavato”[19] col sangue, espressione questa chesuggerisce la necessità dell’espiazione del peccato, perquanto poi Otello non voglia “versarne il sangue”[20],espressione che ancora una volta ci riporta all’idea delsacrificio della “bianca agnella”[21], come era statadefinita inizialmente Desdemona[22]. Da notare poicome nella traduzione di Carcano compaia spesso iltermine “diavolo”[23], seppure non così spesso comenella versione del Piccoli, maggiormente aderenteall’originale. Insomma, malgrado la versificazione, chenaturalmente costringe il traduttore a difficoltà ulterioririspetto a quelle già presentate dal testo, tuttavia èpossibile riconoscere la presenza del rito e del sacrificio,presenza sottolineata anche dal continuo ricorso adespressioni che vorrebbero evocare la presenza deldivino a testimone delle azioni compiute daiprotagonisti.La versione di Raffaello Piccoli, letterale e con il testoa fronte, è del 1934, si inserisce quindi in un contestostorico evidentemente molto diverso da quello in cui eranata la versione del Carcano. Piccoli non ha bisogno di“ingentilire” il dramma, ormai noto al pubblico graziealle successive traduzioni, molte di successo, comequella del Carcano stesso o di Carlo Rusconi, e allerappresentazioni teatrali che si sono avvicendate nelcorso degli anni. La sua non nasce come traduzioneteatrale ed il criterio principale che la informa è quellodella rigorosa aderenza all’originale. La versione ècaratterizzata da un’attenta ricerca della parola; Piccoliinfattivoleva produrre una versione filologica del testo,per questo motivo ritiene di fondamentale importanza86<strong>OSSERVATORIO</strong> <strong>LETTERARIO</strong> <strong>Ferrara</strong> e l’Altrove <strong>A<strong>NN</strong>O</strong> <strong>XIII</strong> – <strong>NN</strong>. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 2009
cercare di mantenerlo quanto più possibile anche initaliano e con ottimi risultati, tanto che la suatraduzione è stata definita “un esempio unico nellastoria delle versioni italiane di Othello e […] punto dipartenza e un valido aiuto per i traduttori successivi”(Busi, 1973: 115). Da notare prima di tutto latraduzione di “rites” con “riti”, termine che consenteun’identificazione più precisa delle ritualizzazioni cheavranno luogo nel dramma e che permette di stabilireun legame più chiaro con la parola “sacrifice”,pronunciata da Otello nell’ultimo atto. Anche qui, comegià in Carcano, ricorrono tutta una serie di espressioniche evocano in qualche modo la presenza del divino edel male e che riportano il pensiero ad un ambitoreligioso ed ancora una volta rituale. Se la presenza diun arbitro supremo, che vede tutto e sa tutto, èpresentata continuamente mediante l’utilizzo diespressioni come “Dio vi salvi”, “mi aiuti ogni spiritosantificato”, “valore della mia anima eterna”,e altre[24],espressioni come “libazioni”, “sacro voto”, “ripudiare ilsuo battesimo, e tutti i suggelli e simboli del peccatoredento”[25], rievocano un preciso contesto religiosolegato naturalmente a determinati rituali. La continuapresenza inoltre di termini come “pregare”,“supplicare”, “confessare”[26], che è possibilericollegare all’immagine del penitente o comunque delfedele che si rivolge al divino, va messa in rapporto conaltre espressioni, come appunto “diavolo” o“demone”[27] che ricorrono qui molto più che inCarcano ed ancora con l’espressione “mettere allaprova”[28], pronunciata da Desdemona e da Otello, chetorna due volte nel testo, tre nella versione diQuasimodo[29] (senza considerare le “prove” che a piùvoci vengono richieste dai personaggi) e che rimandaalla tentazione di biblica memoria. Non è poi datrascurare la nota che Piccoli appone all’inizio dellaseconda scena del V atto. Spiegando la battuta inizialedi Otello, “la causa, la causa”, il traduttore sottolineainfatti la necessità che il protagonista ha di uccidereDesdemona, per volontà non di vendetta, ma piuttostodi espiazione. Afferma infatti: “It, essa, l’impudicizia diDesdemona, è la causa, che egli non osa menzionarealle stelle, il corteo delle vergini che accompagnanoDiana, la dea della castità, e che lo spinge ad uccidere.Ed uccide non per vendicare il proprio onore, non perpunirla della sua colpa, ma per salvarla”[30]. Laversione del Piccoli insomma, proprio grazie all’estremaattenzione che il traduttore ha voluto dedicare ad ognisingola parola, attenzione che è possibile notare già inquesto breve frammentopermette di percepire lesuggestioni evocate da alcune espressioni in manierachiara e precisa anche in italiano.Veniamo ora allaversione di Salvatore Quasimodo. Venne pubblicata nel1958, ma redatta già nel 1956 per Vittorio Gassman. Sitratta di una versione teatrale quindi, ed è propriopartendo da questo principio che Quasimodo traduce iltesto, dichiarando che “il genio di Shakespeare deverimanere legato alla ragione dell’imposizione originale: ilteatro” (Quasimodo, 1964: 17). Non priva di valore, laversione di Quasimodo, tuttavia, come già notava laBusi, “si allontana dall’originale più di quanto non sianecessario per risolvere le inevitabili difficoltàlinguistiche e i problemi testuali” (Busi, 1973: 132),spesso guida il lettore/spettatore verso una determinatainterpretazione del testo piuttosto che lasciarla allettore stesso e soprattutto, come quasi sempre accadenel caso di traduttori/autori, la mediazione è resa piùdifficile dal forte influsso della personalità deltraduttore, che trapela spesso nella lingua adottata. Maparlando in particolare del testo dell’Otello, si deverilevare prima di tutto una preponderante presenza deitermini “colpa”, “peccato”, e altri[31], pronunciati 50volte, rispetto alle versioni precedenti (35 per Piccoli e43 per Carcano). Naturalmente anche qui abbiamo lapresenza di espressioni che rimandano al divino,avvertito incessantemente da quasi tutti i protagonisti,ma anche Quasimodo, come già Carcano, traduce laparola “rites” con “diritti”[32], adombrando quindi lalettura in chiave rituale di quanto avverrà in seguito;non solo, Quasimodo ricorre molto spesso al termine“maledetto”[33], piuttosto che al “dannato”[34],privilegiato dai traduttori precedenti, che rimanda inmaniera più evidente all’ambito religioso. I termini con iquali esprime la purezza e innocenza di Desdemonasono per lo più gli stessi utilizzati anche nelle altreversioni, tuttavia, traducendo “white ewe” con “candidapecorella”[35], sottolinea il richiamo all’idea di sacrificiomeno diCarcano, che lo aveva invece evidenziatorendendo la stessa espressione con “biancaagnella”[36]. Insomma, pur essendo una buonatraduzione, la presenza del rito vi si avverte forse menorispetto alle versioni del Piccoli e del Carcano; chissàche non sia stata proprio la traduzione di Quasimodo,così particolare rispetto alle versioni precedenti, asuggerire a Gassman l’idea di rappresentare un Otello“condiviso”, con i ruoli di Iago ed Otello interpretatiprima da Gassman nel ruolo di Otello e da Randoneinquello di Iago e successivamente con un Gassman,Iago e un Randone, Otello, a rendere ancora piùevidente e concreta l’importanza assolutamente diprimo piano della mediazione del testo da partedell’nterprete, traduttore-attore, che in questo caso si èvenuta a materializzare ancora più chiaramente sullascena. Importante a questo proposito sottolineare comelo stesso Vittorio Gassman, a distanza di ben ventitrèanni, abbia volutodedicarsi personalmente allatraduzione del testo shakesperiano, notando comeproprio “l’esplorazione del tessuto linguistico è stata lavera preparazione ai miei problemi di interprete”(Gassman, 1982: 13);ancora, memore dei commentiche i critici gli rivolsero al tempo di quella suainterpretazione, affermerà “Ho oggi l’età richiesta per ilpersonaggio, quella che mi mancava al tempo della miaprima interpretazione. I critici più acuti di allora videronel mio Otello tracce dell’Amleto che l’aveva preceduto,una malinconia pensosa e un po’ presaga che speroequilibrare ora con lo spessore dell’esperienza, ma nonperdere interamente” (Gassman, 1982: 13). Gassmandunque sembra avere ripensato la sua interpretazione ela traduzione del testo per sua stessa ammissione lo haportato a maturare quelli che poi si risolveranno inproblemi interpretativi da parte dell’attore. Gassmanstesso vede ora nell’Otello un sacrificatore, affermandoinfatti che “è un suggerimento scenografico nellastruttura della tragedia; è l’immagine di un conorovesciato, […] isolando al termine Otello accanto a unatorcia che arde come un fuoco votivo; e l’Otello parlacome un sacerdote che si accinge al sacrificio, testimoni<strong>OSSERVATORIO</strong> <strong>LETTERARIO</strong> <strong>Ferrara</strong> e l’Altrove <strong>A<strong>NN</strong>O</strong> <strong>XIII</strong> – <strong>NN</strong>. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 200987
- Page 1:
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l
- Page 4 and 5:
esclamativo o dubitativo, dall'uso
- Page 7 and 8:
dove il passo dell’uomosi confond
- Page 10 and 11:
leggere il biglietto. Lo sfilai dal
- Page 13 and 14:
fiducia dei due vecchi coniugi. Sol
- Page 15 and 16:
e illumina i mali dei mortipasqua v
- Page 17 and 18:
Végtelen imádság lett az életü
- Page 19 and 20:
István Monok*QUESTIONI APERTE NELL
- Page 21 and 22:
Szamosközy, tranne il curriculum d
- Page 23 and 24:
confronto armato con il potere degl
- Page 25 and 26:
45 A. MIKÓ, Mathias Corvinus - Mat
- Page 27 and 28:
assolutamente vincolante e univoca
- Page 29 and 30:
esperienziale che, indubbiamente, n
- Page 31 and 32:
Emerge un tardo ottocento più prop
- Page 33 and 34:
limita all’analisi stilistica del
- Page 35 and 36: Ecco un brano del Poema della Croce
- Page 37 and 38: e proprie trappole disseminate sia
- Page 39 and 40: Poi Mater Fabula raccontò che i ri
- Page 41 and 42: TRADURRE - TRADIRE - INTERPRETARE -
- Page 43 and 44: fájdalmat hallotta dobogni a mellk
- Page 45 and 46: Mozart zenéje behatolt az ereibe,
- Page 47 and 48: che scendonoper le tempieil mare de
- Page 49 and 50: MILLENNIUM TERTIUM, Opera eseguita
- Page 51 and 52: panchine sotto i pergolati e nei pa
- Page 53 and 54: cielo che infiamma di azzurro il mo
- Page 55 and 56: quello dei Caracciolo. Gli ultimi a
- Page 57 and 58: anti-ungheresi. La religione predom
- Page 59 and 60: (1378-1388, 1411-1415), Re d’Ungh
- Page 61 and 62: pronto e abbellito con gli affresch
- Page 63 and 64: dell’epoca (Poggio Bracciolini, L
- Page 65 and 66: Guarino da Verona, la cui scuola di
- Page 67 and 68: icompensa — perché venissero res
- Page 69 and 70: http://www.osservatorioletterario.n
- Page 71 and 72: del Segre, mentre le tendenze più
- Page 73 and 74: in qualche nuovo modo”. Quel “n
- Page 75 and 76: calcolare, pena il tocco delle sue
- Page 77 and 78: 1909 (in collaborazione con G. Vail
- Page 79 and 80: ventre/ rabbia e umiliazione,/ dall
- Page 81 and 82: Petrocchi applica lo stesso process
- Page 83 and 84: Questo intermezzo intorno all’ess
- Page 85: sono rispettivamente quella di Giul
- Page 89 and 90: versione di Quasimodo, unica nel su
- Page 91 and 92: in parte nel Basso Medioevo, lo si
- Page 93 and 94: numerica potrebbe essere qui la Mon
- Page 95 and 96: miniera nel mondo, localizzata prop
- Page 97 and 98: veda Kersten[46]. Mosè alla fine d
- Page 99 and 100: MENZIONI SPECIALI:BALASTIERA# 186by
- Page 101 and 102: «sforzo», di un «impegno»: spes
- Page 103 and 104: Ritratti, storie, percorsiScrittori
- Page 105 and 106: Il lettore in questione sicuramente
- Page 107 and 108: dall'uno all'altro dio o semidio, c
- Page 109 and 110: modello bronzeo inscritto, che fung
- Page 111 and 112: William Hawking, il fisico britanni
- Page 113 and 114: (vincitori: Silvana Aurilia - Napol
- Page 115 and 116: OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l
- Page 117 and 118: APPENDICE/FÜGGELÉK____Rubrica del
- Page 119 and 120: érnem csak egyszer? Sosem adatott.
- Page 121 and 122: ajzott szerelmesek enyhülést kerg
- Page 123 and 124: kis ironikus árnyalatot éreztem k
- Page 125 and 126: volt, amikor egyszerre három láb
- Page 127 and 128: hagysz itt bennünket? Meddig bírj
- Page 129 and 130: diplomát kapván, az állam által
- Page 131 and 132: tapasztalták meg. Azokban az élm
- Page 133 and 134: szőr a hátunkon. Sajnos nem volt
- Page 135 and 136: Most pedig következzenek a felvét
- Page 137 and 138:
Nos, induljunk tovább, mert van m
- Page 139 and 140:
számítógépes tájékoztató út
- Page 141 and 142:
idézné: A szkíták valaha igen b
- Page 143 and 144:
Mindenesetre a megnevezett kutatók
- Page 145 and 146:
A maga egészében különös szell
- Page 147 and 148:
E gondolatokkal foglalkozva eszembe
- Page 149 and 150:
látható titokzatos tárgy, amelye
- Page 151 and 152:
HASZNOS HÍREKtéged ígért a vár
- Page 153 and 154:
az említett munkáidról a híreid
- Page 155 and 156:
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l