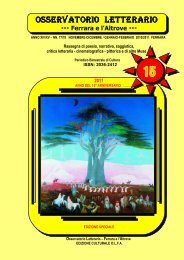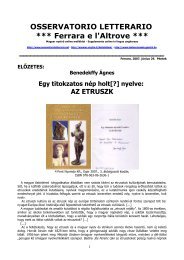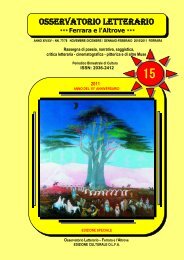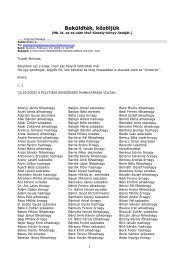fondamentale del poema ma negli accessoricavallereschi”. Essa investe il protagonista, Orlando,che divenuto pazzo è esposto alle risa dei lettori; ilviaggio di Astolfo sull’Ippogrifo nell’altro mondo perrecuperare il senno dell’amico; Angelica che finisce persposare un umile fante, Medoro; la guerra tra Carlo eAgramante; le virtù cavalleresche e “i grandi colpi de’cavalieri, quei grandi colpi ch’essi solo sanno dare”.L’ironia dell’Ariosto è quel sorriso che avvolge tutta lanarrazione, e non vuole significare il distacco del poetadal suo mondo, ma invece proprio l’amore con cui eglilo sente e lo vive. Questa ironia conferisce ilcaratteristico “tono medio” a tutta la multiforme tramadel poema e riduce ogni cosa alle dovute proporzioni.Appunto tramite l’ironia, l’Autore realizza quel suosuperiore equilibrio che gli impedisce sia gli eccessivientusiasmi che i freddi distacchi. Tale atteggiamento èsegno della vitalità del suo genio creatore e della suaserenità interiore. Il Croce ha opportunamente messo inluce la “totalità” dell’ironia ariostesca, nel senso cheessa investe tutto il poema con i suoi personaggi e lesue avventure. Il Bosco istituisce un paragone colManzoni, che ironizza solo su alcuni personaggi del suoromanzo, trasformandoli in macchiette, ma non su altriche rappresentano – nel bene o nel male – il suo idealereligioso od umano. Mentre infatti il Manzoni ha dei fortiideali da far valere, l’Ariosto non ne ha: per lui non c’èun male che sia interamente tale, così come non c’è unbene assoluto, che non sia venato di una qualchedebolezza. Quelli ariosteschi non sono eroi “duri e puri”(com’erano nei poemi medioevali e, ancora in parte, nelBoiardo): sono uomini di questa terra. Mediante l’ironia,l’Ariosto impedisce che ci si affezioni o si odi troppo unpersonaggio piuttosto che un altro; in definitiva, anchegrazie ad una trama quanto mai complessa, impedisceche la nostra attenzione si concentri troppo su uno solodi essi.L’Ariosto è stato qualificato giustamente come “Poetadell’Uomo”, comprendendo in tale definizione laconcezione naturalistica rinascimentale, checomportava una visione dinamica della natura umana,incline alle grandi imprese, costruttrice del propriodestino ma anche consapevole dei propri limiti. Taleconcezione non è quella machiavellica dell’uomo come“golpe” e “lione”, che abbatte qualunque ostacolo perrealizzare ad ogni costo i propri fini. L’uomo ariostesconon è, come vorrebbe il Petronio, un “individualista”sfrenato in cui si sono allentati i legami sociali ed i frenimorali e prevalgono solo gl’impulsi immediati, i motiviistintivi. Se ciò fosse vero, non avrebbe sensol’indeterminatezza dei personaggi né la stessa ironiache pervade l’intero poema, la quale sottolinea appuntola coscienza della comune appartenenza dei varipersonaggi al genere umano, con i loro vizi e le lorovirtù. Questo amore per l’umano rivela, secondo il DeBlasi, un senso di viva socialità nell’Ariosto; rivela altresìil vivo legame che lo salda alle sue creature fantasticheed ai suoi lettori: “uomini tutti, tutti partecipi dellastessa humanitas”.In questa massima attenzione rivolta all’Uomo in tuttele sue terrene manifestazioni consiste lo spirito dell’etàrinascimentale, in cui il poema meravigliosamentes’inserisce, allo stesso modo di un disegno di Leonardo,di una tela di Tiziano, di un dipinto di Raffaello, di unascultura di Michelangelo: in tutte queste opere c’èl’esaltazione dell’armonia del corpo umano – assimilatadall’arte classica – unitamente alla descrizione accuratadi un paesaggio ricco di fascino (ed anche il paesaggioariostesco si presenta affascinante, favoloso,misterioso).Questa armonia, questa serenità nel concepire laNatura e la vita umana in tutti i suoi aspetti (e non soloin quelli epici e grandiosi), si esprimono nel poemaariostesco in un uno stile chiaro e misurato, elegantema non complicato: le ottave, che l’Ambrosini hadefinito l’”Ippogrifo” dell’Ariosto, si succedono fluidel’una dopo l’altra trasportandoci nel suo mondoincantato.L’”Orlando Furioso” ebbe sùbito grande diffusione efortuna, non solo in Italia ma in tutta Europa,soprattutto in Francia e in Spagna (e di converso anchenell’America Latina), dove venne preso a modello per ipoeti del luogo. Galileo Galilei lo esaltò in un celebreconfronto con la “Gerusalemme Liberata” del Tasso, dalui giudicata nettamente inferiore.Tra i primi critici a rilevare la potenza fantastica, lasaggezza, la perfezione stilistica dell’Ariosto fu ungrande poeta a cavallo tra Neoclassicismo eRomanticismo: il Foscolo. La critica romantica,coerentemente con la sua concezione dell’arte comeespressione della società e con la sua visione dellaciviltà rinascimentale come dissoluzione di quellamedioevale, pose attenzione a definire il significatostorico del mondo ariostesco. Per il sommo filosofotedesco G.W.F. Hegel, l’ironia dell’Ariosto, esercitata sulmondo cavalleresco, è il segno del trapasso dalMedioevo al Rinascimento. Il nostro Gioberti riprese,attenuandolo, il giudizio hegeliano, affermando che ilpoema era insieme “la poesia e la satira del Medioevo”e definì l’Ariosto “dipintore ampio, leggiadro, copioso equasi lussureggiante d’immagini e di figure”. Per il DeSanctis, il massimo esponente della critica romantica, ilpoema “è l’epopea del Rinascimento, il tempioconsacrato alla sola divinità riverita ancora in Italia:l’Arte”; opera, pertanto, priva di un contenuto moralema caratterizzata da una “semplicità e chiarezza chetoccano la perfezione”. Secondo la definizionedesanctisiana, l’Ariosto non è semplicemente un poeta,ma il principe degli artisti. La critica positivisticaprodusse contributi filologici ed eruditi, tra i qualiprimeggia il celebre saggio di Pio Rajna sulle fontidell’Orlando Furioso. Un validissimo contributo alrinnovamento delle discussioni critiche sull’Ariosto lodette Benedetto Croce, il quale scrisse su di lui dellepagine mirabili, che in alcuni punti rasentano la purapoesia. Guidato dalla sua concezione esteticaautonomistica dell’arte, il Croce affermò l’affetto delPoeta “per il puro ritmo dell’universo, per la dialetticache è unità, per lo svolgimento che è Armonia”.L’Ariosto è considerato dunque nelle pagine crocianecome il Poeta dell’”Armonia Cosmica”, che si realizzamediante il tono medio dell’ironia, che è la più intimaessenza della sua grande poesia. Nell’orbita delleconclusioni crociane – che all’epoca suscitarono vivacidiscussioni – si posero illustri critici quali il Momigliano,l’Ambrosini, il Raniolo. Un impegno a storicizzare ilmondo ariostesco si ritrova invece nelle pagine delSapegno, del Binni, del Caretti, del Ramat, del Piromalli,70<strong>OSSERVATORIO</strong> <strong>LETTERARIO</strong> <strong>Ferrara</strong> e l’Altrove <strong>A<strong>NN</strong>O</strong> <strong>XIII</strong> – <strong>NN</strong>. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 2009
del Segre, mentre le tendenze più recenti sono andatein direzione di uno “smontaggio” dell’opera in sequenzenarrative e di un’analisi linguistica, strutturale estilistica. Una originale e poetica interpretazione delcapolavoro ariostesco ci è stata infine offerta da ItaloCalvino, il quale sentiva di avere nel Poeta di ReggioEmilia ancor più di un modello, un vero e propriofratello spirituale.Marco Pennone– Savona –PREPARAZIONE CLASSICA E SENSIBILITÀ MO-DERNA NEL PASCOLICome sottolineò lo Jannaco (C. JA<strong>NN</strong>ACO, Da Lyra aiCarmina, la romantica classicità pascoliana, in“Leonardo”, <strong>XIII</strong>, marzo-aprile 1942, pp. 43-52), ilPascoli giunge al Simbolismo partendo da una accuratae perfetta institutio umanistica. E questa solida baseclassica, filtrata attraverso la sua tormentatapersonalità di tardo-romantico, attraverso la suascoperta sensibilità di decadente, viene ad acquistareun aspetto del tutto particolare, assolutamente nuovo.Si può veramente affermare che in lui il moderno“sentire” poetico si incontrò – e reagì – da un lato conquesta complessa e completa formazione classicistica(e con le esigenze di rigore filologico di cui a quei tempila Germania pareva detenere il primato), dall’altro conla concezione sociale e utilitaria che è alla basedell’umanitarismo pascoliano.Il Pascoli critico e studioso, ch’era un tutt’uno colPascoli poeta, rifiutò pertanto un lavoro prettamentefilologico e grammaticale, il che sarebbe stato arido efine a se stesso. Finora nelle scuole – egli scrive – sisono seguìti “commentatori tedeschi o italiani… i qualipresentano gli scrittori greci e latini come complessiproblemi grammaticali e, concediamo, filologici”. In altritermini, così gli scrittori e i poeti risultano morti esepolti, privi d’interesse per i giovani discenti. E invecelui ha un concetto vivo della cultura classica, che può edeve essere civilmente, moralmente e socialmente utile,fuori dalla cerchia di un’arida filologia, tutta conformataa concezioni e a metodi germanici.La sua convinzione è che i filologi tedeschi nonprendano dalle antiche letterature ciò che esse hannodi veramente grande, bello e utile. Il Pascoli, invece,cercava negli antichi autori, con spirito tardo-romantico,le voci della grandezza morale e civile più che laperfezione formale e stilistica; i motivi, a lui ed a noimolto più “vicini”, della commozione lirica, dell’umanitàdistesa, dell’intima spiritualità più che la maestositàdelle concezioni e l’altezza intellettuale: per questo nonpoteva guardare alle antiche letterature con il purointeresse del filologo, ma amava interpretarle unendoalla sua solida preparazione filologica il caldoentusiasmo del poeta. Gli pareva che nelle opereclassiche fosse racchiusa una forza perenne chepotesse e dovesse ancora inondare le menti dei giovaniscolari e confortarli anche nei momenti più difficili, al dilà dello studio. Còmpito del filologo-poeta è quello diriconoscere e tirar fuori questa forza, affinché lo studiodei classici diventi realmente, per dirla con Tucidide, un“possesso perenne”. Ma vediamo come il Pascoliattuava tutto questo.Il “commentario” della lirica latina, premesso alla primaedizione dell’antologia Lyra Romana (Giusti, Livorno,1895) offre agio al poeta romagnolo di tracciare vivaciquadretti della antica vita romana. Siamo intornoall’anno 690 dalla fondazione di Roma: in un gruppettodi giovani che amano la poesia emergono ValerioCatone, Cornelio Nepote, Caio Licinio Macro Calvo,Lucio Manlio Torquato, Asinio Pollione e lo stesso MarcoTullio Cicerone. Fra tutti emerge presto un giovaneveronese, Gaio Valerio Catullo, versatissimo nelle letteregreche, il quale, cessato un dissidio politico, è divenutointimo amico di Calvo (e il Pascoli, nella saturaCatullocalvos, immaginerà una grandiosa tenzonepoetica tra i due amici).La vita di Catullo, il suo tormentato amore per Clodia(cantata col nome di Lesbia), le sue amicizie einimicizie, le sue vivaci battaglie contro i poetucoli deltempo, sono le agili, fresche e movimentate linee delquadro che il Pascoli ci sta delineando. Un’atmosferasimile a quella della vita “bohémienne” di fineOttocento: l’antico tempo sfuma, lentamente, in untempo a noi più vicino.E ora il Pascoli ci trasporta in tribunale, a Roma, dovec’è un oratore famoso (Cicerone) che difende la causadi un poeta (Archia); c’è un praetor dilettante di poesiache giudica (Quinto Tullio Cicerone, fratello del sommooratore) e tutta una folla di uomini cólti che attendecon ansia la sentenza sul poeta e sulla poesia. Ma eccoche parla il grande oratore: egli definisce sanctus ilnome di poeta e commuove Catullo che, in segno diriconoscenza, gli invìa sette versi su di una tavoletta.È questo il modo di affrontare gli autori che il Pascolipreferisce: “La critica è fatta per la letteratura, nonquesta per quella”. Ma qui il poeta è andato oltre. Sullatrama ideale della poesia, ha raccontato diffusamentegli amori di Catullo, le sue delusioni, le sue vittorie e lesue sconfitte amorose, le acerbe vendette, i dolori, iviaggi per dimenticare e, infine, la morte giunta troppopresto a spegnere la fiamma di quella poesia.Il Pascoli non si accosta mai ad un poeta senza inqualche modo sentirlo “fratello”. Come ama Virgilio perquella intima bontà e dolcezza che trasfonde nelle sueopere, come ama Orazio per l’equilibrio e la saggezza,così sente vicino a sé Catullo per quel suo prediligere lepiccole cose, le nugae, i contorni lievi e sfumati, lemomentanee impressioni; per quel suo modo di fare dafanciullo buono troppo spesso ingannato e deluso, chequalche volta romanticamente si compiace, quasi, delsuo dolore. Il Pascoli è soprattutto attratto dallospiccato soggettivismo poetico catulliano: soggettivismoche è per lui il primo requisito di un poeta “moderno”; eanche da una certa affinità di stile: “Egli ama i neòteroi,perché gli assomigliano nell’amore per le belle paroleinsolite e in certe squisitezze metriche e nell’averdovuto superare, con più o meno genialità, lo scoglio diuna cultura esuberante” (A. MOCCHINO, L’arte diGiovanni Pascoli nei carmi latini, Le Monnier, Firenze,1924, p. 25).Come aveva introdotto Catullo nel vivace ambienteletterario romano, così il Pascoli, sempre nel“commentario” di Lyra, introduce Orazio: “Quandoormai pareva che Roma fosse condannata a perire, si<strong>OSSERVATORIO</strong> <strong>LETTERARIO</strong> <strong>Ferrara</strong> e l’Altrove <strong>A<strong>NN</strong>O</strong> <strong>XIII</strong> – <strong>NN</strong>. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 200971
- Page 1:
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l
- Page 4 and 5:
esclamativo o dubitativo, dall'uso
- Page 7 and 8:
dove il passo dell’uomosi confond
- Page 10 and 11:
leggere il biglietto. Lo sfilai dal
- Page 13 and 14:
fiducia dei due vecchi coniugi. Sol
- Page 15 and 16:
e illumina i mali dei mortipasqua v
- Page 17 and 18:
Végtelen imádság lett az életü
- Page 19 and 20: István Monok*QUESTIONI APERTE NELL
- Page 21 and 22: Szamosközy, tranne il curriculum d
- Page 23 and 24: confronto armato con il potere degl
- Page 25 and 26: 45 A. MIKÓ, Mathias Corvinus - Mat
- Page 27 and 28: assolutamente vincolante e univoca
- Page 29 and 30: esperienziale che, indubbiamente, n
- Page 31 and 32: Emerge un tardo ottocento più prop
- Page 33 and 34: limita all’analisi stilistica del
- Page 35 and 36: Ecco un brano del Poema della Croce
- Page 37 and 38: e proprie trappole disseminate sia
- Page 39 and 40: Poi Mater Fabula raccontò che i ri
- Page 41 and 42: TRADURRE - TRADIRE - INTERPRETARE -
- Page 43 and 44: fájdalmat hallotta dobogni a mellk
- Page 45 and 46: Mozart zenéje behatolt az ereibe,
- Page 47 and 48: che scendonoper le tempieil mare de
- Page 49 and 50: MILLENNIUM TERTIUM, Opera eseguita
- Page 51 and 52: panchine sotto i pergolati e nei pa
- Page 53 and 54: cielo che infiamma di azzurro il mo
- Page 55 and 56: quello dei Caracciolo. Gli ultimi a
- Page 57 and 58: anti-ungheresi. La religione predom
- Page 59 and 60: (1378-1388, 1411-1415), Re d’Ungh
- Page 61 and 62: pronto e abbellito con gli affresch
- Page 63 and 64: dell’epoca (Poggio Bracciolini, L
- Page 65 and 66: Guarino da Verona, la cui scuola di
- Page 67 and 68: icompensa — perché venissero res
- Page 69: http://www.osservatorioletterario.n
- Page 73 and 74: in qualche nuovo modo”. Quel “n
- Page 75 and 76: calcolare, pena il tocco delle sue
- Page 77 and 78: 1909 (in collaborazione con G. Vail
- Page 79 and 80: ventre/ rabbia e umiliazione,/ dall
- Page 81 and 82: Petrocchi applica lo stesso process
- Page 83 and 84: Questo intermezzo intorno all’ess
- Page 85 and 86: sono rispettivamente quella di Giul
- Page 87 and 88: cercare di mantenerlo quanto più p
- Page 89 and 90: versione di Quasimodo, unica nel su
- Page 91 and 92: in parte nel Basso Medioevo, lo si
- Page 93 and 94: numerica potrebbe essere qui la Mon
- Page 95 and 96: miniera nel mondo, localizzata prop
- Page 97 and 98: veda Kersten[46]. Mosè alla fine d
- Page 99 and 100: MENZIONI SPECIALI:BALASTIERA# 186by
- Page 101 and 102: «sforzo», di un «impegno»: spes
- Page 103 and 104: Ritratti, storie, percorsiScrittori
- Page 105 and 106: Il lettore in questione sicuramente
- Page 107 and 108: dall'uno all'altro dio o semidio, c
- Page 109 and 110: modello bronzeo inscritto, che fung
- Page 111 and 112: William Hawking, il fisico britanni
- Page 113 and 114: (vincitori: Silvana Aurilia - Napol
- Page 115 and 116: OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l
- Page 117 and 118: APPENDICE/FÜGGELÉK____Rubrica del
- Page 119 and 120: érnem csak egyszer? Sosem adatott.
- Page 121 and 122:
ajzott szerelmesek enyhülést kerg
- Page 123 and 124:
kis ironikus árnyalatot éreztem k
- Page 125 and 126:
volt, amikor egyszerre három láb
- Page 127 and 128:
hagysz itt bennünket? Meddig bírj
- Page 129 and 130:
diplomát kapván, az állam által
- Page 131 and 132:
tapasztalták meg. Azokban az élm
- Page 133 and 134:
szőr a hátunkon. Sajnos nem volt
- Page 135 and 136:
Most pedig következzenek a felvét
- Page 137 and 138:
Nos, induljunk tovább, mert van m
- Page 139 and 140:
számítógépes tájékoztató út
- Page 141 and 142:
idézné: A szkíták valaha igen b
- Page 143 and 144:
Mindenesetre a megnevezett kutatók
- Page 145 and 146:
A maga egészében különös szell
- Page 147 and 148:
E gondolatokkal foglalkozva eszembe
- Page 149 and 150:
látható titokzatos tárgy, amelye
- Page 151 and 152:
HASZNOS HÍREKtéged ígért a vár
- Page 153 and 154:
az említett munkáidról a híreid
- Page 155 and 156:
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l