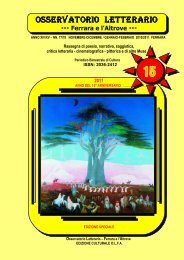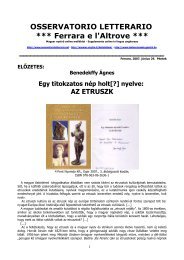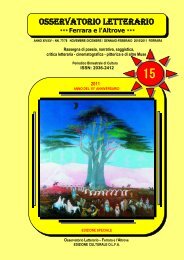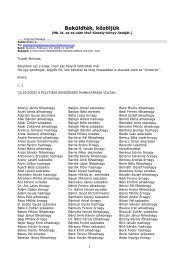della vicenda i “sacerdoti” dei riti che si stannosvolgendo e sono ancora loro i responsabili deltravisamento e del passaggio dal piano spirituale aquello materiale, dalla sacralità del rito sacrificaleall’abiezione dell’omicidio. Ora, che Otello e Desdemonasiano al centro dei riti che si svolgono nel corso deldramma è evidenziato non solo dai loro gesti[3], maanche dalle battute che pronunciano[4] e tuttavia èIago il solo a comprendere l’importanza della funzionerituale per i protagonisti e a sfruttarla per i suoi scopi.Ma cos’è che viene definito rito? Se consultiamol’enciclopedia Treccani, alla voce “rito” si legge:“S’intende per rito la norma dell’azione sacra fissatadalla tradizione religiosa e diretta a intrattenere lacomunicazione tra un individuo o un gruppo umano e ladivinità. Il rito è nato, in origine, da un gestospontaneo che ha accompagnato l’esplosione di undesiderio […] e che una volta sperimentato efficace, siripete fedelmente affinché l’effetto si riproduca ancora”e continua offrendo una classificazione dei diversi riti.Interessante è la distinzione riportata tra riti “magici” e“religiosità”. Tali riti “non si distinguono per lamaterialità del gesto, ma per lo spirito che informal’operatore del rito, in quanto il mago intendecostringere per interesse suo proprio o dei suoi clienti,e quindi per un fine privato, le potenze a cui si dirigeaffinché compiano una data azione, mentre ilsacerdote, anche se adopera mezzi che sembranocostrittivi, li adopera sempre in nome e a vantaggiodella comunità” (Treccani, 1936, vol. XXIX: 466).Consultando un dizionario invece, una delle vociindicate per tale termine definisce il rito “conformitàcon una consuetudine prescritta o una prassi abitualegeneralmente sentita come inderogabile o inevitabile”(Devoto-Oli, 1974: 842). Ora, l’inevitabilità della sorte diDesdemona, come pure quella di Cassio viene sancitaproprio da Iago; è lui che convincerà Roderigo dellamorte “necessaria” di Cassio, “I will show you such anecessity in his death” (Atto IV, II, 241), e sarà semprelui a convincere Otello a compiere il sacrificiopurificatore di Desdemona, “she must die” (Atto V, II,6). Iago dunque si configurerebbe come il vero“sacerdote” delle ritualizzazioni, decretando lui stesso ilcome ed il quando dei sacrifici da compiere ed anzi, inbase alla distinzione precedentemente riportata tra ritimagici e religiosi, Iago si presenterebbe come un“mago”, capace di guidare il potente generale Otello acompiere un delitto per i suoi fini, mentre Otello sipresenterebbe quale sacerdote, che si trova a doversacrificare la sua Desdemona onde impedire che possafare del male al resto della comunità.Tuttavia, se tutti i personaggi della tragedia sembranoavvertire l’inevitabilità degli avvenimenti che lisovrastano, confermata puntualmente dai continuirichiami ad un divino sentito come presente, chestabilisce chi salvare e chi no, come dichiaratoesplicitamente da Cassio (Atto II, III, 102-111), èil soloIago a ritenersi padrone del proprio destino. Iago,infatti, ha “little godliness” (Atto I, II, 9) e ritienel’uomo il solo arbitro del proprio destino, come affermanel famoso discorso del “gardener”, nel I atto. Citroviamo di fronte quindi ad un rito che sembra tale,ma che tale non è. Iago infatti si presenterebbe nellevesti di sacerdote, pur non credendo nella funzionesacrale del rito, Otello quale sacerdote esecutore di unrito di purificazione che non è tale venendo a mancarela “colpa” da espiare, Desdemona quale vittimasacrificale che nega però la sua funzione di vittima,rifiutando appunto ad Otello la responsabilità dellapropria uccisione e Cassio che non solo non vieneucciso, ma che viene ad assumere il ruolo di Otello,come arbitro del destino di Iago. “Men should be whatthey seem” (Atto III, III, 127) diceva Iago, ma “I amnot what I am” (Atto I, I, 65), frase questa che misembra essere la chiave di lettura di tutte le scene cheseguono, caratterizzate appunto dalla contrapposizionecontinua tra ciò che appare e ciò che è,contrapposizione evidenziata già nella presentazione deiprotagonisti, Desdemona ed Otello, una donna ed unuomo, bianco e nero, “paradosso coloristico”, con leparole di Melchiori, “realizzato non tanto come principiomorale, ma come espressione dell’ambiguità e dellapolivalenza della natura umana, nel contesto di quelladialettica tra apparenza e realtà che è il motivocentrale, […] di quasi tutte le tragedie (e le commedie)dello Shakespeare maturo” (Melchiori, 2005: 268).Shakespeare tradotto: l’elemento rituale nelleversioni dell’Otello di Carcano, Piccoli eQuasimodoSe la lettura in chiave rituale del dramma è possibilenell’originale, dovrebbe esserlo anche in traduzione.Tuttavia nella traduzione di un testo, così come nellarappresentazione scenica, il traduttore tenderà asottolineare alcuni aspetti dell’opera in baseall’interpretazione che ne avrà dato, cosicché ognisuccessiva traduzione del dramma sarà uguale ediversa al tempo stesso, illuminando i personaggi dinuova luce e rinnovandoli agli occhi del pubblico.Naturalmente molti sono i traduttori che si sono volutimisurare con il dramma di Otello, dalla primissimaversione italiana di Giustina Renier Michiel del 1798, aquelle di Michele Leoni, Ignazio Valletta, Giulio Carcano,Carlo Rusconi, Luigi Enrico Tettoni nell’ Ottocento,finoalle numerosissime traduzioni del Novecento, Carlo VicoLodovici, Raffaello Piccoli, Paola Ojetti, GiorgioMelchiori, Gabriele Baldini, Agostino Lombardo, solo percitarne alcune. In particolare al fine di condurreun’analisi dei testi tradotti che metta in evidenza ilvalore ed il ruolo di primo piano del traduttore, non solonella resa del dramma in un’altra lingua, ma anche nellasuccessiva interpretazione critica del testo che i lettoripotranno ricavare attraverso la lettura dell’opera“filtrata” dal traduttore, ho scelto di limitare la miaanalisi a tre versioni del testo shakespeariano, prima ditutto per motivi evidenti di spazio ma anche per motividi chiarezza. Il mio scopo in questo breve interventovuole infatti essere quello di mostrare come unatraduzione dell’originale shakespeariano inevitabilmentetenderà ad illuminare o a lasciare in ombra luoghitestuali in funzione di ciò che il traduttore stesso riterràpiù o meno importante sottolineare e la comparazionedi luoghi specifici di soli tre testi permette dievidenziare in maniera immediata e chiara il valoredelle scelte traduttive compiute dal traduttore,mettendo in luce eventuali differenze, che siconfigureranno infine come interpretazioni a loro voltadifferenti del testo originale. Le versioni considerate84<strong>OSSERVATORIO</strong> <strong>LETTERARIO</strong> <strong>Ferrara</strong> e l’Altrove <strong>A<strong>NN</strong>O</strong> <strong>XIII</strong> – <strong>NN</strong>. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 2009
sono rispettivamente quella di Giulio Carcano[5],Raffaele Piccoli[6] e Salvatore Quasimodo[7]. È chiaroche al fine di evidenziare le differenze interpretative ditraduzione la scelta dei testi tradotti poteva essereanche casuale: ogni traduzione infatti saràcaratterizzata da scelte traduttive che saranno propriesolo di quel testo particolare e di nessun altro. Inquesto caso però ho voluto considerare queste treversioni particolari anche e soprattutto perché ritenutetutte e tre, alcune tra le più interessanti traduzionidell’Otello[8] e, in quanto tali, in grado di comunicareanche al pubblico italiano quelle particolarità stilistichee poetiche che rendono l’opera quello che è, nelrispetto sempre e comunque dell’originale inglese.La versione di Carcano si delinea da subito comeparticolarmente degna di nota, non solo perché ritenutauna delle migliori versioni di tutto l’Ottocento, ma ancheperché utilizzata da Ernesto Rossi e Tommaso Salvininelle primissime rappresentazioni italiane di successodel dramma. Entrambi gli attori rappresentarono latragedia nel 1856, a pochi mesi di distanza l’unodall’altro ed entrambi con successo, pur caratterizzandoi propri personaggi in maniera molto diversa. In effetti,fu proprio Ernesto Rossi a commissionare una nuovaversione dell’Otello a Carcano, già nel 1852, decidendotuttavia di rappresentare il dramma solo quattro annidopo. Il motivo di una così lunga attesa va ricercatonon solo nella cura e nell’attenzione che Rossi vollededicare a questa sua interpretazione, ma anche esoprattutto nel rischio al quale l’attore si sottoponevarappresentando un dramma verso cui il pubblico nonera particolarmente ben disposto e nel quale avevafallito il suo stesso maestro, Gustavo Modena. Rossidedicava particolare attenzione alla scelta del testotradotto utilizzato per la messa in scena, è evidenteinfatti che la rappresentazione ne sarebbe stataassolutamente condizionata. Come infatti sottolineaUmberto Eco[9], tradurre èï “dire quasi la stessa cosa”,il filtro del traduttore essendo appunto un elementoassolutamente fondamentale del processo che porteràinfine al testo tradotto. Del resto numerosi studiosi delprocesso di lettura e interpretazione del testo, come adesempio Iser[10] , ma più recentemente anche Sperbere Wilson[11], sottolineano l’importanza proprio dellettore nell’interpretazione del testo. Leggere non èoperazione matematica ed il suo risultato non è certo eimmutabile. Iser, nell’Atto della lettura, evidenzia ilruolo assolutamente unico che il lettore svolgeall’interno del testo. Il lettore infatti si muoverebbe sullapagina scritta attraverso ipotesi che egli stessoformulerà riguardo il possibile significato di un brano,ipotesi che successivamente sarà in grado di accettareo eventualmente rifiutare grazie all’apporto delle nuoveinformazioni che il brano successivo sarà in grado difornire. Anche Sperber e Wilson nella loro RelevanceTheory danno risalto al ruolo del lettore/interprete. Inquesto caso infatti l’interpretazione del testo, orale oscritto che sia, avviene in base alla relevance checiascun interprete attribuisce ad un determinatomessaggio, relevance che in ogni caso verrà attribuitanon solo in base al contesto in cui il messaggio vienerecepito, ma anche in base ad elementi assolutamentesoggettivi caratterizzanti l’interprete stesso, comeesperienze personali, grado di istruzione, ma anchelivello di attenzione prestato in un determinatomomento. Se dunque il lettore interpreta un testo, amaggior ragione il traduttore sarà anch’egli interprete.Il traduttore infatti non solo è ovviamente lettore deltesto di partenza, ma ne è a sua volta anche scrittore:le scelte interpretative che il lettore effettuerà nel corsodella lettura prenderanno infatti corpo nella traduzionestessa, concretizzazione e rappresentazione graficadelle scelte del lettore/traduttore stesso. Studiosi qualiBassnett (2006: 174) e Lefevere (1992: 92) hanno giàsottolineato l’apporto creativo del traduttore nel testotradotto, tanto che Lefevere ha definito qualsiasi formadi riscrittura come vera e propria “manipolazione” (inproposito si veda Lefevere, 2002) e l’analisi dei testitradotti mostra chiaramente fino a che punto taleaffermazione possa essere condivisa. Ora quello che quimi preme sottolineare è appunto il ruolo di primo pianoche l’interpretazione fornita dal traduttore rivestirà poiper quelli che saranno i lettori del testo tradotto. Con leparole di Umberto Eco infatti: “una buona traduzione èsempre un contributo critico alla comprensionedell’opera tradotta. Una traduzione indirizza sempre aun certo tipo di lettura dell’opera, […] perché, se iltraduttore ha negoziato scegliendo di porre attenzionea certi livelli del testo, ha in tal modo automaticamentefocalizzato su quelli l’attenzione del lettore” (Eco, 2003:247). Ora, un attore e per di più attento e scrupolosoquale appunto Ernesto Rossi, non poteva nonriconoscere il valore dell’interpretazione del testo,interpretazione che evidentemente doveva esserecongeniale a quella che lui stesso aveva intenzione dirappresentare concretamente sulla scena; non solo, mada uomo di teatro, non poteva non considerare ledifferenze esistenti tra un testo tradotto per il teatro eduno tradotto per la lettura. È naturale infatti che quelleche per un lettore sono semplici frasi pronunciate da undeterminato personaggio in un determinato momento,per l’attore sono battute che devono essere recitatesulla scena e che devono provocare un determinatoeffetto sul pubblico. Le scelte traduttive quindi inquesto caso saranno orientate anche e soprattutto aquelle che sono le esigenze dell’attore. Queste sono leragioni che spinsero Ernesto Rossi a commissionare unanuova traduzione al Carcano; riteneva infatti chel’Otello andasse recitato in versi sciolti e tuttavia latraduzione di Michele Leoni, già utilizzata dal Modenaper la sua rappresentazione, gli sembravaassolutamente inadeguata, tanto che l’attore attribuiràparte dell’insuccesso di quella prova proprio alla sceltasbagliata della versione. Pertanto, la versione delCarcano, purimportante per il valore letterario, lodiventa ancor più se considerata nel contesto italianodell’epoca. Carcano infatti, amico tra l’altro di GiuseppeVerdi, con il quale ebbe un continuo scambio di opinionidurante la stesura del Macbeth, cui lavorarono entrambinegli stessi anni, era un patriota che aveva partecipatoalle cinque giornate di Milano e che era stato esiliatoper questo, ma soprattutto era un manzoniano,convinto che l’Italia, grazie a Shakespeare, avrebbepotuto creare un teatro nazionale rinnovato e moderno.L’ostilità nei confronti del drammaturgo inglese, che eraandata maturando negli anni grazie soprattuttoall’influente giudizio di Voltaire, continuava però adesercitare pesantemente il suo influsso negativo. Ecco<strong>OSSERVATORIO</strong> <strong>LETTERARIO</strong> <strong>Ferrara</strong> e l’Altrove <strong>A<strong>NN</strong>O</strong> <strong>XIII</strong> – <strong>NN</strong>. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 200985
- Page 1:
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l
- Page 4 and 5:
esclamativo o dubitativo, dall'uso
- Page 7 and 8:
dove il passo dell’uomosi confond
- Page 10 and 11:
leggere il biglietto. Lo sfilai dal
- Page 13 and 14:
fiducia dei due vecchi coniugi. Sol
- Page 15 and 16:
e illumina i mali dei mortipasqua v
- Page 17 and 18:
Végtelen imádság lett az életü
- Page 19 and 20:
István Monok*QUESTIONI APERTE NELL
- Page 21 and 22:
Szamosközy, tranne il curriculum d
- Page 23 and 24:
confronto armato con il potere degl
- Page 25 and 26:
45 A. MIKÓ, Mathias Corvinus - Mat
- Page 27 and 28:
assolutamente vincolante e univoca
- Page 29 and 30:
esperienziale che, indubbiamente, n
- Page 31 and 32:
Emerge un tardo ottocento più prop
- Page 33 and 34: limita all’analisi stilistica del
- Page 35 and 36: Ecco un brano del Poema della Croce
- Page 37 and 38: e proprie trappole disseminate sia
- Page 39 and 40: Poi Mater Fabula raccontò che i ri
- Page 41 and 42: TRADURRE - TRADIRE - INTERPRETARE -
- Page 43 and 44: fájdalmat hallotta dobogni a mellk
- Page 45 and 46: Mozart zenéje behatolt az ereibe,
- Page 47 and 48: che scendonoper le tempieil mare de
- Page 49 and 50: MILLENNIUM TERTIUM, Opera eseguita
- Page 51 and 52: panchine sotto i pergolati e nei pa
- Page 53 and 54: cielo che infiamma di azzurro il mo
- Page 55 and 56: quello dei Caracciolo. Gli ultimi a
- Page 57 and 58: anti-ungheresi. La religione predom
- Page 59 and 60: (1378-1388, 1411-1415), Re d’Ungh
- Page 61 and 62: pronto e abbellito con gli affresch
- Page 63 and 64: dell’epoca (Poggio Bracciolini, L
- Page 65 and 66: Guarino da Verona, la cui scuola di
- Page 67 and 68: icompensa — perché venissero res
- Page 69 and 70: http://www.osservatorioletterario.n
- Page 71 and 72: del Segre, mentre le tendenze più
- Page 73 and 74: in qualche nuovo modo”. Quel “n
- Page 75 and 76: calcolare, pena il tocco delle sue
- Page 77 and 78: 1909 (in collaborazione con G. Vail
- Page 79 and 80: ventre/ rabbia e umiliazione,/ dall
- Page 81 and 82: Petrocchi applica lo stesso process
- Page 83: Questo intermezzo intorno all’ess
- Page 87 and 88: cercare di mantenerlo quanto più p
- Page 89 and 90: versione di Quasimodo, unica nel su
- Page 91 and 92: in parte nel Basso Medioevo, lo si
- Page 93 and 94: numerica potrebbe essere qui la Mon
- Page 95 and 96: miniera nel mondo, localizzata prop
- Page 97 and 98: veda Kersten[46]. Mosè alla fine d
- Page 99 and 100: MENZIONI SPECIALI:BALASTIERA# 186by
- Page 101 and 102: «sforzo», di un «impegno»: spes
- Page 103 and 104: Ritratti, storie, percorsiScrittori
- Page 105 and 106: Il lettore in questione sicuramente
- Page 107 and 108: dall'uno all'altro dio o semidio, c
- Page 109 and 110: modello bronzeo inscritto, che fung
- Page 111 and 112: William Hawking, il fisico britanni
- Page 113 and 114: (vincitori: Silvana Aurilia - Napol
- Page 115 and 116: OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l
- Page 117 and 118: APPENDICE/FÜGGELÉK____Rubrica del
- Page 119 and 120: érnem csak egyszer? Sosem adatott.
- Page 121 and 122: ajzott szerelmesek enyhülést kerg
- Page 123 and 124: kis ironikus árnyalatot éreztem k
- Page 125 and 126: volt, amikor egyszerre három láb
- Page 127 and 128: hagysz itt bennünket? Meddig bírj
- Page 129 and 130: diplomát kapván, az állam által
- Page 131 and 132: tapasztalták meg. Azokban az élm
- Page 133 and 134: szőr a hátunkon. Sajnos nem volt
- Page 135 and 136:
Most pedig következzenek a felvét
- Page 137 and 138:
Nos, induljunk tovább, mert van m
- Page 139 and 140:
számítógépes tájékoztató út
- Page 141 and 142:
idézné: A szkíták valaha igen b
- Page 143 and 144:
Mindenesetre a megnevezett kutatók
- Page 145 and 146:
A maga egészében különös szell
- Page 147 and 148:
E gondolatokkal foglalkozva eszembe
- Page 149 and 150:
látható titokzatos tárgy, amelye
- Page 151 and 152:
HASZNOS HÍREKtéged ígért a vár
- Page 153 and 154:
az említett munkáidról a híreid
- Page 155 and 156:
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l