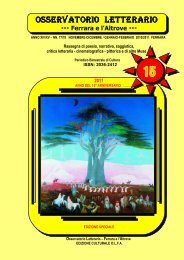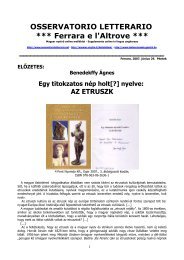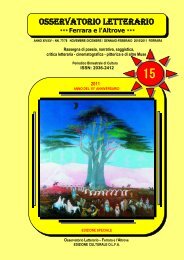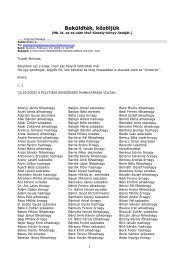esistenza sua e del lettore, il farmakon metrico dellaserenità esistenziale. Con la canzone «Resistendo,mordo» è delineata una sorta di necessità tassativa allaresistenza, nell’asserzione «[…] urgenza […]/ èresistere, resistere/ nella dignità decorosa/ delringhiare/ d’un randagio ferito,/ senza certezze,/ senzasuccessi,/ senza carezze […]»; restano vivi i contornidell’«assassinio morale», effetto di un ostinato nonconformarsi ai valori morali della vita trendy, escaturente dalla tensione tra concorrere e «[…] nonconcorrere,/ con ritmi stolidi,/ all’eccellenza/dell’esistenza […]» [«Roaccutan»]. E’ sommo interessedell’artista resistere, in costante rivolta, evitando, a se ead altri, «assassinii morali», assicurando massimaefficacia alla valenza suturativa del verso, come nellaconclusione della canzone «Eremita»; la «marginalitàsociale dei poeti» - nella condivisione dei destini di umilie sconfitti- è uno stadio necessario del camminodell’artista sulla strada della resistenza contro societàmalate, istituzioni corrotte e diffuso conformismo. Cosasalverà la cultura umanistica tradizionale in declino?«Ma cosa costruiremo,/ collaborando, in via/continuativa, senza/ cantare, senza ballare,/ senzacreare?» [«Pezzi di ricambio»].contesto letterario italiano non era invece ancorapronto al romanzo borghese che si andava sviluppandoin Inghilterra e l’influenza di Fielding si faceva quindisentire principalmente su autori di teatro come Goldonie Chiari. Il processo traduttivo che fece conoscerel’opera fieldinghiana in Italia diviene quindi unstimolante oggetto di analisi. È interessante, adesempio, scoprire che la traduzione del Joseph Andrewsda parte di Giovan Antonio Pedrini (pubblicata sotto lopseudonimo di Nigillo Scamandrio una decina di annidopo l’originale), è indirizzata ad un pubblicoaristocratico, piuttosto che ad un pubblico medio.Tuttavia, ciò non impedisce a quest’opera, secondoPetrocchi, di divenire il tramite per la futura produzioneletteraria di tipo romanzesco in Italia, con interessantispunti stilistici che uniscono il linguaggio teatrale aquello letterario (p.19).In modo più approfondito, il secondo capitolo guida illettore alla comprensione del contesto culturale eletterario in cui si inserisce il lavoro di Pedrini e che,come sostiene Petrocchi, influenza la sua personalità eil suo lavoro di traduttore. Questi era un abate vissutonella Repubblica di Venezia del ‘700 e membrodell’Accademia dell’Arcadia, la quale, sebbeneprincipalmente interessata alla traduzione di testiIvan Pozzoni classici dal latino e dal greco, incitava la traduzione di– Monza – testi filosofici, scientifici, politici e talvolta letterari diorigine francese, inglese e tedesca. Tale apertura allePetrocchi Valeriainfluenze esterne mirava a uno sviluppo linguisticoTIPOLOGIE TRADUTTIVEdell’italiano in grado di creare coesione eCLUEB: Bologna 2004, pp. 224, € 15,00consapevolezza nazionale in un’Italia ancora divisa maaccomunata da un medesimo passato. Non dovrebbeIl libro di Valeria Petrocchi si divide in due parti. Lapertanto sorprendere che la traduzione del Pedrini siaprima parte mira ad uno studio comparato delle unichefortemente influenzata da francesismi e anglicismi chedue traduzioni italiane del Joseph Andrews di Hanrycontribuiscono alla sperimentazione linguistica eFielding da parte di Giovan Antonio Pedrini e Giorgiostilistica all’interno dell’opera, con modifiche al testoMelchiori. La seconda parte analizza la traduzione dellatalvolta rilevanti.trasposizione cinematografica di Alan Dent e SirAl fine di offrire un quadro completo del climaLaurence Oliver dell’opera sheakespeariana Hamlet.socioculturale italiano del diciottesimo secolo, PetrocchiL’approccio metodologico utilizzato viene definitooffre al lettore un’interessante discussione delledall’autrice del libro di tipo ‘psicobiografico’, cioè basatoquestioni politiche e religiose che caratterizzarono ilsull’analisi del periodo storico e socioculturale in cuiperiodo e che ne influenzarono la produzione letteraria.ognuna di queste opere fu portata a termine. È infattiL’autrice spiega, infatti, come i letterati e politici delconvinzione di Petrocchi che questi fattori, insieme atempo sentissero la forte ingerenza delle istituzioni e, inquelli prettamente personali, giochino un ruoloparticolare, quella degli Inquisitori dello Stato nellafondamentale nelle scelte operate dal traduttore (p.11).Repubblica di Venezia (per conto della quale PedriniIn quest’ottica quindi il titolo stesso del libro intendelavorava come ambasciatore) e della Chiesa cattolica,porre l’accento sulle cause contingenti che fanno sì cheche passavano al vaglio i testi prima della loroun testo tradotto si sviluppi e possa essere definitopubblicazione e sui quali potevano imporre la censura.all’interno di una chiara tipologia.Altro fattore rilevante era la forte influenza culturale eIl percorso di analisi delle fonti da parte di Petrocchilinguistica della Francia su molti Paesi europei.si basa sul desiderio di fornire una visione eNonostante in Italia si potesse notare un certo interessecomprensione esaustiva dell’argomento e dei testiper il mondo anglosassone, la maggior parte deitrattati. Pertanto, nella prima parte, l’autrice offre ailetterati rimaneva legata al francese, la lingua francapropri lettori un primo capitolo d’introduzione all’operadel tempo, e alla sua letteratura e cultura illuminista.originaria, il Joseph Andrews di Hanry Fielding.Come precisa Petrocchi, la traduzione francese delPetrocchi ripercorre il periodo sia storico che culturaleJoseph Andrews da parte Pierre-François Guyotin cui l’autore scrive e si sofferma sulla rilevanza diDesfontaines influenza fortemente quella del Pedrini eFielding come uno dei precursori del romanzo sia indiviene un chiaro esempio di tale fenomeno. Ad ogniInghilterra che in tutta Europa. In un periodo di crisi delmodo, ciò non impedisce al Pedrini di discostarseneteatro, il ‘700 inglese vedeva fiorire un nuovo stiletalvolta e usare l’originale inglese come testo diletterario in cui l’opera di Fielding si contraddistinguevapartenza per il proprio lavoro al fine di dargliper il linguaggio vicino a quello parlato e per ilun’impronta personale, che tenta anche di soddisfare lemessaggio sociale e morale che essa intendevaesigenze specifiche del pubblico italiano.trasmettere ai propri lettori. Come spiega l’autrice, il80<strong>OSSERVATORIO</strong> <strong>LETTERARIO</strong> <strong>Ferrara</strong> e l’Altrove <strong>A<strong>NN</strong>O</strong> <strong>XIII</strong> – <strong>NN</strong>. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 2009
Petrocchi applica lo stesso processo metodologico alquarto capitolo che presenta il contesto socioculturaleitaliano in cui vive Giorgio Melchiori, secondo traduttoreitaliano del Joseph Andrews. Da esso si possonocogliere le notevoli differenze che distinguino questoperiodo storico da quello precedentemente discusso eche sembrano essere direttamente connessi con illavoro di Melchiori. In primo luogo, l’Italia della secondametà del Novecento era oramai un Paese unificato conuna precisa identità nazionale e una lingua standard.Altro fattore di particolare interesse è inoltre l’ambienteeditoriale italiano del tempo e il diverso orientamento dialcune case editrici (ad esempio, la Mondadori verso unmercato di massa, la Garzanti verso quellointellettuale). Infine, la figura del traduttore è ormaiben delineata professionalmente e il suo lavoro si basasu precise metodologie, sviluppate con rigorescientifico, e capace di offrire un prodotto che miraall’alfabetizzazione delle masse e alla diffusione dellaletteratura presente e passata.Da questo si passa al quinto capitolo in cui Petrocchisi concentra sulla figura di Melchiori per ricordarnel’educazione accademica e, in particolare, l’influenza diMario Praz sullo sviluppo delle sue innate capacitàtraduttive. Il capitolo è poi arricchito dall’analisi dellavoro di Melchiori che porta Petrocchi a descriverne latipologia traduttiva basata su tre punti fermi: attenzioneal pubblico d’arrivo, conoscenza della personalità elavoro dell’autore del testo di partenza e studio dellalingua di un autore rappresentativo nella culturad’arrivo e contemporaneo all’autore originale.Suggerimenti preziosi questi, a volte dati per scontatianche dagli stessi traduttori se Melchiori stesso sostienedi non aver mai seguito teorie traduttive prestabilite.Alla luce di quanto discusso nei capitoli precedenti,Petrocchi porta avanti un’analisi comparata delle dueversioni italiane del Joseph Andrews, la quale rivelainteressanti differenze tra le due traduzioni e il modo dioperare dei traduttori. Ciò sembra quindi confermarel’ipotesi presentata all’inizio del libro che sostiene cheentrambi i traduttori sono stati influenzati dal periodostorico in cui hanno operato, ma anche da specifichescelte personali. La discussione dei numerosi esempiviene categorizzata e suddivisa in sottosezioni chevanno dalle difficoltà traduttive basate sull’ironia delregistro dei personaggi alle espressioni idiomatiche, dallinguaggio del realismo dell’originale all’umorismotrasmetto creativamente dai nomi dei personaggi. Daciò, Petrocchi conclude che il lavoro di Pedrini èfortemente influenzato dalle scelte fatte dal traduttorefrancese Desfontaines, dl quale saltuariamente siallontana per tradurre direttamente dall’originaleinglese per ragioni di gusto personali (ad esempioquando riproduce il registro della comicità fieldinghianautilizzato per vari personaggi e in particolare perSlipslop). Al contrario, il lavoro di Melchiori dimostraessere il risultato del modus operandi del traduttore. Dauna parte egli riesce a cogliere e a ri-creare l’atmosferadel testo originale, grazie all’utilizzo di terminisettecenteschi; dall’altra, rimane legato al presente, conla prosa fluida dell’italiano del ventesimo secolo.Esempio di una chiara metodologica traduttiva inMelchiori è, secondo Petrocchi, lasciare immutati i nomidei personaggi che in inglese hanno precise valenzesatiriche (ad eccezion fatta di Mrs. Gave-Airs, tradottocon Madama Austerià). Al contrario, Pedrini sceglie ditradurre la maggior parte di questi nomi (Mrs. Gave-Airs diventa Madama Prudenzia), sempre su calcofrancese ma, sfortunatamente, essi non rispecchiano iltentativo del traduttore francese di ri-creare i giochi diparole esistenti nell’originale.Il settimo capitolo l’autrice fa il punto sullecaratteristiche delle due tipologie traduttive analizzate.L’opera di Pedrini, fortemente influenzata dalla prosafrancese e inglese, è il prodotto di una sperimentazionelinguistica che mira allo sviluppo di una prosa italianapiù scorrevole e colloquiale, fino a quel momentopresente solo nei testi teatrali. Melchiori, al contrario,opera a metà del ventesimo secolo e, pur mantenendoil linguaggio settecentesco per ragioni stilistiche,presenta una prosa che riflette una lingua che si èormai sviluppata a pieno.La seconda parte del libro è in linea con la prima.L’analisi e comprensione della la tipologia traduttivasviluppata da Gian Gaspare Napolitano nel tradurre latrasposizione cinematografica dell’Hamlet di Alan Dente Sir Laurence Oliver si basa in primo luogo sulladiscussione dei fattori socioculturali e personali cheoperano sul lavoro del traduttore. Inoltre, si tiene contodelle caratteristiche specifiche del testo sotto analisi,che fonde il linguaggio poetico e lirico del teatroall’immagine filmica. Nel primo capitolo, Petrocchidescrive con rigore di cronaca l’ambiante culturaleitaliano di metà Novecento, periodo in cui il film escenelle sale cinematografiche. Sulla base delle fontiricercate, Petrocchi dimostra come la criticacinematografica sulle testate giornalistiche sembravadimenticare che la versione italiana era un prodottopassato attraverso un processo traduttivo e didoppiaggio. Al contrario, Petrocchi desidera analizzarein che misura il rapporto fra immagine e il testo scrittoabbiamo agito sulla traduzione italiana.Nel secondo e terzo capitolo Petrocchi riflette suquella che chiama la ‘prima’ traduzione, cioè latrasposizione da testo teatrale dell’Hamlet asceneggiatura da parte di Dent e Oliver e influenzata inprimis dal mezzo utilizzato. Ad esempio, la scelta ditagliare delle parti del testo veniva dettata dal bisognodi rientrare nei tempi standard di una proiezionecinematografica e non dal desiderio di modificare osintetizzare il testo. Allo stesso modo, cambiare l’ordinedi alcune scene – come l’incontro di Amleto con il padreprima di quello con Ofelia – era un modo perenfatizzare la relatività delle vicende umane e usare ilvoice-over durante il monologo di Amleto intendevasottolinearne il suo travaglio psicologico interiore.Secondo Petrocchi, la ‘seconda’ traduzione, quella adopera di Napolitano, è naturalmente influenzata dallescelte stilistiche compiute da Dent e Oliver. Tuttavia,Petrocchi dimostra come altri elementi abbiano incisosulle scelte lessicali compiute da Napolitano. Fattoritecnici, come la sincronizzazione labiale, o personali,come l’appartenenza del traduttore al movimentofuturista (per il quale il cinema e la lingua usata in essodovevano essere mezzi di educazione della società) loportano a creare una prosa “pratica, concisa,essenziale, limpida, intensa e vigorosa, linguisticamentericca e opportunamente dosata, capace di alternare, a<strong>OSSERVATORIO</strong> <strong>LETTERARIO</strong> <strong>Ferrara</strong> e l’Altrove <strong>A<strong>NN</strong>O</strong> <strong>XIII</strong> – <strong>NN</strong>. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 200981
- Page 1:
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l
- Page 4 and 5:
esclamativo o dubitativo, dall'uso
- Page 7 and 8:
dove il passo dell’uomosi confond
- Page 10 and 11:
leggere il biglietto. Lo sfilai dal
- Page 13 and 14:
fiducia dei due vecchi coniugi. Sol
- Page 15 and 16:
e illumina i mali dei mortipasqua v
- Page 17 and 18:
Végtelen imádság lett az életü
- Page 19 and 20:
István Monok*QUESTIONI APERTE NELL
- Page 21 and 22:
Szamosközy, tranne il curriculum d
- Page 23 and 24:
confronto armato con il potere degl
- Page 25 and 26:
45 A. MIKÓ, Mathias Corvinus - Mat
- Page 27 and 28:
assolutamente vincolante e univoca
- Page 29 and 30: esperienziale che, indubbiamente, n
- Page 31 and 32: Emerge un tardo ottocento più prop
- Page 33 and 34: limita all’analisi stilistica del
- Page 35 and 36: Ecco un brano del Poema della Croce
- Page 37 and 38: e proprie trappole disseminate sia
- Page 39 and 40: Poi Mater Fabula raccontò che i ri
- Page 41 and 42: TRADURRE - TRADIRE - INTERPRETARE -
- Page 43 and 44: fájdalmat hallotta dobogni a mellk
- Page 45 and 46: Mozart zenéje behatolt az ereibe,
- Page 47 and 48: che scendonoper le tempieil mare de
- Page 49 and 50: MILLENNIUM TERTIUM, Opera eseguita
- Page 51 and 52: panchine sotto i pergolati e nei pa
- Page 53 and 54: cielo che infiamma di azzurro il mo
- Page 55 and 56: quello dei Caracciolo. Gli ultimi a
- Page 57 and 58: anti-ungheresi. La religione predom
- Page 59 and 60: (1378-1388, 1411-1415), Re d’Ungh
- Page 61 and 62: pronto e abbellito con gli affresch
- Page 63 and 64: dell’epoca (Poggio Bracciolini, L
- Page 65 and 66: Guarino da Verona, la cui scuola di
- Page 67 and 68: icompensa — perché venissero res
- Page 69 and 70: http://www.osservatorioletterario.n
- Page 71 and 72: del Segre, mentre le tendenze più
- Page 73 and 74: in qualche nuovo modo”. Quel “n
- Page 75 and 76: calcolare, pena il tocco delle sue
- Page 77 and 78: 1909 (in collaborazione con G. Vail
- Page 79: ventre/ rabbia e umiliazione,/ dall
- Page 83 and 84: Questo intermezzo intorno all’ess
- Page 85 and 86: sono rispettivamente quella di Giul
- Page 87 and 88: cercare di mantenerlo quanto più p
- Page 89 and 90: versione di Quasimodo, unica nel su
- Page 91 and 92: in parte nel Basso Medioevo, lo si
- Page 93 and 94: numerica potrebbe essere qui la Mon
- Page 95 and 96: miniera nel mondo, localizzata prop
- Page 97 and 98: veda Kersten[46]. Mosè alla fine d
- Page 99 and 100: MENZIONI SPECIALI:BALASTIERA# 186by
- Page 101 and 102: «sforzo», di un «impegno»: spes
- Page 103 and 104: Ritratti, storie, percorsiScrittori
- Page 105 and 106: Il lettore in questione sicuramente
- Page 107 and 108: dall'uno all'altro dio o semidio, c
- Page 109 and 110: modello bronzeo inscritto, che fung
- Page 111 and 112: William Hawking, il fisico britanni
- Page 113 and 114: (vincitori: Silvana Aurilia - Napol
- Page 115 and 116: OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l
- Page 117 and 118: APPENDICE/FÜGGELÉK____Rubrica del
- Page 119 and 120: érnem csak egyszer? Sosem adatott.
- Page 121 and 122: ajzott szerelmesek enyhülést kerg
- Page 123 and 124: kis ironikus árnyalatot éreztem k
- Page 125 and 126: volt, amikor egyszerre három láb
- Page 127 and 128: hagysz itt bennünket? Meddig bírj
- Page 129 and 130: diplomát kapván, az állam által
- Page 131 and 132:
tapasztalták meg. Azokban az élm
- Page 133 and 134:
szőr a hátunkon. Sajnos nem volt
- Page 135 and 136:
Most pedig következzenek a felvét
- Page 137 and 138:
Nos, induljunk tovább, mert van m
- Page 139 and 140:
számítógépes tájékoztató út
- Page 141 and 142:
idézné: A szkíták valaha igen b
- Page 143 and 144:
Mindenesetre a megnevezett kutatók
- Page 145 and 146:
A maga egészében különös szell
- Page 147 and 148:
E gondolatokkal foglalkozva eszembe
- Page 149 and 150:
látható titokzatos tárgy, amelye
- Page 151 and 152:
HASZNOS HÍREKtéged ígért a vár
- Page 153 and 154:
az említett munkáidról a híreid
- Page 155 and 156:
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l