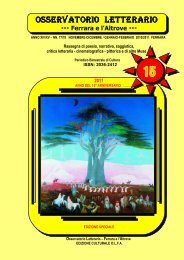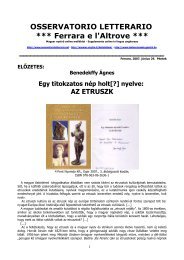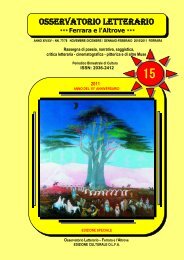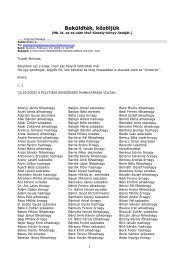ultima battaglia contro i Turchi e, come aveva stabilitoin vita, fu sepolto a Székesfehérvár nella cappella che siera fatto costruire accanto a quella che raccoglieva lespoglie dei re d’Ungheria: una lapide posta sul suosepolcro marmoreo presso l’altare riportava l’iscrizione“Sepulchrum Egregii et Magnifici Domini Filippi deScolaribus de Florencia, Comitis Themesvariensis etOzorae, qui obiit Anno Domini 1426, die XXVII MensisDecembris”. La cappella in cui venne sepolto fudistrutta dai Turchi nel 1543 insieme con la lapidecommemorativa.Filippo Scolari fu quindi senz’altro uno deipersonaggi più importanti della sua epoca: non fu soloun abile generale, un accorto politico e un genialeamministratore, ma anche un patrono delle arti e degliartisti, che ha contribuito a introdurre in Ungheria lacultura rinascimentale italiana e “che – meritaconcludere citando ancora una volta Florio Banfi – quasigrida per suscitare interesse”.Meritano di essere citati anche alcuni umanisti estoriografi italiani alle corti d’Ungheria e di Transilvania,quest’ultima, a quei tempi appartenente all’Ungheriastorica fino al 4 giugno 1920, data del trattato delTrianon. Di loro il Prof. Adriano Papo ha presentatoun’ampia relazione al convegno sopraccitato. Eccoqualche spunto tratto da essa:L’Ungheria è stata il primo paese europeo adaccogliere la cultura rinascimentale italiana, cheraggiunse l’apice del suo splendore nel paesecarpatodanubiano all’epoca dell’ultimo grande renazionale magiaro, Mattia Corvino (1458-90) e di suamoglie Beatrice d’Aragona (v. sulla pag. successiva).Mattia Corvino fu appunto un tipico sovranorinascimentale al pari di molti principi italiani a lui coevi:colto, amante e patrono delle arti, delle lettere e dellescienze, bibliofilo, oltreché grande stratega militare.era divenuta una piccola Firenze con i suoi vescovid’origine toscana Andrea Scolari e Giovanni Milanesi daPrato e il preposto Corrado Cardini. E vescovo di Váradfu anche quel János Vitéz al cui nome èindiscutibilmente legata la fioritura dell’umanesimo inUngheria. János Vitéz, spirito enciclopedico, umanistad’alto profilo, già allievo di Pier Paolo Vergerio al tempodel soggiorno dell’umanista istriano alla corte diSigismondo, incentivò gli studi degli ungheresi in Italia:a esempio, mandò a studiare a <strong>Ferrara</strong> presso Guarinoda Verona suo cugino János Csezmicei, che si sarebbefatto conoscere in tutto il mondo col nome latino diJanus Pannonius (Giano Pannonio). Pier Paolo Vergerio(1370-1444) può invece a ben diritto esserericonosciuto come colui che introdusse l’umanesimo inUngheria: collaborò col Vitéz nella cancelleria regia esembra che il Vitéz stesso ne abbia acquistato labiblioteca, che divenne la prima biblioteca umanistica inUngheria. Il Vergerio fondò anche il primo cenacoloumanistico operante a Buda e il primo in assoluto aessere costituito sul suolo ungherese.Secondo Tibor Kardos, invece, i germidell’umanesimo magiaro possono essere già rintracciatinella letteratura ungherese in lingua latina dei secoli XIe XII; le prime leggende agiografiche e le Ammonizionidi Santo Stefano propagano per l’appunto la dignitashominis, contrapponendo la vita pacifica del popolocristiano all’austerità pagana. Sennonché l’umanesimoungherese si suole far iniziare nel momento in cui laregina Maria d’Angiò diede incarico al venezianoLorenzo de Monacis di scrivere una storia di Carlo diDurazzo. Il primo vero e proprio approccio degliungheresi con l’umanesimo italiano si ebbe invecedurante il viaggio in Italia (1413-14) di Sigismondo diLussemburgo, allorché il re d’Ungheria e allora già redei Romani s’incontrò a Lodi col papa Giovanni X<strong>XIII</strong>per preparare la convocazione del concilio di Costanza.Questo viaggio di Sigismondo in Italia fu diRe Mattia Corvino e Beatrice d’Aragona (Fonti: Op. cit. diLorio Banfi e Domokos Kosáry)Tuttavia, l’umanesimo aveva fatto capolino inUngheria già ai tempi di Maria d’Angiò (1382-95), diSigismondo di Lussemburgo (1387-1437) e di JánosHunyadi (1446-52), il padre di Mattia: la città di Váradfondamentale importanza ai fini del consolidamento deirapporti culturali italo-magiari, perché molti ungheresidel seguito regio conobbero in quest’occasione insignirappresentanti dell’umanesimo italiano, uno su tuttil’aretino Leonardo Bruni, che fu ospite a Piacenza dellacorte del re nel febbraio del 1414. Altrettantoimportante per gli scambi culturali italo-ungheresi fu ilconcilio di Costanza (1414-18), dove i migliori umanisti62<strong>OSSERVATORIO</strong> <strong>LETTERARIO</strong> <strong>Ferrara</strong> e l’Altrove <strong>A<strong>NN</strong>O</strong> <strong>XIII</strong> – <strong>NN</strong>. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 2009
dell’epoca (Poggio Bracciolini, Leonardo Bruni, AntonioLoschi, Pier Paolo Vergerio, Francesco Zabarella,Branda Castiglione e numerosi altri ancora) vennero incontatto con una nutrita delegazione magiara; dopoCostanza numerosi dotti italiani entrarono al servizio diSigismondo e si stabilirono in Ungheria. Oltre alVergerio, troviamo infatti alla sua corte il cardinaleBranda Castiglione (1350-1443) dottore in utroqueiure, incaricato dal papa di fondare un’università aÓbuda, Ambrogio Traversari (1386-1439), monacocamaldolese e grecista, e Francesco Filelfo (1398-1481), che aveva appreso il greco da GiovanniCrisolora, nipote di Manuele, e ne aveva sposata lafiglia Teodora. Non va dimenticata a questo proposito lafigura del fiorentino Filippo Scolari, cugino del vescovodi Várad, già sopra accennato Andrea, che fu sì uneccellente amministratore, politico, diplomatico estratega militare, ma anche un insigne patrono dellearti e instancabile mecenate, che fece venire inUngheria e lavorare al suo servizio artisti comeMasolino da Panicale e Manette Ammannatini, fu incontatto con Poggio Bracciolini, collaborò col cardinaleBranda e legò il proprio nome e il proprio patrimonioalla costruzione d’importanti edifici e operearchitettoniche (un castello a Ozora, un ospedale aLippa, l’Oratorio degli Scolari agli Angeli a Firenze, tantoper citarne alcune).Come detto, la cultura umanistica e rinascimentalegiunse in Ungheria ai fasti della gloria durante lasplendida età corviniana. Nella cancelleria di MattiaCorvino rifiorì l’antica tradizione unnica, cui sirivolgevano gli umanisti magiari come in Italia gliumanisti italiani si rivolgevano alla Roma delle guerrepuniche e a quella imperiale. Mattia Corvino fu salutatoda cortigiani e scrittori come il novello Attila,ovviamente non quello della tradizione latino-cristianapresentato come il flagellum Dei, avido e sanguinario,bensì come quello della tradizione barbarico-germanicache venne per lo più identificato con un monarcapotente, giusto, generoso e benevolo. Il mito di Attila fusfruttato per il rafforzamento del centralismo corvinianoin funzione antimagnatizia. Era stato il protonotaroJános Thuróczy,a denominare Mattia Corvino il ‘secondoAttila’ nella sua Chronica Hungarorum, pubblicata aBrno nel 1488. E l’ascolano Antonio Bonfini (1434-1503), vissuto, egli pure come il Thuróczy alla corte diMattia e infatuato anche lui del grande sovranoungherese, dedicò quasi metà della sua operastoriografica Rerum Hungaricarum Decades quattuorall’epoca corviniana scrivendo nella prefazione cheriporta la dedica al re d’Ungheria e di Boemia VladislaoII Jagellone: “Nam Hunnorum Historiam, quiUngarorum fuere progenitores, a Matthia rege mihidelegatam, et paulo ante eius obitum initam, utconscriberem, ab origineque mundi ad haec usquetempera, quaecumque memoratu digna intercessere,memoriae traderem, iussu tuo factum est “.Antonio Bonfini mette in evidenza nella sua opera laferrea disciplina della famosa ‘Armata Nera’ di re Mattia,e al pari degli altri umanisti alla corte del Corvino s’eraformato un giudizio sull’Ungheria basandosi sullaconsapevolezza che gli ungheresi stessi avevanod’essere il ‘baluardo della cristianità, concetto ch’eranato al tempo dell’invasione mongola, era statocodificato per la prima volta nei documenti dellacancelleria del re magiaro Vladislao I Jagellone (1440-44) e s’era rapidamente diffuso in tutta Europa tramitele lettere papali e gli scritti degli umanisti. Gli umanistiitaliani considerano quindi gli ungheresi come unpopolo guerriero, valoroso e tenace, ne apprezzano levirtù militari, li vedono fieri della loro fama guerriera,messa ormai al servizio della cristianità e della culturaeuropea: tali appaiono negli aneddoti di GaleottoMarzio, nelle considerazioni politiche di AurelioBrandolini Lippo, negli epigrammi di Ugolino da Vieri enelle ‘lodi militari’ di Mattia Corvino di AlessandroCortese e di Ludovico Carbone.In genere, gli umanisti consideravano barbari tutti ipopoli d’Oltralpe; perciò essi si ritenevano investiti dellamissione d’incivilire quei popoli e di temperarel’asprezza della loro vita. Gli ungheresi rappresentavanoperò un’eccezione tra i popoli ‘barbari’ d’Oltralpe; per ilBonfini i magiari s’erano infatti spogliati della loro‘barbarie scitica’ grazie alla gloria acquisita con ladisciplina militare e la conseguente nobiltà. Inoltre nonsi poteva prescindere dagli strettissimi rapportiintercorsi tra l’Ungheria o meglio tra l’antica Pannonia el’Impero Romano e dal fatto che la Transilvania stessaera abitata da genti che parlavano una lingua neolatina.Perciò secondo gli umanisti italiani non dovevameravigliare il fatto che gli ungheresi fossero portatialla cultura.Gli ungheresi identificavano le virtù naturali conquelle cavalleresche, che conferivano all’uomo ‘nobiltà’e quindi ‘umanità’, cioè dignità; per loro infattil’umanesimo era considerato identico alla nobiltà.L’acquisizione della nobiltà veniva interpretata allastregua del risultato d’una selezione sociale, mentre lasua perdita significava la perdita dell’onore edell’umanità. Tale criterio divenne infatti caratteristicodell’umanesimo ungherese. Ciò corrispondeva proprio altemperamento del popolo magiaro portato all’azione eall’osservanza delle leggi dello stato, caratteristica chegià l’imperatore romano d’Oriente Leone VI il Saggio(886-912) aveva evidenziato nella sua Tattica di guerra[XVIII, 58].Anche Filippo Buonaccorsi soggiacque al mito e alfascino di Mattia. Il Buonaccorsi (San Gimignano 1437 –Cracovia 1496), aggregato all’accademia di PomponioLeto col nome di Callimaco Esperiente, era statocostretto ad emigrare all’estero essendo stato implicatonella congiura ordita contro il papa Paolo II; rifugiatesiin Polonia nel 1470, divenne precettore dei figli del reCasimiro IV, poi suo segretario e quindi consigliere delsuo successore Jan Olbracht salendo alfine alle più altecariche dello stato. Nominato ambasciatore per contodel re di Polonia alla corte del Corvino negli anni 1483-84, anziché convincere il sovrano magiaro a mutare lapropria politica espansionistica, rimase invece colpitosia dalle sue capacità politiche, sia dalla splendidacultura umanistica che fioriva alla sua corte. Nell’Attilainfatti, il Buonaccorsi descrive il re degli unni come ilmonarca perfetto, che tra l’altro vedeva incarnatoproprio in Mattia Corvino; egli anticipa quindi ilMachiavelli nella diffusione nell’Europa centrale delladottrina del ‘Principe’. Così da propugnatore e difensoredegli ideali di libertà e di democrazia della szlachta,Callimaco Esponente sarebbe ben presto passato nella<strong>OSSERVATORIO</strong> <strong>LETTERARIO</strong> <strong>Ferrara</strong> e l’Altrove <strong>A<strong>NN</strong>O</strong> <strong>XIII</strong> – <strong>NN</strong>. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 200963
- Page 1:
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l
- Page 4 and 5:
esclamativo o dubitativo, dall'uso
- Page 7 and 8:
dove il passo dell’uomosi confond
- Page 10 and 11:
leggere il biglietto. Lo sfilai dal
- Page 13 and 14: fiducia dei due vecchi coniugi. Sol
- Page 15 and 16: e illumina i mali dei mortipasqua v
- Page 17 and 18: Végtelen imádság lett az életü
- Page 19 and 20: István Monok*QUESTIONI APERTE NELL
- Page 21 and 22: Szamosközy, tranne il curriculum d
- Page 23 and 24: confronto armato con il potere degl
- Page 25 and 26: 45 A. MIKÓ, Mathias Corvinus - Mat
- Page 27 and 28: assolutamente vincolante e univoca
- Page 29 and 30: esperienziale che, indubbiamente, n
- Page 31 and 32: Emerge un tardo ottocento più prop
- Page 33 and 34: limita all’analisi stilistica del
- Page 35 and 36: Ecco un brano del Poema della Croce
- Page 37 and 38: e proprie trappole disseminate sia
- Page 39 and 40: Poi Mater Fabula raccontò che i ri
- Page 41 and 42: TRADURRE - TRADIRE - INTERPRETARE -
- Page 43 and 44: fájdalmat hallotta dobogni a mellk
- Page 45 and 46: Mozart zenéje behatolt az ereibe,
- Page 47 and 48: che scendonoper le tempieil mare de
- Page 49 and 50: MILLENNIUM TERTIUM, Opera eseguita
- Page 51 and 52: panchine sotto i pergolati e nei pa
- Page 53 and 54: cielo che infiamma di azzurro il mo
- Page 55 and 56: quello dei Caracciolo. Gli ultimi a
- Page 57 and 58: anti-ungheresi. La religione predom
- Page 59 and 60: (1378-1388, 1411-1415), Re d’Ungh
- Page 61: pronto e abbellito con gli affresch
- Page 65 and 66: Guarino da Verona, la cui scuola di
- Page 67 and 68: icompensa — perché venissero res
- Page 69 and 70: http://www.osservatorioletterario.n
- Page 71 and 72: del Segre, mentre le tendenze più
- Page 73 and 74: in qualche nuovo modo”. Quel “n
- Page 75 and 76: calcolare, pena il tocco delle sue
- Page 77 and 78: 1909 (in collaborazione con G. Vail
- Page 79 and 80: ventre/ rabbia e umiliazione,/ dall
- Page 81 and 82: Petrocchi applica lo stesso process
- Page 83 and 84: Questo intermezzo intorno all’ess
- Page 85 and 86: sono rispettivamente quella di Giul
- Page 87 and 88: cercare di mantenerlo quanto più p
- Page 89 and 90: versione di Quasimodo, unica nel su
- Page 91 and 92: in parte nel Basso Medioevo, lo si
- Page 93 and 94: numerica potrebbe essere qui la Mon
- Page 95 and 96: miniera nel mondo, localizzata prop
- Page 97 and 98: veda Kersten[46]. Mosè alla fine d
- Page 99 and 100: MENZIONI SPECIALI:BALASTIERA# 186by
- Page 101 and 102: «sforzo», di un «impegno»: spes
- Page 103 and 104: Ritratti, storie, percorsiScrittori
- Page 105 and 106: Il lettore in questione sicuramente
- Page 107 and 108: dall'uno all'altro dio o semidio, c
- Page 109 and 110: modello bronzeo inscritto, che fung
- Page 111 and 112: William Hawking, il fisico britanni
- Page 113 and 114:
(vincitori: Silvana Aurilia - Napol
- Page 115 and 116:
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l
- Page 117 and 118:
APPENDICE/FÜGGELÉK____Rubrica del
- Page 119 and 120:
érnem csak egyszer? Sosem adatott.
- Page 121 and 122:
ajzott szerelmesek enyhülést kerg
- Page 123 and 124:
kis ironikus árnyalatot éreztem k
- Page 125 and 126:
volt, amikor egyszerre három láb
- Page 127 and 128:
hagysz itt bennünket? Meddig bírj
- Page 129 and 130:
diplomát kapván, az állam által
- Page 131 and 132:
tapasztalták meg. Azokban az élm
- Page 133 and 134:
szőr a hátunkon. Sajnos nem volt
- Page 135 and 136:
Most pedig következzenek a felvét
- Page 137 and 138:
Nos, induljunk tovább, mert van m
- Page 139 and 140:
számítógépes tájékoztató út
- Page 141 and 142:
idézné: A szkíták valaha igen b
- Page 143 and 144:
Mindenesetre a megnevezett kutatók
- Page 145 and 146:
A maga egészében különös szell
- Page 147 and 148:
E gondolatokkal foglalkozva eszembe
- Page 149 and 150:
látható titokzatos tárgy, amelye
- Page 151 and 152:
HASZNOS HÍREKtéged ígért a vár
- Page 153 and 154:
az említett munkáidról a híreid
- Page 155 and 156:
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l