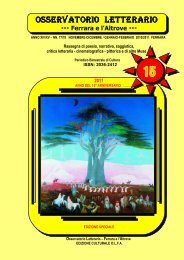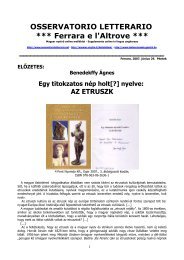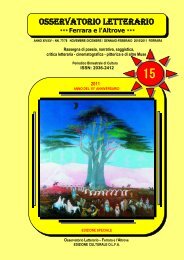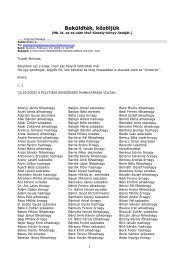udì la voce non di un poeta, ma di un vates che sipresentava al popolo con il suo canto…”.Orazio conosce Virgilio e gli diviene subito amico: “Essiavevano del resto gusti uguali: né all’uno né all’altropiacevano i poeti che affettavano l’antico; e a questinon piacevano essi, come è naturale”. L’idea diun’amicizia intima fra Orazio e Virgilio contro i comuniantagonisti letterari stuzzicava il sentimento e lafantasia del Pascoli, al quale sembrava in tal modo disentirseli più vicini: “Io gioisco di cogliere, sebbene daun’infinita distanza, una qualche parola tra i conversaridei due massimi poeti romani. Non parlavano essi deiloro disegni? Non leggevano a vicenda i loro tentativi?Non si ispiravano l’uno dall’altro? Vergilio imitava daTeocrito la Pharmaceutria: Orazio pensava anch’essouna scena di sortilegi, ma cittadinesca, tragica. Vergilioabbozzava parlando, o leggeva abbozzato, l’idilliocampestre del secondo libro delle Georgiche, e Oraziofaceva anch’esso quasi in parodia il suo bozzettocampagnolo, ma in persona di uno strozzino: idilliocomico”.Così, risaltando quelle caratteristiche che dei dueantichi poeti più amava, il Pascoli ha fatto un soloquadro, anche se con qualche forzatura, tipo il“bozzetto campagnolo” di Orazio (l’epodo II) che hacome protagonista lo strozzino… Ma troppo gliaggradava l’idea di una stretta fraternità d’arte e di vitatra i due poeti augustei, e così l’ha voluta vedererealizzata. In tal modo, il Pascoli critico e filologo vieneincontro al Pascoli poeta nelle sue predilezioni. Unesempio: nel ritratto ideale di Orazio, non faceva bellafigura l’episodio della fuga durante la battaglia di Filippi,dopo aver abbandonato lo scudo (la non bene relictaparmula dell’ode II 7). Ed ecco che il Pascoli, nel suocommento all’ode, è pronto a dimostrare che quel sensifugam vuol dire “provai le amare conseguenze dellafuga” e che parmula è uguale per metonimia adequitatus; pertanto relicta parmula significherebbe“lasciata sola la cavalleria”…; e il diminutivo parmulapotrebbe alludere a quel pugno di “prodi disgraziati” trai quali figurava anche il tribunus militum Orazio. Indefinitiva, non è Orazio che è scappato abbandonandolo scudo, ma è stato lui, tra quel pugno di “prodidisgraziati”, che è stato abbandonato non bene dallacavalleria! Così, grazie all’abilità del critico-filologo, lamacchia è tolta, l’onore del Venosino è salvo ed ilPascoli poeta è soddisfatto!Il Pascoli sentiva Orazio vicino per la pensosa intimitàsugli eterni problemi della vita e sul suo fineultimo. L’aderenza al pensiero oraziano è chiara neltono, nel senso profondo dei commenti a quelle odidove più risalta il doloroso problema esistenziale: sidirebbe che egli vi esponga il suo stesso pensiero,come nel riassunto dell’ode I 18: “Hai misurato la terra,il mare, l’arena” – grida il navigante al sapiente Archita– Ed eccoti qui mezzo sepolto sul lido di Matinata. Nonti giova esserti spinto sino al cielo: eri mortale.Morirono anche altri che più da presso toccarono gli dèie il cielo: morì anche Pythagora che credeva che lamorte non avesse da aver possanza se non sopra il suocorpo. E, tu lo sai, egli era bene addentro nei segretidella natura. Dobbiamo morir tutti (…), vecchi, giovani,tutti. (…) Non giova la scienza, non giova ribellarsi colpensiero al destino comune: tutti dobbiamo morire”.Oppure nell’introduzione all’ode I 34: Orazio è rimastostupito e pensoso per un fulmine a ciel sereno. È un dioche lo scaglia? E che intenzioni ha? “Mistero” – rispondeil Pascoli – “Salvo è il reo, colpito l’innocente? Nonsappiamo nulla: vediamo soltanto: mutamenti repentini,inesplicabili, fulmini veramente a ciel sereno. E l’uomo,nel tremore di tutta la natura, deve tremare anch’esso,non deve arrischiarsi a spiegare ciò che non puòspiegare, deve chiamare insania la sua sapientia”. Quic’è già in nuce tutto il Pascoli “cosmico” dei Canti diCastelvecchio, il cantore del mistero dell’universo!In fondo ad ogni gioia, anche a quella così luminosa diuna nuova primavera, c’è – oscuro e cupo – il pensierodella morte: ed il consiglio che Orazio, pieno ditristezza, dà a Torquato nell’ode IV 7, ha una profondarisonanza nell’animo pascoliano: “La neve dimoiò,rinverzica il campo, rimette l’albero, e i fiumi scorrononel loro letto. È un danzare di Grazie e di Ninfe… mabada: questo avvicendarsi di stagioni ti dice che seimortale. Ora il freddo è cessato, alla primavera segueperò l’estate, all’estate l’autunno e poi… i brevi dìdell’inverno. Passano i mesi, la luna si oscura esparisce: ma pur ritorna: noi, quando siamo andatilaggiù dove tutti devono andare, siamo polvere edombra. Chi sa se la vita nostra finora vissuta avràancora un domani?” Chi è che si pone questointerrogativo angosciante? L’antico od il nuovo poeta? Ilpensiero oraziano è tutto dominato dalla duranecessitas della morte, anche se il poeta sembrasorridere e godere delle gioie della vita. Lo segue neilieti convivii, nelle vicende amorose, persino neltranquillo riposo della vita agreste. Ed è lo stessopensiero che dòmina anche l’animo del Pascoli, che loesprime in tutte le sue opere, dalle prime Myricae(1891, l’anno stesso in cui inizia la stesura di Lyra e incui vince per la prima volta il Certamen Hoefftianumcon il poemetto Veianius) in avanti. Lo esprime in versimirabili (magistralmente tradotti in prosa dallo stessoAutore), nella lingua medesima di Orazio, nel poemettoSermo, composto al tempo in cui esce Lyra (1895) e poiincluso nei Poematia et epigrammata. È un dubbio chenon lascia requie. Orazio tenta di liberarsene invitandoLydia incoronata di rose a godere l’attimo fuggente (ilceleberrimo carpe diem dell’ode I 11); il Pascoli ci invitaad andare incontro alla morte abituandoci al pensierodi essa un poco tutti i giorni: così impareremo a nontemerla! Ma se le vie sono diverse, si sente che identicoè il punto di arrivo: in fondo al nappo di Orazio non c’èla dimenticanza ma il dolore; ed il consiglio del Pascolinon tende certo a familiarizzare con la morte, ma arendere più sopportabile la vita, dominata dal dolore.Ed il dolore è il filo rosso che lega fraternamente ilPascoli a Virgilio. Il Mantovano ha un posto diprotagonista assoluto nella successiva antologia, Epos(Giusti, Livorno, 1897), in cui il Pascoli commenta dapar suo quasi tutta l’Eneide. “Ci sono racconti, nei suntidell’Eneide, che sembrano myricae, poemetti, inni…”:così scrive con affetto Manara Valgimigli nellapresentazione di una ristampa che negli anni CinquantaLa Nuova Italia fece delle due antologie. Ma già ilCarducci in persona, in una lettera del 24 novembre1896, avendo letto la prima stesura di Epos, avevaindirizzato una lettera di ringraziamento al suo Autore:“Caro Pascoli…, tu mi hai fatto sentire e gustare Virgilio72<strong>OSSERVATORIO</strong> <strong>LETTERARIO</strong> <strong>Ferrara</strong> e l’Altrove <strong>A<strong>NN</strong>O</strong> <strong>XIII</strong> – <strong>NN</strong>. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 2009
in qualche nuovo modo”. Quel “nuovo modo” che ilMaestro aveva percepito, lo si avverte ancora oggiintero e intatto nei sunti, nelle note, nelle traduzioni enel “commentario” sulla poesia epica in Roma checostituisce l’introduzione di Epos.E il Virgilio di Epos è lo stesso dei Carmina, dove ha unruolo di primo piano, nella sua veste di poeta bucolico egeorgico, in due poemetti: l’Ecloga XI sive ovispeculiaris – vera e propria prosecuzione ideale delledieci ecloghe virgiliane – ed il Senex Coricius, in cui unfamoso episodio delle Georgiche (IV 125 segg.) èsviluppato e variato con un’adesione tale al mondospirituale del modello, che fece restare stupiti edammirati esegeti come il Gandiglio ed il Barchiesi. Poiritroviamo Virgilio nel Moretum, dov’è silenzioso, quasiritroso, sulla raeda di Mecenate che prende su Orazioper una delle tante scampagnate e nell’aia assolatad’una masserìa ricorda al patronus che l’olezzantefocaccia di cui s’è invogliato è il moretum pieno d’aglioche lui stesso aveva cantato da giovinetto. Nella Cenain Caudiano Nervae il Mantovano discute di poesia conOrazio e con altri dotti amici, e raccomanda alVenosino, tra lo stupore dei presenti che intuiscono ilnascere di cose immortali, di continuare la sua opera,s’egli non vivrà ancora a lungo, cantando la bellezza ela grandezza di Roma (e Orazio adempirà alla promessainnalzando il suo Carmen Speculare). In FanumVacunae Virgilio compare nel sogno di Orazio che sitramuta in un inno di riconoscenza per il suo“verecondo amico” (Lyra); in Sosii Frates BibliopolaeMarco Sosio sta dettando nel retrobottega ai suoicopisti i primi versi del primo libro delle Georgiche eVirgilio è oggetto delle critiche severe del vecchio poetaFurio Bibàculo; infine in Ultima Linea è presentenell’affettuoso ricordo di Orazio (Virgilio ormai non c’èpiù) che diviene al tempo stesso una certezzanell’immortalità della poesia.Ma guardando ai riferimenti di lingua, di stile, dicontenuto, possiamo dire che Virgilio sia presente nonsoltanto nel Liber de Poetis, bensì in tutte le altresezioni dei Carmina e massimamente, per affinità diargomenti con la poetica pascoliana, nei Ruralia, ipoemetti georgici che hanno per protagonisti animali epiante. Per tacere della poesia italiana, in cui ilMantovano è sempre costantemente presente non sololaddove compaiono temi d’ispirazione georgica, masoprattutto quando – come abbiamo già detto sopra – ildolore diviene il sostrato e il leit motiv della profondaispirazione lirica pascoliana.“Per fare un Virgilio ci vuole il dolore. Ci vuole, per direpiù propriamente, in un’anima grande la grandeemozione superstite d’un grande dolore”, egli scrive: equi è possibile trovare, in sintesi, tutto il motivodell’adesione spirituale del moderno all’antico poeta.Come scrivevo in una mia vecchia plaquette (M.PE<strong>NN</strong>ONE, Pascoli e Virgilio, Personaledit, Genova,1996, ma il breve saggio era stato scritto nel 1981 inoccasione del bimillenario della morte del sommoMantovano), il Virgilio del Pascoli è “vissuto”direttamente, non si ferma all’impressione paesaggisticadel famoso sonetto carducciano delle Rime Nuove oall’immagine bella e preziosa del sonetto dannunzianoPer la mèsse (da L’Isotteo): il Virgiliuo del Pascoli èPoeta fraternamente amico e vicino, oltre le barriere deltempo. È il Poeta degli umili, dei deboli, dei diseredati,degli “sradicati”, degli esuli; è il Poeta che ha provatosu di sé il dolore, e perciò vede gli uomini e il mondosotto una luce diversa. Il dolore è l’altro versante dellaserena Arcadia virgiliana; il dolore, presente anchenell’Eneide (si ricordi il celeberrimo verso: sunt lacrimaererum et mentem mortalia tangunt, I 462), è l’essenzache sprigiona dalla vita e dall’opera del Poeta di SanMauro. La pietas virgiliana, che nel poema immortale èriversata su Enea, è la pietas del Pascoli di fronte almondo, sia pur crudele, degli uomini; è un invito allabontà, alla mitezza, alla fraternità, a comporre lediscordie e gli odii in quel sentimento di fratellanzaumana che dovrebbe unire sulla “prona terra” tutti gliuomini, tutte le classi sociali, unite sotto la guida di unnuovo ordine universale (chi non ricorda il finale de Idue fanciulli?: “Uomini, Pace!…”).La formazione del pensiero pascoliano va ricercata,oltre che nell’influsso delle correnti positivistiche cosìattive al suo tempo, anche nel fondo intellettualisticodel pensiero dei grandi classici, specialmente la dottrinaepicurea di Lucrezio, di Orazio, dello stesso Virgilio, suiquali aveva a lungo studiato. Si viene così a ingenerareun incessante contrasto tra la sua intima natura, che lospingerebbe ad una piena adesione al Cristianesimo, ela sua formazione classica che, malgrado il desideriosincero di una fede, lo portava a dolorose conclusioniagnostiche.Lyra ed Epos ci illuminano dunque sul particolareatteggiamento del Pascoli di fronte ai classici e sul suopersonalissimo modo di intenderli e sentirli. E non pochidi quei motivi che si rilevano dalla lettura dei“commentarii” delle due antologie, dalle introduzioni edalle note ai singoli brani, li ritroviamo poi tradotti inpoesia latina nei Carmina e anche in svariati luoghidella poesia italiana. Per molti anni è sfuggito aparecchi critici il ruolo importantissimo che queste dueopere di “critica poetica” (o, come dissi io nella mia tesidi dottorato: M. PE<strong>NN</strong>ONE, Pascoli: da Lyra al Liber dePoetis. Dal momento filologico al momento creativo,Ist. Di Filologia Classica e Medievale, Univ. Degli Studidi Genova, A.A. 1977-78, di “poesia critica”) hannoavuto nella gènesi non solo di parecchi dei Carmina(alcuni di essi non sono che lo sviluppo poetico diun’idea abbozzata in sede critica, come il Catullocalvosod il Moretum), ma anche di alcune delle Myricae(come ha dimostrato A. SERONI, Per una storia delleMyricae, in “Letteratura”, 19, 1941) e dei PoemiConviviali.Ed è proprio per questa stretta interdipendenza tral’opera di pensiero e l’opera poetica che i Carmina nonsono affatto, come il Croce ebbe a credere e taluniancora continuano a sostenere, una sempliceesercitazione umanistica, ma la spontanea, naturaleespressione artistica dell’intimo sentire dell’Autore, diquegli spiriti e di quelle forme della classicità romana edel primo Cristianesimo che il Pascoli vedeva e sentivaessenzialmente nella sua veste primaria, cioè quella dipoeta. In altre parole – conclude lo Jannaco – fuproprio l’originale e speciale modo di studiare e disentire l’arte e la storia di Roma antica e le primevicende cristiane che, unitamente ad una padronanzaveramente straordinaria della lingua e della metricalatine, portò quasi necessariamente il Pascoli ad<strong>OSSERVATORIO</strong> <strong>LETTERARIO</strong> <strong>Ferrara</strong> e l’Altrove <strong>A<strong>NN</strong>O</strong> <strong>XIII</strong> – <strong>NN</strong>. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 200973
- Page 1:
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l
- Page 4 and 5:
esclamativo o dubitativo, dall'uso
- Page 7 and 8:
dove il passo dell’uomosi confond
- Page 10 and 11:
leggere il biglietto. Lo sfilai dal
- Page 13 and 14:
fiducia dei due vecchi coniugi. Sol
- Page 15 and 16:
e illumina i mali dei mortipasqua v
- Page 17 and 18:
Végtelen imádság lett az életü
- Page 19 and 20:
István Monok*QUESTIONI APERTE NELL
- Page 21 and 22: Szamosközy, tranne il curriculum d
- Page 23 and 24: confronto armato con il potere degl
- Page 25 and 26: 45 A. MIKÓ, Mathias Corvinus - Mat
- Page 27 and 28: assolutamente vincolante e univoca
- Page 29 and 30: esperienziale che, indubbiamente, n
- Page 31 and 32: Emerge un tardo ottocento più prop
- Page 33 and 34: limita all’analisi stilistica del
- Page 35 and 36: Ecco un brano del Poema della Croce
- Page 37 and 38: e proprie trappole disseminate sia
- Page 39 and 40: Poi Mater Fabula raccontò che i ri
- Page 41 and 42: TRADURRE - TRADIRE - INTERPRETARE -
- Page 43 and 44: fájdalmat hallotta dobogni a mellk
- Page 45 and 46: Mozart zenéje behatolt az ereibe,
- Page 47 and 48: che scendonoper le tempieil mare de
- Page 49 and 50: MILLENNIUM TERTIUM, Opera eseguita
- Page 51 and 52: panchine sotto i pergolati e nei pa
- Page 53 and 54: cielo che infiamma di azzurro il mo
- Page 55 and 56: quello dei Caracciolo. Gli ultimi a
- Page 57 and 58: anti-ungheresi. La religione predom
- Page 59 and 60: (1378-1388, 1411-1415), Re d’Ungh
- Page 61 and 62: pronto e abbellito con gli affresch
- Page 63 and 64: dell’epoca (Poggio Bracciolini, L
- Page 65 and 66: Guarino da Verona, la cui scuola di
- Page 67 and 68: icompensa — perché venissero res
- Page 69 and 70: http://www.osservatorioletterario.n
- Page 71: del Segre, mentre le tendenze più
- Page 75 and 76: calcolare, pena il tocco delle sue
- Page 77 and 78: 1909 (in collaborazione con G. Vail
- Page 79 and 80: ventre/ rabbia e umiliazione,/ dall
- Page 81 and 82: Petrocchi applica lo stesso process
- Page 83 and 84: Questo intermezzo intorno all’ess
- Page 85 and 86: sono rispettivamente quella di Giul
- Page 87 and 88: cercare di mantenerlo quanto più p
- Page 89 and 90: versione di Quasimodo, unica nel su
- Page 91 and 92: in parte nel Basso Medioevo, lo si
- Page 93 and 94: numerica potrebbe essere qui la Mon
- Page 95 and 96: miniera nel mondo, localizzata prop
- Page 97 and 98: veda Kersten[46]. Mosè alla fine d
- Page 99 and 100: MENZIONI SPECIALI:BALASTIERA# 186by
- Page 101 and 102: «sforzo», di un «impegno»: spes
- Page 103 and 104: Ritratti, storie, percorsiScrittori
- Page 105 and 106: Il lettore in questione sicuramente
- Page 107 and 108: dall'uno all'altro dio o semidio, c
- Page 109 and 110: modello bronzeo inscritto, che fung
- Page 111 and 112: William Hawking, il fisico britanni
- Page 113 and 114: (vincitori: Silvana Aurilia - Napol
- Page 115 and 116: OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l
- Page 117 and 118: APPENDICE/FÜGGELÉK____Rubrica del
- Page 119 and 120: érnem csak egyszer? Sosem adatott.
- Page 121 and 122: ajzott szerelmesek enyhülést kerg
- Page 123 and 124:
kis ironikus árnyalatot éreztem k
- Page 125 and 126:
volt, amikor egyszerre három láb
- Page 127 and 128:
hagysz itt bennünket? Meddig bírj
- Page 129 and 130:
diplomát kapván, az állam által
- Page 131 and 132:
tapasztalták meg. Azokban az élm
- Page 133 and 134:
szőr a hátunkon. Sajnos nem volt
- Page 135 and 136:
Most pedig következzenek a felvét
- Page 137 and 138:
Nos, induljunk tovább, mert van m
- Page 139 and 140:
számítógépes tájékoztató út
- Page 141 and 142:
idézné: A szkíták valaha igen b
- Page 143 and 144:
Mindenesetre a megnevezett kutatók
- Page 145 and 146:
A maga egészében különös szell
- Page 147 and 148:
E gondolatokkal foglalkozva eszembe
- Page 149 and 150:
látható titokzatos tárgy, amelye
- Page 151 and 152:
HASZNOS HÍREKtéged ígért a vár
- Page 153 and 154:
az említett munkáidról a híreid
- Page 155 and 156:
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l