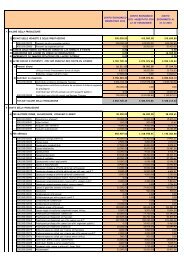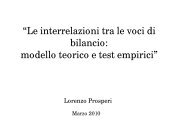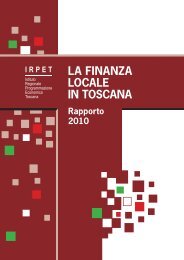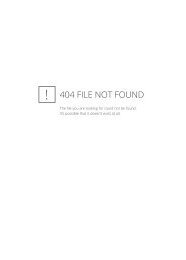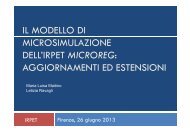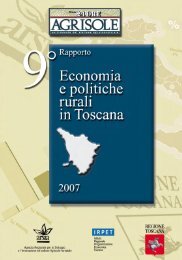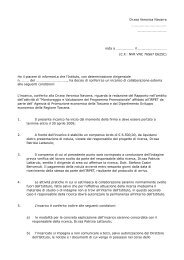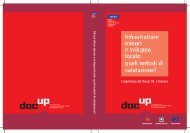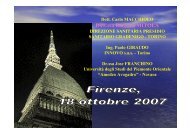La condizione giovanile ai tempi della crisi - Irpet
La condizione giovanile ai tempi della crisi - Irpet
La condizione giovanile ai tempi della crisi - Irpet
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
orare e poi attuare strategie di livello all’altezza dei <strong>tempi</strong>. <strong>La</strong> Regione Toscana da<br />
questo punto di vista ha l’occasione di divenire il pivot del cambiamento anche attraverso<br />
l’adozione di una logica sistemica top-down <strong>della</strong> programmazione e distribuzione<br />
dei fattori produttivi, possibile solo a patto di dotarsi delle capacità<br />
programmatorie necessarie a gestire il processo di trasferimento di risorse, strumenti e<br />
personale, previsto dalla bozza di Accordo tra Stato e Regioni e dalla Legge 42/2009.<br />
Nell’ambito del ragionamento complessivo che sottolinea il ruolo strategico di<br />
una governance regionale forte, dal Focus Group emerge una proposta concreta per<br />
far fronte alla necessità di investire in capitale umano e istruzione in presenza di<br />
una drammatica scarsità di risorse. Si tratta di meccanismi di welfare-mix con incentivi<br />
fiscali per le imprese che investano sulle scuole. Alcuni imprenditori, anche<br />
in coordinamento con altri attori locali pubblici e privati, potrebbero prendersi in<br />
carico l’istituto tecnico locale, il liceo scientifico o l’istituto d’arte e investirvi per<br />
migliorare le strutture, per assistere gli allievi, e al tempo stesso per influenzare il<br />
profilo <strong>della</strong> didattica, in una logica di coordinamento regionale ma anche di attenzione<br />
alle esigenze locali.<br />
All’interno di questo quadro, che coinvolge la capacità di interagire, il coordinamento<br />
e la visione strategica dei principali attori istituzionali (il sistema<br />
dell’istruzione, l’Università, il governo regionale, le rappresentanze delle imprese e<br />
dei lavoratori) è dunque auspicabile affrontare il tema <strong>della</strong> costruzione di un curriculum<br />
locale principalmente, ma non solo, a carattere vocazionale o tecnico-professionale,<br />
da declinare in tutti i canali di insegnamento secondari. In questo, il ruolo<br />
dell’Università, delle agenzie di sviluppo, delle regioni e degli enti locali è molto<br />
importante. Ciò che serve insegnare e apprendere in Toscana non può ragionevolmente<br />
essere deciso al livello <strong>della</strong> Conferenza Stato-Regioni o del MIUR. Occorre<br />
una governance regionale che “si sporchi le mani sul livello locale”, che sia capace<br />
di dialogare con gli operatori, che possa intervenire nel meccanismo di produzione<br />
degli apprendimenti. Le norme attualmente vigenti danno la possibilità alle regioni<br />
di impartire indicazioni curriculari sul 20% del tempo scuola finanziato dallo Stato.<br />
Sino ad oggi la Regione Toscana ha lasciato <strong>ai</strong> singoli istituti l’autonomia di decidere<br />
sulla destinazione di questo tempo scuola. Tuttavia la logica dei “100 fiori<br />
fioriranno” non ha dato i risultati sperati ma ha molto spesso confermato punti di<br />
forza e debolezza dei singoli istituti, fallendo nel qualificare il rapporto tra scuola e<br />
territorio. È dunque opportuno che le regioni assumano la governance rispetto a<br />
questo 20% del tempo scuola che può essere oggetto di un call for proposal che<br />
pieghi in un qualche modo i meccanismi di insegnamento-apprendimento coniugandoli<br />
con le esigenze dello sviluppo a scala regionale e locale. Questo potrebbe<br />
essere un modo molto concreto di riattivare il collegamento tra la scuola e il territorio,<br />
tra la scuola e il mondo del lavoro, tra la scuola e l’impresa.<br />
Tra le competenze “chiave” appare particolarmente suggestivo, per una regione<br />
come la Toscana (caratterizzata da un declino progressivo <strong>della</strong> propensione a fare<br />
impresa, in particolare tra le giovani generazioni), il richiamo all’educazione<br />
all’imprenditorialità. Da questo punto di vista emerge la necessità di studiare a fondo<br />
la letteratura e le policy dell’ambito nordeuropeo, in particolare le riflessioni e le<br />
esperienze danese e olandese 57 .<br />
Finanziare l’istruzione<br />
con meccanismi di<br />
welfare mix<br />
Il “curriculum locale”<br />
per riattivare il<br />
collegamento tra la<br />
scuola e il territorio<br />
L’educazione<br />
all’imprenditorialità<br />
è essenziale per le<br />
nuove generazioni<br />
57 Dalle esperienze nordeuropee emergono chiaramente alcune evidenze:<br />
1. la qualità dell’educazione all’imprenditorialità dipende dall’individuazione e distinzione corretta tra le competenze<br />
specifiche e quelle “trasversali”;<br />
2. sulle competenze specifiche poco si riesce a fare, a ameno che non si riesca a costruire stage e inserimenti in<br />
azienda che supportino l’educazione all’imprenditorialità;<br />
3. sulle competenze trasversali, che sono comunque utili all’imprenditorialità, si riesce a fare molto, ma esse non<br />
danno luogo ad un vantaggio immediato, e non hanno un grande peso se l’educazione all’imprenditorialità<br />
inizia tardi, durante i percorsi di istruzione del ciclo secondario e sugli studenti universitari. I risultati sono invece<br />
eccellenti se l’educazione comincia d<strong>ai</strong> cicli inferiori.<br />
73