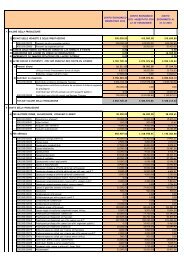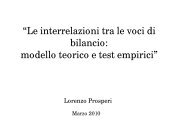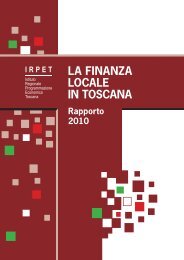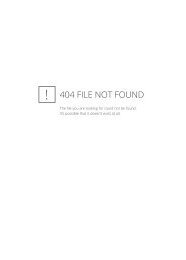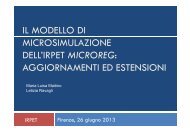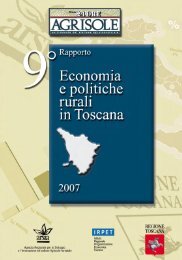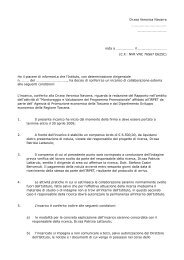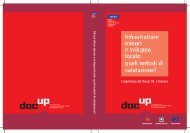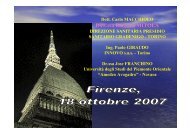La condizione giovanile ai tempi della crisi - Irpet
La condizione giovanile ai tempi della crisi - Irpet
La condizione giovanile ai tempi della crisi - Irpet
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
mentre le produzioni più mature e a minore valore aggiunto vengono delocalizzate verso<br />
Paesi a basso costo del lavoro, Cina e Messico in primo luogo.<br />
Complementarietà istituzionale<br />
Quello che accade, in forme diverse, in Germania e in Giappone è che le aziende accettano<br />
vincoli sociali che diminuiscono la loro libertà di azione nel mercato del lavoro. In Germania,<br />
oltre a sopportare i costi dell’apprendistato, le aziende non possono assumere individui privi<br />
di qualifica professionale, che sarebbero con ogni probabilità disposti a lavorare per salari<br />
inferiori; in Giappone le aziende cedono alle scuole, almeno parzialmente, una funzione<br />
strategica quale il reclutamento e la selezione. Questi vincoli, che consentono di produrre il<br />
bene pubblico rappresentato da una forza lavoro qualificata e motivata, non sono accettati<br />
dalle aziende nella consapevolezza di poter godere di questo beneficio: sul breve periodo<br />
ne godrebbero anche adottando un comportamento opportunistico, assumendo lavoratori<br />
formati altrove, senza sobbarcarsi i costi di questa formazione. <strong>La</strong> strategia opportunistica di<br />
assumere lavoratori già formati, prendendo i benefici ed evitando i costi dell’investimento,<br />
rimane la strategia privilegiata per le aziende che si misurano con il mercato. Tuttavia, il vincolo<br />
istituzionale viene invece accettato, come strategia di second best, perché c’è fiducia a<br />
livello sistemico: le aziende credono che nessun concorrente adotterà comportamenti opportunisti,<br />
e il buon funzionamento trascorso del sistema garantisce non tanto una (astratta)<br />
massimizzazione dell’utile quanto una situazione (concretamente) soddisfacente (Streeck,<br />
1988; 1994; Finegold e Soskice, 1988; Soskice, 1994). Per avere indicazioni, dunque, sulla<br />
viabilità di un sistema di formazione professionale orientato alla ridondanza, occorre guardare<br />
al livello sistemico, e all’interconnessione che a quel livello esiste tra il modo in cui è<br />
organizzata la formazione professionale e gli altri aspetti <strong>della</strong> regolazione istituzionale<br />
dell’economia. Gli studiosi parlano a questo proposito di complementarietà istituzionale: due<br />
istituzioni sono complementari quando la presenza, o l’efficienza, <strong>della</strong> prima favorisce<br />
quella, o l’efficienza, <strong>della</strong> seconda (Hall e Soskice, 2001). Secondo questa interpretazione<br />
istituzionalista delle società contemporanee, al centro delle economie capitaliste sono gli<br />
attori economici, in primo luogo le aziende. Le diverse “varietà di capitalismo” si distinguono<br />
per come vi sono strutturate le interazioni strategiche delle aziende: all’interno dell’azienda<br />
quella con i lavoratori, all’esterno quelle con i fornitori, i clienti, i proprietari, il governo e le<br />
altre amministrazioni pubbliche, e così via. L’assetto istituzionale del rapporto tra sistema<br />
scolastico e mercato del lavoro secondo questa analisi è funzione del modo in cui le<br />
aziende si procurano le risorse umane. I diversi modelli di formazione delle competenze<br />
sono connessi a diversi modelli di regolazione del mercato del lavoro, a loro volta connessi<br />
con la distribuzione dei redditi (Estevez-Abe, Iversen e Soskice, 2001). <strong>La</strong> distinzione più<br />
generale è quella tra economie di mercato liberali, come quelle anglosassoni, dove i rapporti<br />
tra aziende e altri attori sono prevalentemente regolati dal mercato, ed economie di mercato<br />
coordinate, come Germania e Giappone, dove i rapporti tra aziende e altri attori sono regolati<br />
da un mix di mercato e norme politiche e sociali (Soskice, 1999; Hall e Soskice, 2001). I<br />
rapporti istituzionali esistenti in Germania e in Giappone sono quindi solo una parte di un<br />
sistema regolativo più ampio, in assenza del quale essi non sarebbero vitali. In Germania, la<br />
partecipazione delle aziende e dei sindacati alla gestione del sistema duale tedesco è complementare<br />
alle relazioni industriali cooperative e consensuali e alla forte regolazione istituzionale<br />
del mercato del lavoro che caratterizzano l’economia tedesca, mentre in Giappone il<br />
Jisseki Kankei è complementare alle regole di reciprocità che caratterizzano il rapporto di<br />
lavoro nelle aziende medie e grandi, dove l’impiego a vita non è garantito da leggi o contratti<br />
di lavoro ma da una norma sociale informale ma non per questo meno vincolante. Questo è<br />
il motivo per cui diversi tentativi di “esportare” i rapporti istituzionali tra scuole e aziende<br />
sono spesso andati incontro a fallimenti. Negli anni Ottanta del secolo scorso, per esempio,<br />
i governi britannici hanno cercato a più riprese di creare un sistema di qualifiche professionali<br />
ispirato a quello tedesco, e di coinvolgere le aziende nella gestione del sistema, per superare<br />
la tradizione locale, dove la formazione professionale avviene prevalentemente on<br />
the job, in modo analogo a quanto accade nel caso americano. Nessuno di questi tentativi è<br />
86