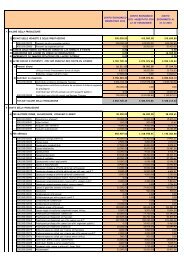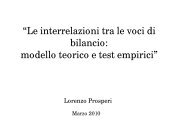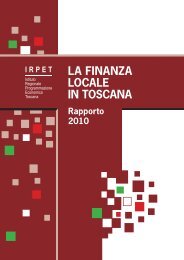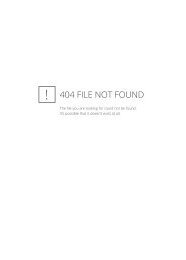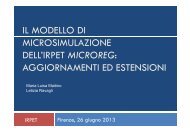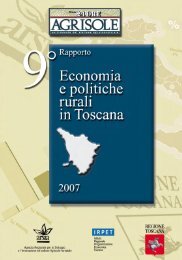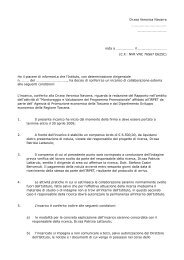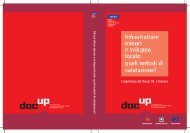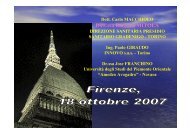La condizione giovanile ai tempi della crisi - Irpet
La condizione giovanile ai tempi della crisi - Irpet
La condizione giovanile ai tempi della crisi - Irpet
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Approfondimento 3.2<br />
MODELLI DI FORMAZIONE DELLE COMPETENZE E DI TRANSIZIONE DALLA<br />
SCUOLA AL LAVORO<br />
In una ricerca comparativa sulla formazione delle risorse umane in 5 regioni europee, Marino<br />
Regini (1996) distingue due modelli idealtipici di produzione sociale delle competenze<br />
di cui le aziende hanno bisogno: un modello orientato all’appropriatezza e un modello<br />
orientato alla ridondanza. Nel primo caso, le diverse istituzioni coinvolte (scuola, formazione<br />
professionale, aziende e così via) producono un insieme di competenze adeguate al fabbisogno<br />
immediato delle aziende, mentre nel secondo caso le istituzioni producono un di più<br />
di competenze rispetto a quello che è il fabbisogno immediato del sistema produttivo. Nel<br />
primo caso mancano rapporti stabili tra scuola e mercato del lavoro: la prima forma competenze<br />
generali e accademiche, mentre le competenze professionali e tecniche necessarie<br />
per le attività lavorative vengono prodotte on the job, senza che le aziende siano sottoposte<br />
ad alcun tipo di vincolo istituzionale. Nel secondo caso esistono rapporti, variamente organizzati,<br />
tra scuola e mercato del lavoro, e le attività formative delle aziende sono sottoposte<br />
a vari tipi di vincoli istituzionali. Sulla base dei risultati <strong>della</strong> ricerca, vengono ricondotti al<br />
primo modello i sistemi di formazione delle risorse umane dei Paesi dell’Europa meridionale<br />
(Italia e Spagna) e quello inglese, mentre al secondo modello vengono ricondotti i sistemi<br />
“renani”, ovvero il tedesco e il francese. In entrambi questi sistemi, infatti, esiste un intervento<br />
istituzionale sistematico che vincola gli attori coinvolti a produrre competenze in misura<br />
maggiore rispetto al fabbisogno immediato del sistema economico. Nel caso tedesco si<br />
tratta del “sistema duale” di apprendistato e formazione professionale, mentre nel caso<br />
francese si tratta di una quota del monte salari che secondo la legge le aziende devono investire<br />
nella formazione dei propri dipendenti, presso operatori accreditati dallo stato.<br />
<strong>La</strong> distinzione proposta da Regini può essere anche utilizzata in un senso più generale, per<br />
analizzare diversi modelli di transizione dalla scuola al lavoro e di rapporto tra sistemi scolastici<br />
e mercati del lavoro. Il problema sottostante è infatti il medesimo, ovvero quello <strong>della</strong><br />
produzione di un bene pubblico, qual è una forza lavoro qualificata o una popolazione<br />
istruita, in un contesto di economia di mercato, dove gli incentivi all’investimento si basano<br />
sui ritorni privati allo stesso. In un’economia di questo tipo le aziende sono poco incentivate<br />
a investire sulla formazione dei propri dipendenti, perché si crea una divergenza tra razionalità<br />
collettiva e razionalità privata, simile a quella descritta da paradossi analitici quali il<br />
“dilemma del prigioniero” o la “tragedia dei comuni” (Streeck, 1994; Soskice, 1994).<br />
L’azienda, attore razionale e interessato alla massimizzazione del proprio interesse, non è<br />
incentivata a investire nella formazione dei dipendenti, perché questi, dato che il mercato<br />
del lavoro è libero, potrebbero abbandonarla e passare alle dipendenze dei concorrenti. In<br />
questo modo l’azienda che ha investito nella formazione dei suoi dipendenti non riceverebbe<br />
i benefici del suo investimento, dopo averne sopportato i costi, mentre l’azienda concorrente<br />
si approprierebbe dei benefici dell’investimento in formazione senza averne sopportato<br />
i costi, semplicemente pagando una minima maggiorazione allo stipendio del lavoratore<br />
per incentivarlo ad abbandonare l’azienda dove si è formato. Dato che tutte le<br />
aziende sono razionali, in assenza di incentivi che trasformino questa struttura di interessi<br />
nessuna investirà nella formazione dei propri dipendenti. Questo porterà a un sottoinvestimento<br />
nella formazione delle risorse umane, che impedisce al sistema produttivo di collocarsi<br />
sulla cosiddetta high road (la “strada maestra”) allo sviluppo industriale, basata su<br />
qualificazione del lavoro, massiccia applicazione <strong>della</strong> tecnologia <strong>ai</strong> processi produttivi, alta<br />
qualità del prodotto e alti salari. Ci si troverà invece sulla cosiddetta low road (la “scorciatoia)”<br />
allo sviluppo, dove in assenza di adeguata formazione il lavoro sarà poco qualificato e<br />
poco retribuito, e il prodotto competerà sui costi. Si tratta di una strategia particolarmente<br />
rischiosa nel contesto globale attuale, con grande apertura dei commerci e la possibilità per<br />
i produttori insediati nei Paesi più poveri, con costo del lavoro strutturalmente più basso, di<br />
competere con quelli insediati nei Paesi più ricchi. <strong>La</strong> “strada maestra” rappresenta invece<br />
81