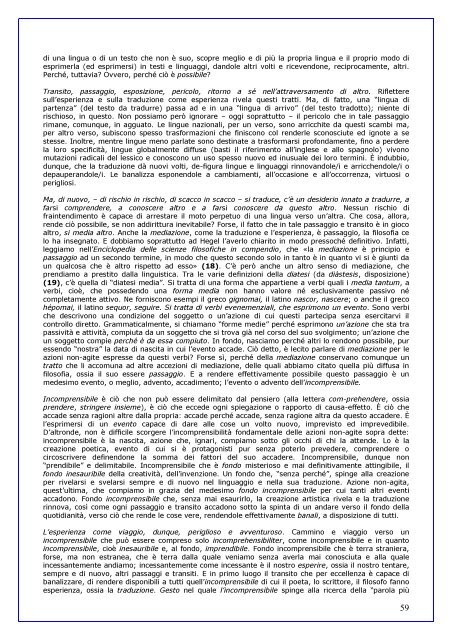ULISSE 7-8 - LietoColle
ULISSE 7-8 - LietoColle
ULISSE 7-8 - LietoColle
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
di una lingua o di un testo che non è suo, scopre meglio e di più la propria lingua e il proprio modo di<br />
esprimerla (ed esprimersi) in testi e linguaggi, dandole altri volti e ricevendone, reciprocamente, altri.<br />
Perché, tuttavia? Ovvero, perché ciò è possibile?<br />
Transito, passaggio, esposizione, pericolo, ritorno a sé nell’attraversamento di altro. Riflettere<br />
sull’esperienza e sulla traduzione come esperienza rivela questi tratti. Ma, di fatto, una “lingua di<br />
partenza” (del testo da tradurre) passa ad e in una “lingua di arrivo” (del testo tradotto); niente di<br />
rischioso, in questo. Non possiamo però ignorare – oggi soprattutto – il pericolo che in tale passaggio<br />
rimane, comunque, in agguato. Le lingue nazionali, per un verso, sono arricchite da questi scambi ma,<br />
per altro verso, subiscono spesso trasformazioni che finiscono col renderle sconosciute ed ignote a se<br />
stesse. Inoltre, mentre lingue meno parlate sono destinate a trasformarsi profondamente, fino a perdere<br />
la loro specificità, lingue globalmente diffuse (basti il riferimento all’inglese e allo spagnolo) vivono<br />
mutazioni radicali del lessico e conoscono un uso spesso nuovo ed inusuale dei loro termini. È indubbio,<br />
dunque, che la traduzione dà nuovi volti, de-figura lingue e linguaggi rinnovandole/i e arricchendole/i o<br />
depauperandole/i. Le banalizza esponendole a cambiamenti, all’occasione e all’occorrenza, virtuosi o<br />
perigliosi.<br />
Ma, di nuovo, – di rischio in rischio, di scacco in scacco – si traduce, c’è un desiderio innato a tradurre, a<br />
farsi comprendere, a conoscere altro e a farsi conoscere da questo altro. Nessun rischio di<br />
fraintendimento è capace di arrestare il moto perpetuo di una lingua verso un’altra. Che cosa, allora,<br />
rende ciò possibile, se non addirittura inevitabile? Forse, il fatto che in tale passaggio e transito è in gioco<br />
altro, si media altro. Anche la mediazione, come la traduzione e l’esperienza, è passaggio, la filosofia ce<br />
lo ha insegnato. E dobbiamo soprattutto ad Hegel l’averlo chiarito in modo pressoché definitivo. Infatti,<br />
leggiamo nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, che «la mediazione è principio e<br />
passaggio ad un secondo termine, in modo che questo secondo solo in tanto è in quanto vi si è giunti da<br />
un qualcosa che è altro rispetto ad esso» (18). C’è però anche un altro senso di mediazione, che<br />
prendiamo a prestito dalla linguistica. Tra le varie definizioni della diatesi (da diàstesis, disposizione)<br />
(19), c’è quella di “diatesi media”. Si tratta di una forma che appartiene a verbi quali i media tantum, a<br />
verbi, cioè, che possedendo una forma media non hanno valore né esclusivamente passivo né<br />
completamente attivo. Ne forniscono esempi il greco gignomai, il latino nascor, nascere; o anche il greco<br />
hépomai, il latino sequor, seguire. Si tratta di verbi evenemenziali, che esprimono un evento. Sono verbi<br />
che descrivono una condizione del soggetto o un’azione di cui questi partecipa senza esercitarvi il<br />
controllo diretto. Grammaticalmente, si chiamano “forme medie” perché esprimono un’azione che sta tra<br />
passività e attività, compiuta da un soggetto che si trova già nel corso del suo svolgimento; un’azione che<br />
un soggetto compie perché è da essa compiuto. In fondo, nasciamo perché altri lo rendono possibile, pur<br />
essendo “nostra” la data di nascita in cui l’evento accade. Ciò detto, è lecito parlare di mediazione per le<br />
azioni non-agite espresse da questi verbi? Forse sì, perché della mediazione conservano comunque un<br />
tratto che li accomuna ad altre accezioni di mediazione, delle quali abbiamo citato quella più diffusa in<br />
filosofia, ossia il suo essere passaggio. E a rendere effettivamente possibile questo passaggio è un<br />
medesimo evento, o meglio, advento, accadimento; l’evento o advento dell’incomprensibile.<br />
Incomprensibile è ciò che non può essere delimitato dal pensiero (alla lettera com-prehendere, ossia<br />
prendere, stringere insieme), è ciò che eccede ogni spiegazione o rapporto di causa-effetto. È ciò che<br />
accade senza ragioni altre dalla propria: accade perché accade, senza ragione altra da questo accadere. È<br />
l’esprimersi di un evento capace di dare alle cose un volto nuovo, imprevisto ed imprevedibile.<br />
D’altronde, non è difficile scorgere l’incomprensibilità fondamentale delle azioni non-agite sopra dette:<br />
incomprensibile è la nascita, azione che, ignari, compiamo sotto gli occhi di chi la attende. Lo è la<br />
creazione poetica, evento di cui si è protagonisti pur senza poterlo prevedere, comprendere o<br />
circoscrivere definendone la somma dei fattori del suo accadere. Incomprensibile, dunque non<br />
“prendibile” e delimitabile. Incomprensibile che è fondo misterioso e mai definitivamente attingibile, il<br />
fondo inesauribile della creatività, dell’invenzione. Un fondo che, “senza perché”, spinge alla creazione<br />
per rivelarsi e svelarsi sempre e di nuovo nel linguaggio e nella sua traduzione. Azione non-agita,<br />
quest’ultima, che compiamo in grazia del medesimo fondo incomprensibile per cui tanti altri eventi<br />
accadono. Fondo incomprensibile che, senza mai esaurirlo, la creazione artistica rivela e la traduzione<br />
rinnova, così come ogni passaggio e transito accadono sotto la spinta di un andare verso il fondo della<br />
quotidianità, verso ciò che rende le cose vere, rendendole effettivamente banali, a disposizione di tutti.<br />
L’esperienza come viaggio, dunque, periglioso e avventuroso. Cammino e viaggio verso un<br />
incomprensibile che può essere compreso solo incomprehensibiliter, come incomprensibile e in quanto<br />
incomprensibile, cioè inesauribile e, al fondo, imprendibile. Fondo incomprensibile che è terra straniera,<br />
forse, ma non estranea, che è terra dalla quale veniamo senza averla mai conosciuta e alla quale<br />
incessantemente andiamo; incessantemente come incessante è il nostro esperire, ossia il nostro tentare,<br />
sempre e di nuovo, altri passaggi e transiti. E in primo luogo il transito che per eccellenza è capace di<br />
banalizzare, di rendere disponibili a tutti quell’incomprensibile di cui il poeta, lo scrittore, il filosofo fanno<br />
esperienza, ossia la traduzione. Gesto nel quale l’incomprensibile spinge alla ricerca della “parola più<br />
59