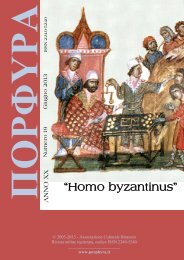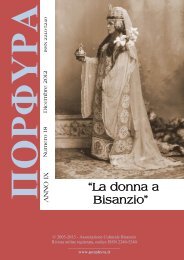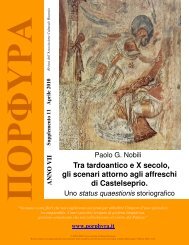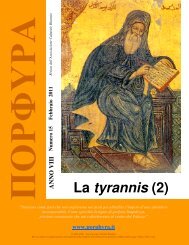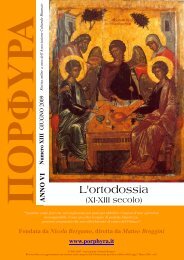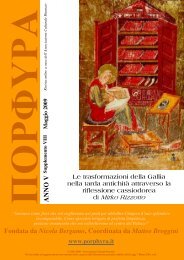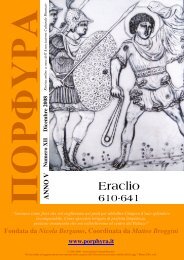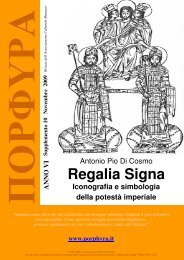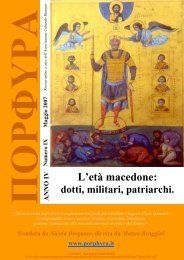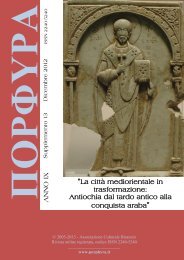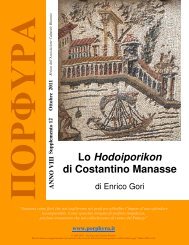Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
“Venezia e Bisanzio, incontro e scontro tra Oriente ed Occidente”<br />
Atti del convegno tenutosi a Venezia, 10-11 dicembre 2011<br />
<strong>Porphyra</strong>, giugno 2012, n. XVII<br />
Questa supremazia veniva poi rafforzata anche dai motivi economici,<br />
religiosi e culturali già visti, ed in effetti nel corso dell’XI secolo l’impero<br />
semplicemente annesse diversi di questi territori caucasici, finendo così per<br />
scontrarsi con i Turchi Selgiuchidi a Manzicerta, battaglia sicuramente<br />
strategica, in quanto decise il controllo su questo territorio, che nella teoria<br />
dell’heartland è ritenuto di grande valore geopolitico.<br />
Un esito diverso di questa battaglia avrebbe probabilmente portato i<br />
Bizantini ad assoggettare direttamente l’intera area, portandoli ad<br />
estendere la loro zona di influenza ad una regione ancora più fondamentale<br />
dal punto di vista geopolitico: l’Asia Centrale.<br />
Al contrario la vittoria selgiuchide tolse in una ventina d’anni<br />
all’impero il suo centro: l’Anatolia, un colpo da cui lo stato bizantino non<br />
si riebbe mai completamente, nonostante una breve stagione di rinascita<br />
sotto i Comneni. 15<br />
Da notare che questo non fu il solo periodo in cui ai Romani d’oriente<br />
parve aperta la via dell’Asia Centrale, giacché anche Eraclio mantenne una<br />
forte presenza militare nella regione caucasica tra il 624 ed il 628 nel corso<br />
delle sue campagne vittoriose contro l’impero Persiano Sasanide, ma in<br />
quel caso fu l’invasione araba a negare all’imperatore i frutti della vittoria.<br />
Concludendo possiamo dire che nel periodo considerato, che grosso<br />
modo va dalla morte di Giustiniano (565) alla battaglia di Manzicerta<br />
(1071), l’impero romano d’oriente, mantenendo un controllo di tipo<br />
politico - diplomatico sulle regioni a nord del Mar Nero e più diretto sul<br />
Caucaso, impedì di fatto che si formasse una potenza ostile che prendesse<br />
il controllo di tutte le terre dell’ hearthland, minacciando poi le zone del<br />
rimland in mano ai Bizantini, come era successo all’epoca dell’impero<br />
unno di Attila e come sarebbe successo ancora dopo Manzicerta ad opera<br />
dei Selgiuchidi e più ancora nel XIII secolo ad opera dei Mongoli.<br />
Questa grande strategia portò più volte i Romani d’oriente, nel periodo<br />
tra il VII e l’XI secolo, non solo a sopravvivere a numerose minacce<br />
esterne, ma ad allargare il loro dominio fino a proporsi come potenza<br />
dominante in una vasta area dell’Eurasia.<br />
Una visione geopolitica senza dottrina geopolitica<br />
Sembra <strong>qui</strong>ndi che la classe dirigente bizantina, nel corso di diversi<br />
secoli abbia consapevolmente portato avanti una grande strategia coerente<br />
con una visione geopolitica complessa. Ma ovviamente a quei tempi non<br />
esisteva nessuna disciplina paragonabile alle geopolitica, anche se già dai<br />
tempi della guerra del Peloponneso e di Tucidide doveva essere chiara la<br />
differenza tra potenze marittime e potenze continentali.<br />
La conclusione pertanto è che le élite dell’impero avessero, pur senza<br />
averle formalizzate, a causa della peculiare situazione geografica e delle<br />
contingenze storiche, concezioni geopolitiche elementari ma comunque<br />
utili al processo decisionale ed all’elaborazione informale di quella grande<br />
strategia che permise per tanto tempo la sopravvivenza dello stato<br />
bizantino in un ambiente esterno politicamente ostile.<br />
15 OSTROGORSKY G., Storia dell’impero bizantino, Torino 1993.<br />
11