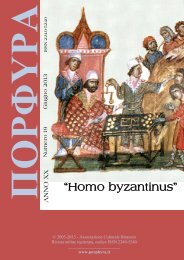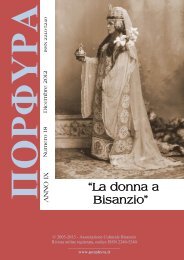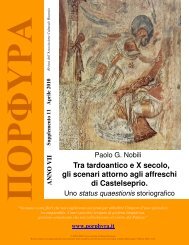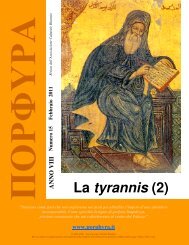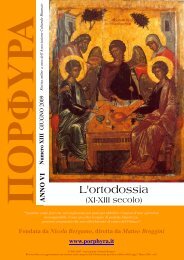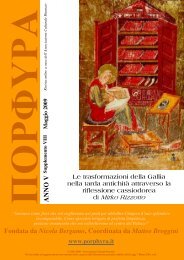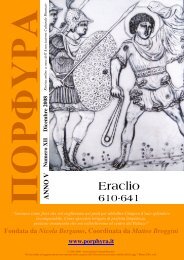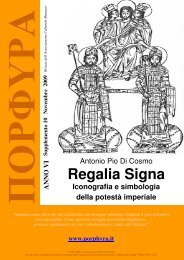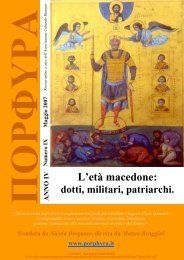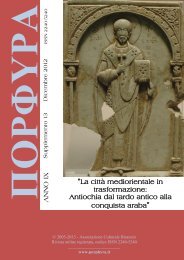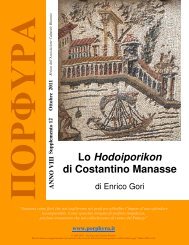You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
“Venezia e Bisanzio, incontro e scontro tra Oriente ed Occidente”<br />
Atti del convegno tenutosi a Venezia, 10-11 dicembre 2011<br />
<strong>Porphyra</strong>, giugno 2012, n. XVII<br />
orientali di varia provenienza ed uno ha un nome latino 269 . Un altro esempio<br />
è il nome semitico Μ⇐λχο∫ , attestato nella basilica del fondo Tullio alla<br />
Beligna 270 , a Monastero 271 in A<strong>qui</strong>leia, a Santa Maria delle Grazie a<br />
Grado 272 e ai SS. Felice e Fortunato di Vicenza (CIL, V, 1619, ora<br />
scomparsa). Nel caso dell’iscrizione della Beligna, non solo il nome e<br />
l’utilizzo dell’alfabeto greco, ma anche la presenza della formula <br />
(corrispondente all’espressione votum solvere), molto diffusa<br />
nell’impero d’Oriente (non così nell’alto Adriatico di questi secoli),<br />
avvalora l’ipotesi della provenienza orientale dell’individuo 273 . Come si<br />
spiega una tale concentrazione di nomi semitici/ebraici in un contesto<br />
religioso cristiano? La profonda compenetrazione degli Ebrei nella società,<br />
legata anche ad attività statali come la functio navicularia e l’appartenenza<br />
alle curie, poteva apparire insidiosa agli occhi del vescovo Cromazio (394-<br />
413), che si premurò di sottolinearne sempre le differenze rispetto ai<br />
Cristiani e preferì la loro esclusione, forte anche dell’esiguità della comunità<br />
ebraica stessa. Altrove, in Siria, l’influenza degli Ebrei era invece tale da<br />
vincolare i Cristiani locali alla loro stessa vita religiosa senza che senza<br />
costringerli a rinunciare alla propria fede 274 . D’altra parte, la situazione<br />
degli Ebrei nel corso del V secolo peggiorò a causa di limitazioni civili,<br />
politiche e religiose. Accanto ad una persistente tolleranza legale (e teorica)<br />
vi era una serie crescente di violenze, fomentate soprattutto dai monaci delle<br />
zone rurali di Siria, Palestina ed Egitto. La conversione missionaria era<br />
l’alternativa adottata in centri come A<strong>qui</strong>leia e nella stessa Costantinopoli,<br />
269<br />
BRUSIN-ZOVATTO, 1957, p. 340, n°18; Caillet, 1993, p. 167-168, n°7. Il suo diametro misura cm. 91 e le lettere<br />
del testo sono alte cm. 11-5:<br />
Μαρε / ας, Ιουλιαν⎫ς, /Παλλαδις και Ι⎫σηφ απο κ⎭ / µης Καπρο / τουρις π⎫(δας) λε⎺. = Mareas, Giuliano,<br />
Palladis e Giuseppe dal villaggio/regione di Caprotoulis fecero (realizzare) 35 piedi di mosaico. Secondo Levi della<br />
Vida, Μαρεας potrebbe essere ricollegato al termine aramaico mar “signore”, che spesso si ritrova nei nomi di persona,<br />
mentre Παλλαδις è indubbiamente greco ed è quasi uguale a Παλλ⇐διος (forse anche questa è una sopravvivenza di<br />
teonimo come nel caso di Anicitus, di Afrodites di Santa Maria delle Grazie e del suo vicino di Piazza della Vittoria).<br />
Ιοσηφ, invece, più spesso noto nella forma Ι⎭σηφ, è un nome ebraico, ma vista la varietà onomastica presentata in<br />
questo testo, senza specificazioni se non quella della provenienza, non significa che si tratti di un Ebreo. Per il<br />
toponimo, Brusin propone il confronto tra Καπροτουρις e Καπροζαβαραδα⇓ων, presso Apamea di Siria, attestato in<br />
un’epigrafe cristiana di Treviri edita da Hettner nel 1903. Sembra essere identificabile, pur con molte riserve, in<br />
Caperturi, e pare sia ubicato a Tourin nel Djebel Woustani al di sopra del ponte di Derkoush (area calcidica). Mouterde<br />
e Poidebard pensano che il primo elemento del nome (Kafr, “villaggio”) sia potuto cadere nel corso dei secoli, come<br />
accadde a Καπροπ⇒ρα (che divenne El-Bara) e Καπροβαραδα (trasformata in El-Brad).<br />
270<br />
Al livello della quarta fila di colonne partendo dai pilastri cruciformi del transetto erano collocate tre epigrafi, tutte<br />
perdute, ma una di esse è stata fotografata prima di andare distrutta. BRUSIN-ZOVATTO, 1957, p. 278, n°9;<br />
CAILLET, 1993, p. 147-1448, n°1. L’altezza delle lettere varia da 8 a 10 cm. e la superficie corrisponde a circa 3 m 2<br />
(cm 83 X 63): Μ⇐λχο∫ / υπ[⇑ρ ε]υ / χ⇒∫ επο⇓η / σεν π⎫ / δα[∫] λγ⎺= Malchos, come offerta votiva, fece (realizzare)<br />
33 piedi (di mosaico). Ringrazio il Prof. Paolo Odorico per la correzione a proposito della trascrizione del testo.<br />
271<br />
BRUSIN-ZOVATTO, 1957, p. 332, n°4; CAILLET, 1993, p. 172, n°13. Nella parte superiore reca un fiore stilizzato<br />
che si apre all’ingiù, la cui voluta è danneggiata. E’ lacunosa nella parte superiore, l’ultima riga e parte della penultima<br />
sono perdute. L’altezza è di cm. 82 e le lettere sono alte cm. 12:<br />
Βαρβ⇑ουσο∫ / ∆ρακοντ⇓ου / κ⎭µη Ραβωνα / ⇐µα συµβ⇓ου Μ⇐θβη / και τ⇑κνοισ Ιο⇐ν / να κα⇓ Μ⇐λχου / ε<br />
πο[⇓η]σαν [...] = Barbeusos (figlio di) Draconzio del villaggio/regione di Rab’ôn(a), così come sua moglie Mathbé e<br />
con i (loro) figli Giovanna e Malchos realizzarono […] (piedi di mosaico).<br />
272<br />
CAILLET, 1993, p. 206, n°6; COSENTINO, 1996, p. 409, n°39: Malchus / et Eufimia / cum suis vo / tum soluent =<br />
Malchus ed Eufemia con i loro (parenti) assolsero il (loro) voto.<br />
273<br />
Sull’uso di questa espressione: CAILLET J.P, op. cit., pag. 408.<br />
274<br />
CRACCO RUGGINI L., Pietro di Grado: giudaismo e conversioni nel mondo tardoantico, in AAAd XVII, vol. 1,<br />
Udine, 1980, p. 372, nota 44.<br />
91