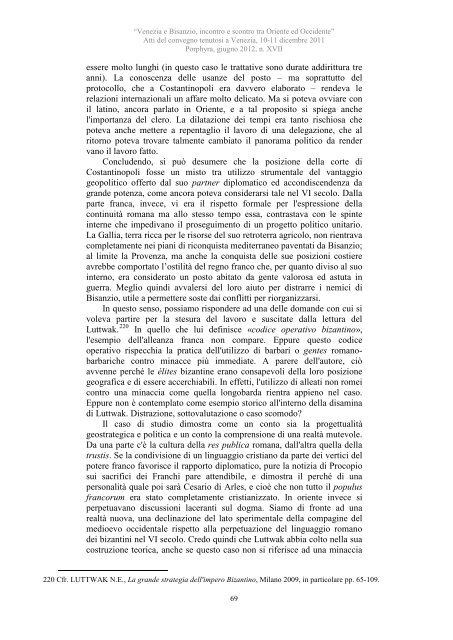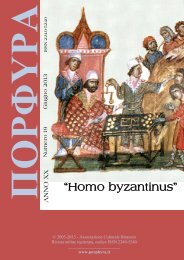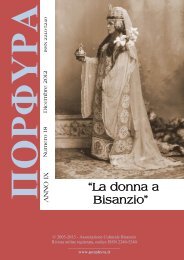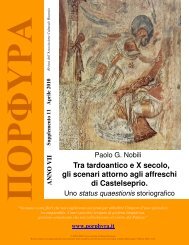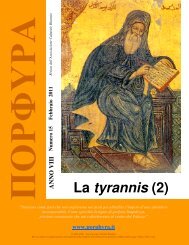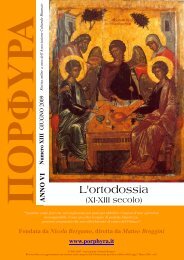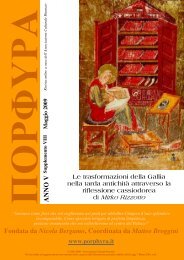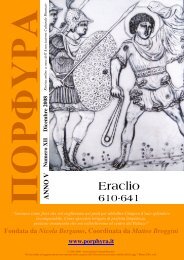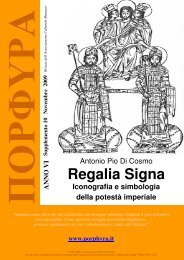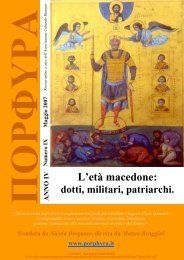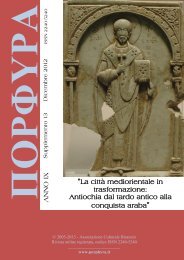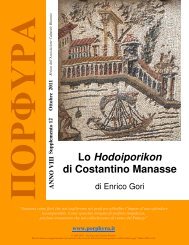You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
“Venezia e Bisanzio, incontro e scontro tra Oriente ed Occidente”<br />
Atti del convegno tenutosi a Venezia, 10-11 dicembre 2011<br />
<strong>Porphyra</strong>, giugno 2012, n. XVII<br />
essere molto lunghi (in questo caso le trattative sono durate addirittura tre<br />
anni). La conoscenza delle usanze del posto – ma soprattutto del<br />
protocollo, che a Costantinopoli era davvero elaborato – rendeva le<br />
relazioni internazionali un affare molto delicato. Ma si poteva ovviare con<br />
il latino, ancora parlato in Oriente, e a tal proposito si spiega anche<br />
l'importanza del clero. La dilatazione dei tempi era tanto rischiosa che<br />
poteva anche mettere a repentaglio il lavoro di una delegazione, che al<br />
ritorno poteva trovare talmente cambiato il panorama politico da render<br />
vano il lavoro fatto.<br />
Concludendo, si può desumere che la posizione della corte di<br />
Costantinopoli fosse un misto tra utilizzo strumentale del vantaggio<br />
geopolitico offerto dal suo partner diplomatico ed accondiscendenza da<br />
grande potenza, come ancora poteva considerarsi tale nel VI secolo. Dalla<br />
parte franca, invece, vi era il rispetto formale per l'espressione della<br />
continuità romana ma allo stesso tempo essa, contrastava con le spinte<br />
interne che impedivano il proseguimento di un progetto politico unitario.<br />
La Gallia, terra ricca per le risorse del suo retroterra agricolo, non rientrava<br />
completamente nei piani di ricon<strong>qui</strong>sta mediterraneo paventati da Bisanzio;<br />
al limite la Provenza, ma anche la con<strong>qui</strong>sta delle sue posizioni costiere<br />
avrebbe comportato l’ostilità del regno franco che, per quanto diviso al suo<br />
interno, era considerato un posto abitato da gente valorosa ed astuta in<br />
guerra. Meglio <strong>qui</strong>ndi avvalersi del loro aiuto per distrarre i nemici di<br />
Bisanzio, utile a permettere soste dai conflitti per riorganizzarsi.<br />
In questo senso, possiamo rispondere ad una delle domande con cui si<br />
voleva partire per la stesura del lavoro e suscitate dalla lettura del<br />
Luttwak. 220 In quello che lui definisce «codice operativo bizantino»,<br />
l'esempio dell'alleanza franca non compare. Eppure questo codice<br />
operativo rispecchia la pratica dell'utilizzo di barbari o gentes romanobarbariche<br />
contro minacce più immediate. A parere dell'autore, ciò<br />
avvenne perché le élites bizantine erano consapevoli della loro posizione<br />
geografica e di essere accerchiabili. In effetti, l'utilizzo di alleati non romei<br />
contro una minaccia come quella longobarda rientra appieno nel caso.<br />
Eppure non è contemplato come esempio storico all'interno della disamina<br />
di Luttwak. Distrazione, sottovalutazione o caso scomodo?<br />
Il caso di studio dimostra come un conto sia la progettualità<br />
geostrategica e politica e un conto la comprensione di una realtà mutevole.<br />
Da una parte c'è la cultura della res publica romana, dall'altra quella della<br />
trustis. Se la condivisione di un linguaggio cristiano da parte dei vertici del<br />
potere franco favorisce il rapporto diplomatico, pure la notizia di Procopio<br />
sui sacrifici dei Franchi pare attendibile, e dimostra il perché di una<br />
personalità quale poi sarà Cesario di Arles, e cioè che non tutto il populus<br />
francorum era stato completamente cristianizzato. In oriente invece si<br />
perpetuavano discussioni laceranti sul dogma. Siamo di fronte ad una<br />
realtà nuova, una declinazione del lato sperimentale della compagine del<br />
medioevo occidentale rispetto alla perpetuazione del linguaggio romano<br />
dei bizantini nel VI secolo. Credo <strong>qui</strong>ndi che Luttwak abbia colto nella sua<br />
costruzione teorica, anche se questo caso non si riferisce ad una minaccia<br />
220 Cfr. LUTTWAK N.E., La grande strategia dell'impero Bizantino, Milano 2009, in particolare pp. 65-109.<br />
69