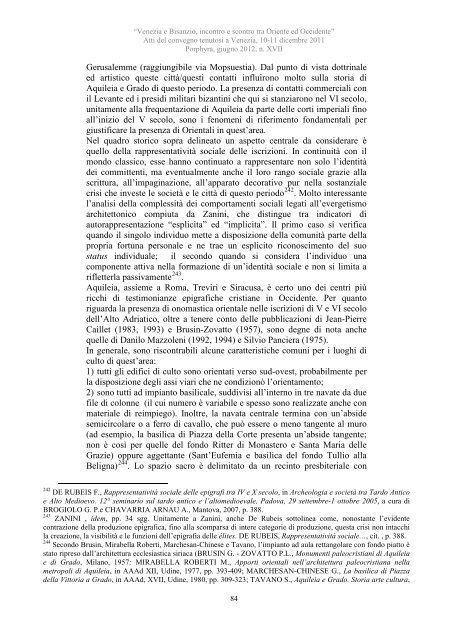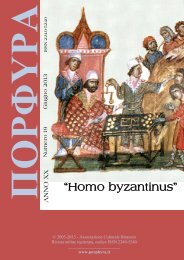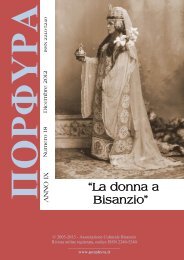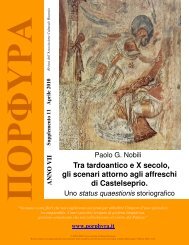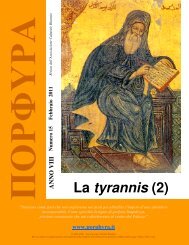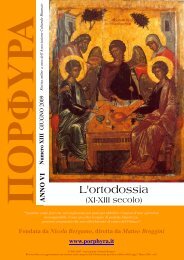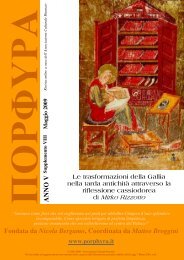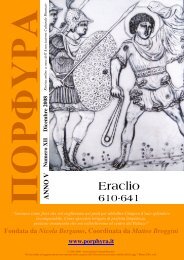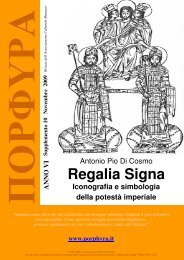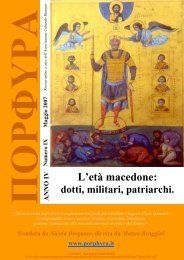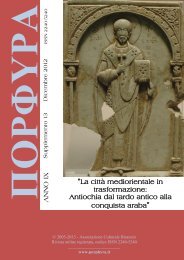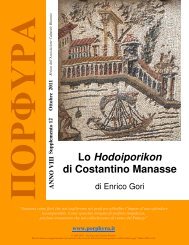You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
“Venezia e Bisanzio, incontro e scontro tra Oriente ed Occidente”<br />
Atti del convegno tenutosi a Venezia, 10-11 dicembre 2011<br />
<strong>Porphyra</strong>, giugno 2012, n. XVII<br />
Gerusalemme (raggiungibile via Mopsuestia). Dal punto di vista dottrinale<br />
ed artistico queste città/questi contatti influirono molto sulla storia di<br />
A<strong>qui</strong>leia e Grado di questo periodo. La presenza di contatti commerciali con<br />
il Levante ed i presidi militari bizantini che <strong>qui</strong> si stanziarono nel VI secolo,<br />
unitamente alla frequentazione di A<strong>qui</strong>leia da parte delle corti imperiali fino<br />
all’inizio del V secolo, sono i fenomeni di riferimento fondamentali per<br />
giustificare la presenza di Orientali in quest’area.<br />
Nel quadro storico sopra delineato un aspetto centrale da considerare è<br />
quello della rappresentatività sociale delle iscrizioni. In continuità con il<br />
mondo classico, esse hanno continuato a rappresentare non solo l’identità<br />
dei committenti, ma eventualmente anche il loro rango sociale grazie alla<br />
scrittura, all’impaginazione, all’apparato decorativo pur nella sostanziale<br />
crisi che investe le società e le città di questo periodo 242 . Molto interessante<br />
l’analisi della complessità dei comportamenti sociali legati all’evergetismo<br />
architettonico compiuta da Zanini, che distingue tra indicatori di<br />
autorappresentazione “esplicita” ed “implicita”. Il primo caso si verifica<br />
quando il singolo individuo mette a disposizione della comunità parte della<br />
propria fortuna personale e ne trae un esplicito riconoscimento del suo<br />
status individuale; il secondo quando si considera l’individuo una<br />
componente attiva nella formazione di un’identità sociale e non si limita a<br />
rifletterla passivamente 243 .<br />
A<strong>qui</strong>leia, assieme a Roma, Treviri e Siracusa, è certo uno dei centri più<br />
ricchi di testimonianze epigrafiche cristiane in Occidente. Per quanto<br />
riguarda la presenza di onomastica orientale nelle iscrizioni di V e VI secolo<br />
dell’Alto Adriatico, oltre a tenere conto delle pubblicazioni di Jean-Pierre<br />
Caillet (1983, 1993) e Brusin-Zovatto (1957), sono degne di nota anche<br />
quelle di Danilo Mazzoleni (1992, 1994) e Silvio Panciera (1975).<br />
In generale, sono riscontrabili alcune caratteristiche comuni per i luoghi di<br />
culto di quest’area:<br />
1) tutti gli edifici di culto sono orientati verso sud-ovest, probabilmente per<br />
la disposizione degli assi viari che ne condizionò l’orientamento;<br />
2) sono tutti ad impianto basilicale, suddivisi all’interno in tre navate da due<br />
file di colonne (il cui numero è variabile e spesso sono realizzate anche con<br />
materiale di reimpiego). Inoltre, la navata centrale termina con un’abside<br />
semicircolare o a ferro di cavallo, che può essere o meno tangente al muro<br />
(ad esempio, la basilica di Piazza della Corte presenta un’abside tangente;<br />
non è così per quelle del fondo Ritter di Monastero e Santa Maria delle<br />
Grazie) oppure aggettante (Sant’Eufemia e basilica del fondo Tullio alla<br />
Beligna) 244 . Lo spazio sacro è delimitato da un recinto presbiteriale con<br />
242 DE RUBEIS F., Rappresentatività sociale delle epigrafi tra IV e X secolo, in Archeologia e società tra Tardo Antico<br />
e Alto Medioevo. 12° seminario sul tardo antico e l’altomedioevale, Padova, 29 settembre-1 ottobre 2005, a cura di<br />
BROGIOLO G. P.e CHAVARRIA ARNAU A., Mantova, 2007, p. 388.<br />
243 ZANINI , idem, pp. 34 sgg. Unitamente a Zanini, anche De Rubeis sottolinea come, nonostante l’evidente<br />
contrazione della produzione epigrafica, fino alla scomparsa di intere categorie di produzione, questa crisi non intacchi<br />
la creazione, la visibilità e le funzioni dell’epigrafia delle élites. DE RUBEIS, Rappresentatività sociale…, cit. , p. 388.<br />
244 Secondo Brusin, Mirabella Roberti, Marchesan-Chinese e Tavano, l’impianto ad aula rettangolare con fondo piatto è<br />
stato ripreso dall’architettura ecclesiastica siriaca (BRUSIN G. - ZOVATTO P.L., Monumenti paleocristiani di A<strong>qui</strong>leia<br />
e di Grado, Milano, 1957; MIRABELLA ROBERTI M., Apporti orientali nell’architettura paleocristiana nella<br />
metropoli di A<strong>qui</strong>leia, in AAAd XII, Udine, 1977, pp. 393-409; MARCHESAN-CHINESE G., La basilica di Piazza<br />
della Vittoria a Grado, in AAAd, XVII, Udine, 1980, pp. 309-323; TAVANO S., A<strong>qui</strong>leia e Grado. Storia arte cultura,<br />
84