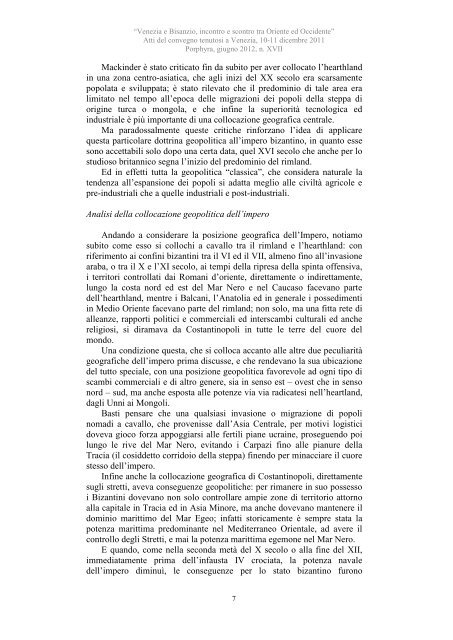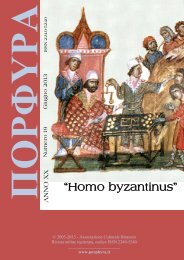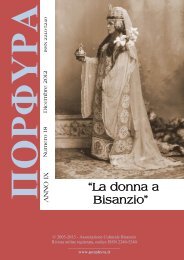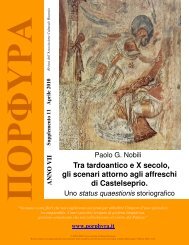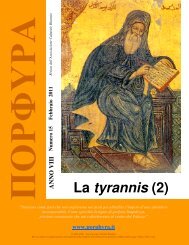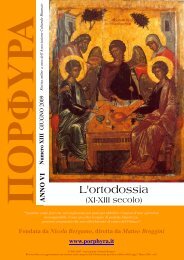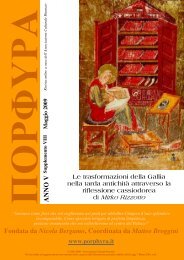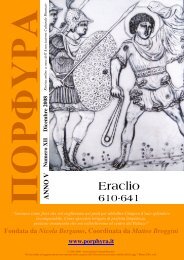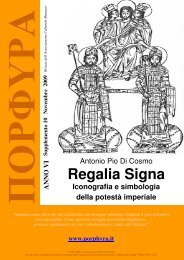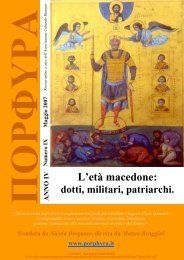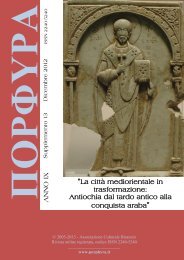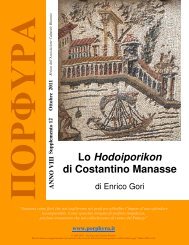Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
“Venezia e Bisanzio, incontro e scontro tra Oriente ed Occidente”<br />
Atti del convegno tenutosi a Venezia, 10-11 dicembre 2011<br />
<strong>Porphyra</strong>, giugno 2012, n. XVII<br />
Mackinder è stato criticato fin da subito per aver collocato l’hearthland<br />
in una zona centro-asiatica, che agli inizi del XX secolo era scarsamente<br />
popolata e sviluppata; è stato rilevato che il predominio di tale area era<br />
limitato nel tempo all’epoca delle migrazioni dei popoli della steppa di<br />
origine turca o mongola, e che infine la superiorità tecnologica ed<br />
industriale è più importante di una collocazione geografica centrale.<br />
Ma paradossalmente queste critiche rinforzano l’idea di applicare<br />
questa particolare dottrina geopolitica all’impero bizantino, in quanto esse<br />
sono accettabili solo dopo una certa data, quel XVI secolo che anche per lo<br />
studioso britannico segna l’inizio del predominio del rimland.<br />
Ed in effetti tutta la geopolitica “classica”, che considera naturale la<br />
tendenza all’espansione dei popoli si adatta meglio alle civiltà agricole e<br />
pre-industriali che a quelle industriali e post-industriali.<br />
Analisi della collocazione geopolitica dell’impero<br />
Andando a considerare la posizione geografica dell’Impero, notiamo<br />
subito come esso si collochi a cavallo tra il rimland e l’hearthland: con<br />
riferimento ai confini bizantini tra il VI ed il VII, almeno fino all’invasione<br />
araba, o tra il X e l’XI secolo, ai tempi della ripresa della spinta offensiva,<br />
i territori controllati dai Romani d’oriente, direttamente o indirettamente,<br />
lungo la costa nord ed est del Mar Nero e nel Caucaso facevano parte<br />
dell’hearthland, mentre i Balcani, l’Anatolia ed in generale i possedimenti<br />
in Medio Oriente facevano parte del rimland; non solo, ma una fitta rete di<br />
alleanze, rapporti politici e commerciali ed interscambi culturali ed anche<br />
religiosi, si diramava da Costantinopoli in tutte le terre del cuore del<br />
mondo.<br />
Una condizione questa, che si colloca accanto alle altre due peculiarità<br />
geografiche dell’impero prima discusse, e che rendevano la sua ubicazione<br />
del tutto speciale, con una posizione geopolitica favorevole ad ogni tipo di<br />
scambi commerciali e di altro genere, sia in senso est – ovest che in senso<br />
nord – sud, ma anche esposta alle potenze via via radicatesi nell’heartland,<br />
dagli Unni ai Mongoli.<br />
Basti pensare che una qualsiasi invasione o migrazione di popoli<br />
nomadi a cavallo, che provenisse dall’Asia Centrale, per motivi logistici<br />
doveva gioco forza appoggiarsi alle fertili piane ucraine, proseguendo poi<br />
lungo le rive del Mar Nero, evitando i Carpazi fino alle pianure della<br />
Tracia (il cosiddetto corridoio della steppa) finendo per minacciare il cuore<br />
stesso dell’impero.<br />
Infine anche la collocazione geografica di Costantinopoli, direttamente<br />
sugli stretti, aveva conseguenze geopolitiche: per rimanere in suo possesso<br />
i Bizantini dovevano non solo controllare ampie zone di territorio attorno<br />
alla capitale in Tracia ed in Asia Minore, ma anche dovevano mantenere il<br />
dominio marittimo del Mar Egeo; infatti storicamente è sempre stata la<br />
potenza marittima predominante nel Mediterraneo Orientale, ad avere il<br />
controllo degli Stretti, e mai la potenza marittima egemone nel Mar Nero.<br />
E quando, come nella seconda metà del X secolo o alla fine del XII,<br />
immediatamente prima dell’infausta IV crociata, la potenza navale<br />
dell’impero diminuì, le conseguenze per lo stato bizantino furono<br />
7