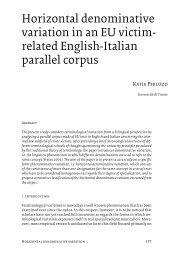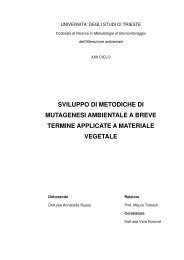universita - OpenstarTs
universita - OpenstarTs
universita - OpenstarTs
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Com’è noto, la dottrina, già sotto la vigenza del codice Rocco, ha classificato i<br />
vizi patologici afferenti le prove in due categorie. Si parla di “prove illecite” quando sia<br />
stata violata una norma penale sostanziale, o meglio quando la commissione di un reato<br />
si inserisca nell’iter che permette l’ammissione di una prova nel processo; sono, invece,<br />
definite “prove illegittime” quelle che presentano un vizio tale per cui nel procedimento<br />
di ammissione della prova sia ravvisabile una violazione di una norma processuale 267 .<br />
In assenza di espressa indicazione normativa, nel codice abrogato, vi fu un<br />
acceso dibattito che ha visto contrapposti i sostenitori delle due teorie. Da un lato,<br />
secondo l’impostazione dominante, l’ammissibilità delle prove doveva essere giudicata<br />
in base alla legge processuale 268 , poiché solo una falsa prospettiva avrebbe suggerito<br />
l’opinione secondo la quale sarebbero inammissibili le prove ottenute o formate con<br />
un’azione illecita 269 . Si sosteneva, infatti, che “per quanto la si cerchi riuscirà<br />
impossibile rintracciare nel nostro codice una norma che imponga d’escludere, e in ogni<br />
caso d’ignorare, le prove ottenute con un’azione illecita: le qualifiche d’ammissibilità e<br />
rilevanza appaiono formulate in base a criteri autonomi, endoprocessuali, fuori d’ogni<br />
riferimento ai paradigmi del diritto sostanziale” 270 . Ancora, secondo questa tesi, tali<br />
qualifiche non potevano essere dedotte dai princìpi costituzionali poiché le norme della<br />
Costituzione rappresentano il metro per valutare la validità delle leggi comuni, ma<br />
spetta alle leggi comuni del processo stabilire l’ammissibilità o meno delle prove 271 . In<br />
conclusione, si sosteneva che per decidere sulla validità dell’acquisizione probatoria<br />
bisognasse riferirsi al “potere di apprensione coattiva dell’organo giudiziario”, come<br />
dire che, in una ipotesi di sequestro probatorio eseguito all’esito di una perquisizione<br />
illegittima, “la chiave sta nel vedere se il giudice avrebbe potuto ordinare il sequestro;<br />
nell’ipotesi affermativa la prova è ammissibile, perché, di fatto, l’esito non eccede la<br />
misura del legittimamente conseguibile; e se invece il potere del sequestro non compete<br />
neppure al giudice, vale la conclusione opposta [...]. Ammesso che l’ausiliare si sia<br />
impossessato illegittimamente della prova, l’acquisizione da parte del giudice (che<br />
avrebbe potuto disporre il sequestro) interrompe la sequela: l’atto del funzionario era e<br />
resta illecito, ma il giudice può disporre validamente della prova perché, nell’acquisirla,<br />
267 Sulla distizione cfr. F. CORDERO, Prove illecite, in Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963, 147.<br />
268 F. CORDERO, Dialogo sulle prove, in Jus, 1964, 35.<br />
269 F. CORDERO, Il procedimento probatorio, in Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963, 63.<br />
270 F. CORDERO, Prove illecite, cit., 149.<br />
271 F. CORDERO, Prove illecite, cit., 153.<br />
101