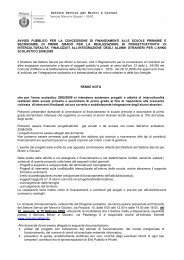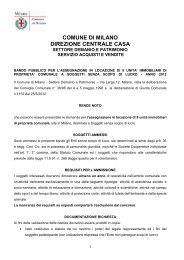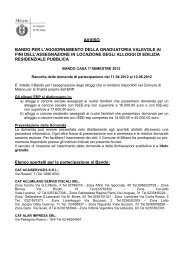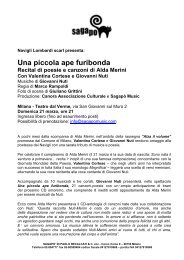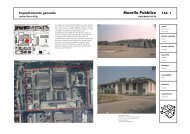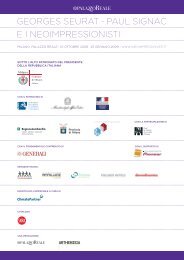LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
oBinia<br />
Famiglia: Fabaceae<br />
Nome scientifico: Robinia pseudoacacia L.<br />
Nome volgare: robinia, gaggìa, acacia<br />
Tipo biologico: Pscap<br />
Descrizione: Albero deciduo alto 2-25 m oppure arbusto pollonante (ceduato), con sistema ra<strong>di</strong>cale molto esteso in<br />
superficie; ritidoma <strong>di</strong> rami e giovani fusti omogeneo, grigiastro, quello dei tronchi fessurato longitu<strong>di</strong>nalmente in losanghe<br />
lunghe e strette. Foglie composte in me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 13-15 segmenti ellittici, <strong>di</strong> 3-5×1-2 cm, arrotondati all’apice, <strong>di</strong> un verde un<br />
po’ glauco, più chiari <strong>di</strong> sotto; stipole trasformate in spine robuste, nero-brunastre. Fiori molto profumati, in racemi ascellari<br />
penduli, lunghi 10-20 cm; corolla papilionata, lunga 15-20 mm, bianca con vessillo giallo alla base; stami <strong>di</strong>adelfi (1 libero<br />
+ 9 saldati a tubo per i filamenti); ovario supero, stilo sporgente dal tubo degli stami. Il frutto è un legume <strong>di</strong> 5-10×1 cm,<br />
appiattito, glabro, contenente 3-10 semi lenticolari-reniformi, bruni, opachi.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: aprile-giugno.<br />
Area d’origine: Nordamerica orientale (regione appalachiana).<br />
Habitat: Boschi planiziali e collinari, scarpate, incolti, siepi.<br />
Distribuzione nel territorio: Ovunque, in ambito planiziale e collinare. Bergamo (INV), Brescia (INV), Como (INV), Cremona<br />
(INV), Lecco (INV), Lo<strong>di</strong> (INV), Monza e Brianza (INV), <strong>Milano</strong> (INV), Mantova (INV), Pavia (INV), Sondrio (INV), Varese (INV).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, introdotta in Europa nel 1601, in Italia nel 1662 (Orto Botanico <strong>di</strong> Padova). In Lombar<strong>di</strong>a<br />
coltivata almeno dal 1785 all’Orto Botanico <strong>di</strong> Pavia (Hortus regius botanicus ticinensis, 1785, 1788, 1789); reintrodotta<br />
(me<strong>di</strong>ante nuovi esemplari americani) e <strong>di</strong>ffusa in Lombar<strong>di</strong>a nel 1787-1789 da parte del conte Luigi Castglioni e,<br />
successivamente, da Alessandro Manzoni; naturalizzata almeno dal 1855 (campione raccolto da F. Sordelli a <strong>Milano</strong> e<br />
conservato nell’Erbario dell’Università <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>, MI).<br />
Modalità d’introduzione: Deliberata: inizialmente come soggetto sperimentale <strong>di</strong> provenienza coloniale, poi scambiata<br />
privatamente tra cultori e appassionati (per es. Luigi Castiglioni e Alessandro Manzoni), quin<strong>di</strong>, nella seconda metà<br />
dell’Ottocento, impiegata in modo estensivo per consolidare gli argini delle prime linee ferroviarie in costruzione.<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: Sì.<br />
Impatto: Nei boschi causa per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> bio<strong>di</strong>versità in quanto soppianta le specie legnose autoctone. Il contenuto <strong>di</strong> azoto<br />
delle sue foglie è <strong>di</strong> 1.5-2.5 volte maggiore che nelle altre latifoglie (Ziegler, 1958), grazie alla simbiosi con batteri del genere<br />
Rhizobium che fissano l’azoto atmosferico. La caduta delle foglie determina quin<strong>di</strong> un aumento dell’azoto nel suolo e la<br />
comparsa <strong>di</strong> molte specie ammoniacali. A <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> altre vegetazioni eutrofiche, è la presenza della robinia che crea le<br />
con<strong>di</strong>zioni per un inse<strong>di</strong>amento della flora nitrofila. È specie inclusa nella lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto <strong>di</strong><br />
monitoraggio, contenimento o era<strong>di</strong>cazione, allegata alla l.r. 10/2008 della Lombar<strong>di</strong>a.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: La capacità espansiva della robinia è massimale fintanto che l’uomo ne pratica la gestione<br />
soprattutto attraverso il taglio ripetuto (ceduazione); pertanto, il recupero delle specie native e dei loro assetti naturali nelle<br />
cenosi infestate da robinia (boschetti e boscaglie) può conseguirsi a 25-30 anni dall’ultimo intervento perturbativo. Per evitare<br />
che le piante rigettino, è possibile praticare la cercinatura asportando un anello <strong>di</strong> corteccia largo 15 cm; in questo modo le<br />
ra<strong>di</strong>ci non ricevono più gli elaborati della fotosintesi e nell’anno successivo l’albero può essere abbattuto senza rischio <strong>di</strong><br />
reviviscenze.<br />
Note: La tremenda aggressività della robinia è dovuta all’alta efficienza <strong>di</strong> entrambe le modalità riproduttive della specie: vegetativa e per<br />
seme. La prima svolge ruolo essenziale nei popolamenti gestiti a ceduo o in qualche modo mantenuti giovanili da interventi <strong>di</strong> taglio, incen<strong>di</strong>o,<br />
estirpazione (incompleta), eliminazione parziale e altro; essa determina l’ampliamento progressivo del clone per riempimento degli spazi vuoti e<br />
per espansione periferica esterna. Ecco perché spesso si assiste all’esplosione della robinia nel giro <strong>di</strong> pochi anni in siti <strong>di</strong>sboscati destinati all’e<strong>di</strong>lizia.<br />
La seconda modalità, sommandosi alla prima per poi <strong>di</strong>ventare determinante nell’ambiente <strong>di</strong> fustaia (boscaglie invecchiate), interessa le piante<br />
sessualmente mature e in<strong>di</strong>sturbate rispetto ai cicli <strong>di</strong> fioritura, producendo nuclei <strong>di</strong> fondazione, per lo più irregolarmente <strong>di</strong>stribuiti, dovuti alla<br />
<strong>di</strong>spersione dei semi. Simile a R. viscosa e R. neomexicana, anch’esse presenti nel territorio regionale, per le quali si rimanda alla scheda <strong>di</strong> R. viscosa.<br />
roBinia<br />
vischiosa<br />
Tipo biologico: Pscap<br />
Descrizione: Alberello o albero deciduo, alto fino a 13 m, con crescita dell’anno ghiandoloso-pubescente e rametti appiccicosi,<br />
bruno-nerastri, provvisti <strong>di</strong> piccole spine (derivate dalla trasformazione delle stipole). Foglie imparipennate, composte <strong>di</strong> 6-12<br />
paia <strong>di</strong> segmenti ovato-ellittici, interi, lunghi fino a 5 cm, verde scuro sulla faccia adassiale, più o meno grigio-pubescenti su<br />
quella abassiale. Fiori in densi racemi penduli lunghi circa 8 cm; calice campanulato a 5 denti acuminati; corolla papilionacea,<br />
rosa vivo, alla base del vessillo con due macchie gialle simmetriche (guide del nettare); stami <strong>di</strong>adelfi (1 libero + 9 saldati<br />
a tubo per i filamenti); ovario supero, stilo sporgente dal tubo degli stami. Il frutto è un legume bruno-nerastro, lineare,<br />
appiattito, <strong>di</strong> 5-11×1-1.5 cm, <strong>di</strong> solito densamente ghiandoloso-pubescente, contenente piccoli semi reniformi, bruni.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: maggio-giugno.<br />
Area d’origine: Nordamerica sudorientale.<br />
Habitat: Boscaglie <strong>di</strong> latifoglie e boschi degradati (robinieti), scarpate.<br />
Distribuzione nel territorio: Presente soprattutto nell’alto milanese e nel basso varesino, ma con penetrazioni sino a Varese<br />
e in Valcuvia; è segnalata anche per la zona del torrente Molgora. Lecco (NAT), <strong>Milano</strong> (INV), Varese (INV).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, introdotta in Europa nel 1791. In Lombar<strong>di</strong>a segnalata da Stucchi (1972) come naturalizzata<br />
già da <strong>di</strong>versi anni.<br />
Modalità d’introduzione: Deliberata (ortofloricoltura, vivaistica).<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: No.<br />
Impatto: Molto contenuto, rilevabile solo alla fioritura.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: Al momento non appaiono necessarie.<br />
Note: Questa specie non è in grado <strong>di</strong> competere con la comune robinia (R. pseudoacacia), <strong>di</strong> cui occupa il medesimo habitat, ed è per questo che<br />
si mantiene marginale alle sue formazioni, senza penetrarvi. Da questa si riconosce agevolmente durante la fioritura per il colore dei fiori, negli altri<br />
perio<strong>di</strong> dell’anno per il colore e, soprattutto, l’indumento dei giovani rami.<br />
Le piante della zona del Parco del Molgora presentano alcuni caratteri non tipici <strong>di</strong> R. viscosa, come i legumi con ghiandole sessili, e vanno<br />
ulteriormente stu<strong>di</strong>ate.<br />
In Lombar<strong>di</strong>a è segnalata anche R. neomexicana A.Gray (robinia del Nuovo Messico, gaggìa del Nuovo Messico), osservata casuale nel bresciano<br />
(Guarino, 1995). Anch’essa è caratterizzata dai fiori rosa, ma i suoi rami non sono ghiandolosi.<br />
Bibliografia: Brusa et al. 2008a; Guarino, 1995; Isely & Peabody, 1984; Stucchi, 1972<br />
Famiglia: Fabaceae<br />
Nome scientifico: Robinia viscosa Vent.<br />
Nome volgare: robinia vischiosa, gaggìa vischiosa<br />
Sinonimi: Robinia glutinosa Sims<br />
Bibliografia: Gentile, 1995; Hortus regius botanicus ticinensis, 1785, 1788, 1789; Isely & Peabody, 1984; Klauck, 1988; Mon<strong>di</strong>no & Scotta, 1987; Stucchi, 1949b; Ziegler, 1958<br />
106 107