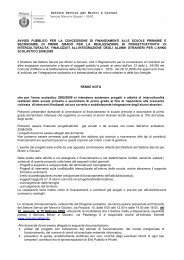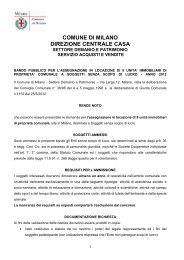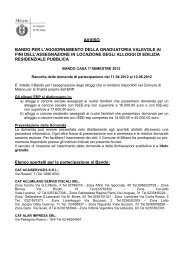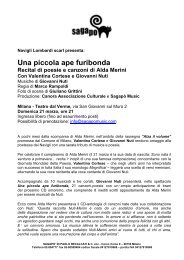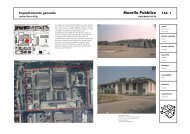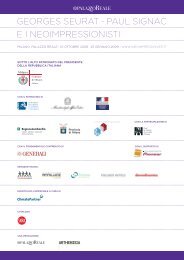LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
enagra a<br />
petali larghi<br />
Tipo biologico: Hbienn<br />
Descrizione: Pianta erbacea bienne, alta 80-150(-200) cm, con fusto ramoso, arrossato nella parte più bassa, superiormente<br />
verde e senza punteggiature rosse lungo l’asse dell’infiorescenza. Foglie alterne, lanceolate, a nervo me<strong>di</strong>ano bianco o incolore,<br />
acuminate e a margine intero o appena ondulato. Pelosità non ghiandolare, abbastanza fitta su fusto, foglie, ovario, frutti,<br />
sepali e ipanzio; i peli ghiandolari si sviluppano e <strong>di</strong>ventano prevalenti dall’inizio <strong>di</strong> agosto, se non più tar<strong>di</strong>. Fiori attinomorfi,<br />
notturni, fortemente odorosi, con 4 petali gialli lunghi 19-32 mm e larghi 26-40 mm; stami 8 in due verticilli; ovario semiinfero;<br />
stilo sempre incluso tra le antere. Il frutto è una capsula lineare loculicida, a 4 valve, lunga 30-45 mm.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: giugno-settembre.<br />
Area d’origine: Italia.<br />
Habitat: Greti fluviali, margini ruderali.<br />
Distribuzione nel territorio: Pressoché in tutto il territorio, nelle fasce planiziale e collinare. Bergamo (NAT), Brescia (INV),<br />
Cremona (INV), Lo<strong>di</strong> (INV), Monza e Brianza (NAT), <strong>Milano</strong> (INV), Mantova (NAT), Pavia (INV), Varese (INV).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, presumibilmente originatasi spontaneamente in Italia da piante speciate in Europa e<br />
introdotte deliberatamente da noi (piante da giar<strong>di</strong>no). Le date relative alla sua <strong>di</strong>ffusione sul nostro territorio non sono certe<br />
a causa della confusione tra le <strong>di</strong>verse specie: le prime raccolte in Italia risalgono al 1869 (Piemonte), quelle lombarde al 1882<br />
(Revere, MN); la prima segnalazione certa per la Lombar<strong>di</strong>a è <strong>di</strong> Soldano (1981).<br />
Modalità d’introduzione: Originatasi in loco (ve<strong>di</strong>: Periodo <strong>di</strong> introduzione).<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: Sì.<br />
Impatto: Estetico-paesaggistico; inoltre minaccia la bio<strong>di</strong>versità delle comunità a bassa competizione in cui si afferma.<br />
Note: Si veda quanto scritto per Oenothera biennis.<br />
Famiglia: Onagraceae<br />
Nome scientifico: Oenothera latipetala (Soldano) Soldano<br />
Nome volgare: enagra a petali larghi<br />
Basionimo: Oenothera suaveolens Desf. ex Pers. var.<br />
latipetala Soldano<br />
Bibliografia: Bonali, 2008; Bonali et al., 2006a; Dietrich et al., 1997; Mihulka et al., 2003; Soldano, 1981, 1993, 2010; Zanotti, 2010<br />
sommacco<br />
maggiore<br />
Tipo biologico: Pscap<br />
Descrizione: Alberello caducifoglio o grosso arbusto con stoloni sotterranei e fusti spesso in cerchio, arcuato-ascendenti,<br />
alti 2-10 m; rami ricoperti <strong>di</strong> una fitta pubescenza bruno-rossiccia o purpurea. Foglie alterne, imparipennate, con picciolo<br />
densamente rugginoso-pubescente e lamina raggiungente i 50 cm, composta <strong>di</strong> 11-31 segmenti lunghi fino a 11 cm,<br />
oblungo-lanceolati, seghettati al margine, fittamente pubescenti, ver<strong>di</strong>, viranti al rosso vivo in autunno. Fiori pentameri,<br />
piccoli, verdastri, in pannocchie terminali, erette, piramidali, molto compatte e lobulate, ispido-pubescenti per peli rosso<br />
ruggine e lunghe la metà delle foglie. Frutti a drupa con epicarpo ricoperto <strong>di</strong> lunghi peli purpurei.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: giugno-luglio.<br />
Area d’origine: Nordamerica orientale.<br />
Habitat: Incolti solatii.<br />
Distribuzione nel territorio: Frequentemente coltivata e a volte casuale, naturalizzata nel lecchese e bergamasco. Bergamo<br />
(NAT), Brescia (CAS), Cremona (CAS), Lecco (NAT), Monza e Brianza (CAS), <strong>Milano</strong> (CAS), Mantova (CAS), Pavia (CAS), Sondrio<br />
(CAS), Varese (CAS).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, coltivata in Italia dal Seicento e avventizia dalla seconda metà dell’Ottocento nel trevigiano<br />
(Saccardo, 1863); in Lombar<strong>di</strong>a segnalata da Giacomini (1950).<br />
Modalità d’introduzione: Deliberata (commercio ortofloricolo).<br />
Status: Naturalizzata.<br />
Dannosa: Potenzialmente sì.<br />
Impatto: Può formare popolamenti densi, deteriorando la vegetazione locale; la sua notevole e problematica <strong>di</strong>ffusione in<br />
Canton Ticino costituisce una minaccia anche per il nostro territorio.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: Evitarne l’uso nei giar<strong>di</strong>ni e nei parchi; non utilizzare terriccio contenente ra<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> sommacco; non<br />
tagliarlo (data la sua notevole capacità pollonifera), ma estirpare i turioni fino a completa eliminazione della pianta.<br />
Note: È specie della lista nera elvetica e va quin<strong>di</strong> tenuta sotto osservazione.<br />
Famiglia: Anacar<strong>di</strong>aceae<br />
Nome scientifico: Rhus typhina L.<br />
Nome volgare: sommacco maggiore<br />
Sinonimi: Datisca hirta L., nom. rej.<br />
Rhus hirta (L.) Sudw.<br />
Bibliografia: Aeschimann et al., 2004; Bonali et al., 2006a; Banfi & Galasso, 1998; Consonni, 1997, 1999; Giacomini, 1950; Saccardo, 1863<br />
162 163