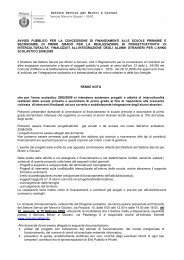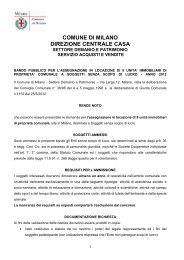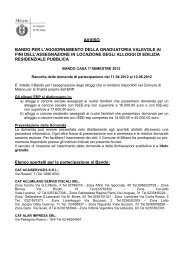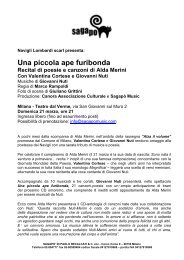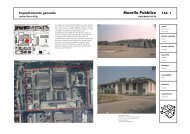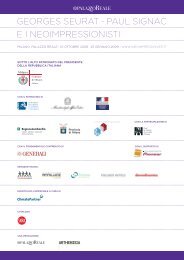LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
INTRODUzIONE E ASPETTI gENERALI INTRODUzIONE E ASPETTI gENERALI<br />
Da sempre, dove l’uomo installa i propri inse<strong>di</strong>amenti, le comunità originali <strong>di</strong> piante vengono<br />
sistematicamente demolite, dal taglio/incen<strong>di</strong>o della foresta al pascolo, all’agricoltura, alla<br />
cementificazione, e gli spazi prodottisi sono imme<strong>di</strong>atamente occupati da piante spontanee<br />
opportuniste, spesso classificate come erbacce o infestanti, che si espandono in lungo e in largo<br />
non trovando più la barriera verde originale; poiché causa del degrado è l’uomo, la vegetazione<br />
opportunistica che accompagna i suoi inse<strong>di</strong>amenti è detta sinantropica, intendendo sottolineare<br />
il fatto che si muove insieme a lui. Le piante sinantropiche con<strong>di</strong>vidono <strong>di</strong>verse, importanti strategie<br />
vitali che consentono loro <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>arsi e riprodursi rapidamente sui terreni denudati o <strong>di</strong>sturbati, prima<br />
che questi possano essere riconquistati stabilmente da una vegetazione strutturata. Al contingente<br />
sinantropico appartengono specie sia in<strong>di</strong>gene sia esotiche, le une già <strong>di</strong> casa, le altre provenienti dai<br />
luoghi più <strong>di</strong>sparati del mondo. Ecco tre esempi, rispettivamente, per ciascuna delle due categorie (ci<br />
riferiamo sempre al territorio lombardo): centocchio (Stellaria me<strong>di</strong>a), farinaccio (Chenopo<strong>di</strong>um album),<br />
sambuco (Sambucus nigra); occhi della Madonna (Veronica persica, Asia occidentale), assenzio dei Verlot<br />
(Artemisia verlotiorum, Estremoriente), robinia (Robinia pseudoacacia, Nordamerica).<br />
Va sottolineato che le aliene entrano a far parte della flora del territorio ospite proprio perché dotate<br />
<strong>di</strong> strategia sinantropica; <strong>di</strong>versamente non vi avrebbero accesso in quanto bloccate dalla barriera<br />
vegetazionale interna. Per la maggior parte, esse sono già sinantropiche in patria, ma non mancano<br />
quelle che, improvvisamente, una volta introdotte, sfuggono alla coltivazione svelando un’insospettata<br />
capacità invasiva (robinia, ailanto, buddleja, ciliegio tar<strong>di</strong>vo ecc.). Anche la nostra flora è “colpevole” <strong>di</strong><br />
simili misfatti in altre parti del mondo, basti ricordare, fra i più recenti, i casi del pino marittimo (Pinus<br />
pinaster) in Sudafrica e della ginestra (Spartium junceum) sulle Ande centro-meri<strong>di</strong>onali. In sostanza, il<br />
sinantropismo è con<strong>di</strong>cio sine qua non perché autoctone e alloctone convivano sul territorio.<br />
Per quanto riguarda Asia Minore, Europa e Nordafrica, da almeno 12˙000 anni, con la nascita<br />
dell’agricoltura e degli inse<strong>di</strong>amenti fissi, si verificano trasferimenti <strong>di</strong> piante da un’area geografica<br />
all’altra; si tratta <strong>di</strong> trasferimenti colturali che, inevitabilmente e all’insaputa della parte interessata,<br />
trascinano con sè una coorte <strong>di</strong> specie opportuniste, alcune delle quali estremamente specializzate<br />
nel competere con la coltura. È il noto caso della così detta vegetazione segetale o cerealicola, formata<br />
da piante come il fiordaliso (Cyanus segetum), il papavero (Papaver rhoeas), la camomilla (Matricaria<br />
chamomilla) e la zizania (Lolium temulentum), tutte <strong>di</strong> probabile, antichissima origine anatolica.<br />
Si presume che queste piante siano state involontariamente selezionate laddove ebbe inizio la<br />
domesticazione dei primi cereali e abbiano conseguito la capacità (mimetospermia e sin<strong>di</strong>aspora) <strong>di</strong><br />
farsi trasferire clandestinamente da un luogo all’altro con la coltura. Queste antiche aliene, ormai tanto<br />
assimilate e simbolizzate nella nostra cultura da essere percepite, nel male e nel bene, come in<strong>di</strong>gene,<br />
costituiscono un argomento controcorrente rispetto alle attuali posizioni <strong>di</strong> prevenzione antiglobal.<br />
Esse, infatti, sono state completamente rivalutate in funzione del recupero <strong>di</strong> quell’agrobio<strong>di</strong>versità che<br />
per millenni ha caratterizzato l’economia rurale del nostro settore geografico.<br />
PREVISTE, IMPREVISTE, ARCHEOFITE, NEOFITE<br />
Il quadro della vegetazione sinantropica e dei suoi effetti sull’ambiente, sul paesaggio, sull’economia e<br />
sulla qualità della vita umana rimase sostanzialmente immutato fino agli inizi del secolo XVII. In questo<br />
periodo andavano configurandosi le premesse <strong>di</strong> un cambiamento politico-economico globale, il<br />
primo della storia a segnare un passo epocale nei confronti dell’ambiente (escludendo le deforestazioni<br />
d’epoca preromana, romana, rinascimentale e postrinascimentale, che non compromisero mai la<br />
naturale resilienza della vegetazione). La scoperta dell’America, avvenuta poco più <strong>di</strong> un secolo<br />
prima, aveva stimolato in tutta Europa un fermento <strong>di</strong> rinnovo alla ricerca non solo <strong>di</strong> potenziali terre<br />
promesse, ma anche <strong>di</strong> nuove fonti <strong>di</strong> benessere e <strong>di</strong> miglioramento della vita in<strong>di</strong>viduale e sociale. In<br />
particolare, spingeva in tale <strong>di</strong>rezione il ripetersi quasi cadenzato <strong>di</strong> due antichi flagelli, <strong>di</strong> norma tra loro<br />
connessi: le epidemie <strong>di</strong> piante e animali alla base dell’alimentazione e le carestie. Attraverso impatti<br />
umani tutt’altro che indolori, nacquero dunque le prime colonie, ma sarà soprattutto tra Settecento e<br />
Ottocento che queste raggiungeranno il massimo della <strong>di</strong>ffusione sull’intero globo. Furono proprio le<br />
colonie a garantire la possibilità <strong>di</strong> introdurre in Europa (e viceversa) una quantità incre<strong>di</strong>bile <strong>di</strong> piante<br />
<strong>di</strong> interesse economico, effettivo o potenziale; alcune, per esempio, arrivarono in soccorso <strong>di</strong> catastrofi<br />
agrarie, come la vite americana contro la fillossera, o <strong>di</strong> carestie alimentari, come la patata. Un canale<br />
privilegiato hanno sempre avuto le piante me<strong>di</strong>cinali, con ampia sperimentazione colturale negli orti<br />
botanici; comunque gli orti botanici svolgevano funzione acclimatatoria per tutte le piante <strong>di</strong> cui i<br />
singoli governi pianificavano l’introduzione a fini economici (Visconti, 2008), mentre quelle <strong>di</strong> interesse<br />
ornamentale-floricolturale soggiornavano spesso nelle proprietà <strong>di</strong> appassionati e <strong>di</strong> personaggi<br />
illuminati del mondo culturale dell’epoca. In Lombar<strong>di</strong>a, il conte Luigi Castiglioni, sul finire del ‘700 e<br />
Alessandro Manzoni, nella prima metà dell’‘800, contribuirono attivamente alla <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> essenze<br />
da poco introdotte dal Nordamerica, quali la quercia rossa (Quercus rubra), il “northern pitch pine” (Pinus<br />
rigida) e la già citata robinia.<br />
In ogni modo, il successo acclimatativo e il vantaggio economico sperato sod<strong>di</strong>sfarono le attese in<br />
ben pochi casi sul totale <strong>di</strong> quelli sperimentati, ma tanto bastò per innescare cambiamenti ambientali<br />
<strong>di</strong> portata fino allora sconosciuta. Para<strong>di</strong>gmatici, al riguardo, i casi dell’ailanto (Ailanthus altissima) e<br />
della robinia: con la loro naturalizzazione, a partire dal secolo scorso, hanno cambiato il volto della<br />
vegetazione e del paesaggio in Europa, come in altre parti del mondo; e <strong>di</strong>re che l’ailanto si rivelò ben<br />
presto inutile agli scopi per i quali era stato introdotto.<br />
Finora si è parlato <strong>di</strong> piante introdotte su progetto, ma non bisogna <strong>di</strong>menticare che <strong>di</strong> pari passo aliene<br />
impreviste e incontrollate andarono via via conquistando il territorio: opportuniste capaci <strong>di</strong> sfruttare<br />
i movimenti umani a lunga <strong>di</strong>stanza per trasferirsi da un continente all’altro attraverso il terreno delle<br />
colture, gli imballaggi commerciali, i tessuti, i mangimi per uccelli, le sementi, la risicoltura, il mercato<br />
degli acquari, l’ortofloricoltura ecc. Queste inattese clandestine costituiscono oggi una quota importante<br />
del contingente alieno e provengono da tutto il mondo; la fase significativa del loro incremento non<br />
coincise con le colonie, ma con l’era post-industriale, essenzialmente in or<strong>di</strong>ne alla facilitazione logistica<br />
degli scambi commerciali e degli spostamenti umani sul pianeta. Vi è anche il caso, in vero poco<br />
comune, <strong>di</strong> piante domestiche d’antica data come il riso (Oryza sativa), che tutt’a un tratto, in parte,<br />
imparano a riabilitare qualche carattere tacitato dalla domesticazione, presente nell’antenato selvatico<br />
(O. rufipogon); se il carattere è, appunto, un <strong>di</strong>spositivo chiave dell’auto<strong>di</strong>sseminazione (le spighette si<br />
staccano spontaneamente dalla pianta a maturità), ecco che compaiono in<strong>di</strong>vidui selvatici (ferali) in<br />
grado <strong>di</strong> riprodursi attivamente e infestare la stessa coltura. Conosciuti con il nome <strong>di</strong> “riso crodo”. Si<br />
può <strong>di</strong>re che in questo caso l’aliena viene introdotta in<strong>di</strong>rettamente, attraverso la coltura del domestico.<br />
In conclusione, possiamo contestualizzare la storia delle piante aliene in quattro tappe principali: nascita<br />
dell’agricoltura, scoperta dell’America, periodo delle colonie, rivoluzione industriale. Ma l’elemento<br />
<strong>di</strong>scriminante, in termini <strong>di</strong> risposta ambientale e paesaggistica, sta nella scoperta dell’America; solo<br />
12 13