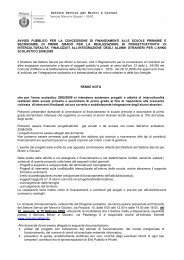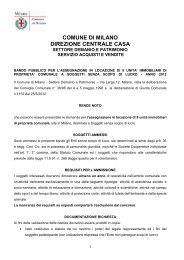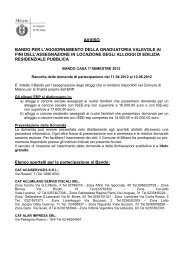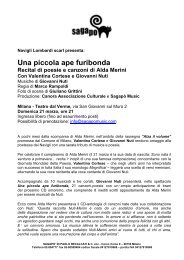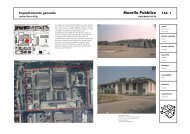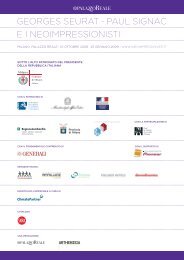LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
galinsoga<br />
comune<br />
Tipo biologico: Tscap<br />
Descrizione: Pianta erbacea annuale, alta 10-50 cm, a fusto eretto, striato, ramificato, nella parte superiore con peli semplici,<br />
eretto-patenti o appressati e ra<strong>di</strong> peli ghiandolari. Foglie opposte, semplici, con picciolo <strong>di</strong> 1-2 cm e lamina ovato-rombica<br />
o rombico-lanceolata, scabra, grossolanamente dentata, verde-giallastra, acuminata all’apice, percorsa da 3 nervi evidenti.<br />
Capolini (calati<strong>di</strong>) del <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> circa 5 mm, con involucro emisferico, su peduncoli glabri o con rari peli ghiandolari; fiori<br />
periferici 5-6, ligulati, bianchi, tridentati, quelli del <strong>di</strong>sco tubulosi e gialli; i fiori alla base sono involucrati da una squama<br />
(paglietta) lineare, tridentata all’apice. Frutti consistenti in acheni pelosi, con pappo dei fiori tubulosi formato da numerose<br />
scaglie frangiate, più brevi o subeguali alla corolla.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: agosto-<strong>di</strong>cembre.<br />
Area d’origine: Sudamerica.<br />
Habitat: Colture (mais, patata, vigneti ecc.), campi abbandonati, incolti, margini, aree urbane.<br />
Distribuzione nel territorio: Ovunque, dalla fascia planiziale a quella montana. Bergamo (INV), Brescia (INV), Cremona<br />
(NAT), Lecco (NAT), Lo<strong>di</strong> (NAT), Monza e Brianza (NAT), <strong>Milano</strong> (NAT), Mantova (NAT), Pavia (NAT), Sondrio (INV), Varese (NAT).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, citata per l’Orto Botanico <strong>di</strong> Padova nel 1801 ed in seguito <strong>di</strong>ffusasi rapidamente in tutta la<br />
penisola. Conosciuta in Lombar<strong>di</strong>a almeno dal 1847 (Rota, 1847).<br />
Modalità d’introduzione: Deliberata (Orti Botanici), con successiva <strong>di</strong>ffusione accidentale.<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: Sì.<br />
Impatto: Riduce la produttività delle colture agrarie estive e mo<strong>di</strong>fica il paesaggio naturale, determinando un decremento <strong>di</strong><br />
bio<strong>di</strong>versità delle comunità erbacee strutturate. È pianta <strong>di</strong> grande adattabilità e alligna su qualsiasi tipo <strong>di</strong> suolo, in particolare<br />
su quelli profon<strong>di</strong>, più o meno umi<strong>di</strong> e ricchi <strong>di</strong> nutrienti.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: Consigliate solo in ambito agrario.<br />
Note: Molto simile a e spesso convivente con G. quadrira<strong>di</strong>ata (ve<strong>di</strong> scheda), <strong>di</strong>stinta per la pubescenza e la pelosità ghiandolare abbondanti, per<br />
i capolini maggiori (6-7 mm) e per le pagliette acute, intere all’apice.<br />
Bibliografia: Camoletto Pasin & Dal Vesco, 1992; Canne, 1977, 1978; Giacomini, 1950; Rota, 1847<br />
Famiglia: Asteraceae<br />
Nome scientifico: Galinsoga parviflora Cav.<br />
Nome volgare: galinsoga comune<br />
Sinonimi: Galinsoga quinquera<strong>di</strong>ata Ruiz & Pav.<br />
Wiborgia parviflora (Cav.) Kunth<br />
galinsoga<br />
ispida<br />
Tipo biologico: Tscap<br />
Descrizione: Pianta erbacea annuale, alta 10-50 cm, con fusti eretti, striati, ramificati, pubescenti e con densi peli ghiandolari<br />
nella parte superiore. Foglie opposte, semplici, con picciolo <strong>di</strong> 1-2 cm, con lamina rombico-lanceolata, ruvida, grossolanamente<br />
dentata, verde-giallastra, tutte con apice acuminato e con 3 nervature principali. Capolini (calati<strong>di</strong>) <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro pari a 6-7 mm;<br />
peduncolo ghiandoloso; involucro emisferico; fiori periferici (5-6) ligulati, bianchi, tridentati, quelli del <strong>di</strong>sco tubulosi e gialli;<br />
i fiori sono accompagnati alla base da una squama (paglietta) lineare, intera all’apice. Frutti ad achenio peloso, quelli derivanti<br />
dai fiori tubulosi con un pappo <strong>di</strong> squame sfrangiate, più brevi della corolla o della stessa lunghezza.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: agosto-<strong>di</strong>cembre.<br />
Area d’origine: Sudamerica.<br />
Habitat: Colture, ambienti ruderali e semiruderali (sentieri, strade rurali, macerie, aree abbandonate, base dei muri ed e<strong>di</strong>fici,<br />
ferrovie e scarpate), orti, parchi, tappeti erbosi, giar<strong>di</strong>ni, viali e lungo i fiumi.<br />
Distribuzione nel territorio: Ampiamente <strong>di</strong>ffusa nel territorio regionale, dalla fascia planiziale a quella montana. Bergamo<br />
(INV), Brescia (INV), Como (INV), Cremona (INV), Lecco (INV), Lo<strong>di</strong> (INV), Monza e Brianza (INV), <strong>Milano</strong> (INV), Mantova (INV),<br />
Pavia (INV), Sondrio (INV), Varese (INV).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, introdotta in Italia a metà del XIX secolo: coltivata nell’Orto Botanico <strong>di</strong> Firenze nel 1854, in<br />
quello <strong>di</strong> Padova nel 1893 ove si era inselvatichita. In Italia <strong>di</strong>ffusasi in natura (Italia settentrionale) negli anni ‘40 del secolo scorso,<br />
probabilmente in seguito ai movimenti delle truppe tedesche; conosciuta in Lombar<strong>di</strong>a almeno dal 1945 (Giacomini, 1946).<br />
Modalità d’introduzione: Deliberata (Orti Botanici), con successiva <strong>di</strong>ffusione accidentale.<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: Sì.<br />
Impatto: Riduce la produttività delle colture agrarie estive e mo<strong>di</strong>fica il paesaggio naturale, determinando un decremento <strong>di</strong><br />
bio<strong>di</strong>versità delle comunità erbacee strutturate. È pianta <strong>di</strong> grande adattabilità e alligna su qualsiasi tipo <strong>di</strong> suolo, in particolare<br />
su quelli profon<strong>di</strong>, più o meno umi<strong>di</strong> e ricchi <strong>di</strong> nutrienti.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: Consigliate solo in ambito agrario.<br />
Note: Molto simile a e spesso convivente con G. parviflora (ve<strong>di</strong> scheda), che possiede peli semplici e appressati nella parte superiore del fusto, non<br />
ha che pochissimi peli ghiandolari, presenta capolini più piccoli (<strong>di</strong>ametro intorno a 5 mm) e pagliette dei fiori con apice tridentato.<br />
Il genere Galinsoga è stato revisionato da Canne (1977, 1978), anche se tali lavori non sono stati presi in considerazione da numerose flore<br />
successive; per un riassunto relativo alle uniche due specie infestanti in tutti i paesi temperati sinora raggiunti si veda Camoletto Pasin & Dal Vesco<br />
(1992). Pertanto, oltre a riaffermare la completa sinonimia tra G. ciliata e G. quadrira<strong>di</strong>ata, con priorità per il secondo binomio, si ricorda che le<br />
<strong>di</strong>verse forme, varietà e ibri<strong>di</strong> descritti e segnalati in Italia e Lombar<strong>di</strong>a (es. Giacomini, 1950; Zanotti, 2003) non sono accettabili. Nella zona d’origine<br />
non sono mai stati osservati veri ibri<strong>di</strong>, ma tutte le forme presumibilmente interme<strong>di</strong>e sono risultate rientrare nell’ampia variabilità del poliploide<br />
G. quadrira<strong>di</strong>ata; anche l’entità descritta da Giacomini (1950) come presunto ibrido col nome <strong>di</strong> G. ×plikeri (tra l’altro priva <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnosi latina; il nome<br />
corretto è Galinsoga ×mixta) rientra, in base alla descrizione in italiano, in G. quadrira<strong>di</strong>ata (Canne, 1977).<br />
Bibliografia: Bonali, 2008; Galasso & Bonali, 2008<br />
Famiglia: Asteraceae<br />
Nome scientifico: Galinsoga quadrira<strong>di</strong>ata Ruiz & Pav.<br />
Nome volgare: galinsoga ispida<br />
Sinonimi: Adventina ciliata Raf.<br />
Galinsoga ×mixta Murr<br />
Galinsoga ×plikeri Giacom., nom. nud.<br />
Galinsoga aristulata E.P.Bicknell<br />
Galinsoga hispida (DC.) Hieron., non Benth., nom. illeg.<br />
Galinsoga hispida Benth.<br />
Galinsoga parviflora Cav. subsp. quadrira<strong>di</strong>ata (Ruiz. & Pav.) Pers<br />
Galinsoga parviflora Cav. var. hispida DC.<br />
Galinsoga parviflora Cav. var. quadrira<strong>di</strong>ata (Ruiz. & Pav.) Poir.<br />
Galinsoga quadrira<strong>di</strong>ata Ruiz & Pav. subsp. hispida (DC.) Thell.<br />
242 243