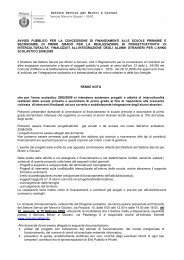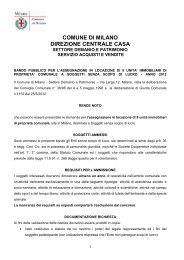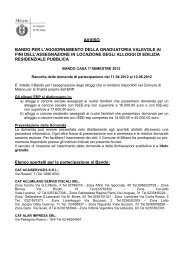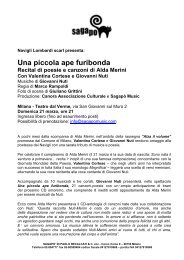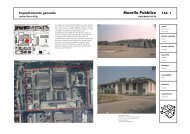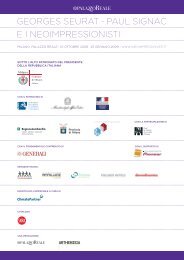LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
poligono<br />
della<br />
pennsylvania<br />
Famiglia: Polygonaceae<br />
Nome scientifico: Persicaria pensylvanica (L.) M.Gómez<br />
Nome volgare: poligono della Pennsylvania<br />
Basionimo: Polygonum pensylvanicum L.<br />
Tipo biologico: Tscap<br />
Descrizione: Pianta erbacea annuale, alta 10-200 cm, con fusto ascendente o eretto, glabro o <strong>di</strong>stalmente provvisto <strong>di</strong><br />
pubescenza appressata o peli ghiandolari. Foglie alterne con ocrea (guaina tubolare derivata dalla fusione delle stipole,<br />
tipica delle Polygonaceae) lunga 5-20 mm, brunastra, troncata all’apice, non fimbriata (o con fimbrie brevissime); lamina<br />
lanceolata, 4-17(-23)×(0.5-)1-4.8 cm, a volte con una chiazza scura a V rovesciata sulla pagina superiore e con ghiandole<br />
sull’inferiore, subsessile o con breve picciolo lungo fino a 0.1-2(-3) cm. Infiorescenze spiciformi, terminali e ascellari, dense,<br />
erette o raramente nutanti, lunghe 0.5-5 cm, con ghiandole stipitate; perianzio da bianco-verdastro a rosato. Il frutto è un<br />
achenio <strong>di</strong>scoidale, raramente trigono, lungo 2.1-3.4 mm, marrone o nero, lucido.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: giugno-settembre.<br />
Area d’origine: Nordamerica.<br />
Habitat: Sabbia umida, ciottoli e pietrisco, sui greti.<br />
Distribuzione nel territorio: In espansione lungo il Ticino, il Po e i principali fiumi (0-500 m s.l.m.). Bergamo (NAT), Cremona<br />
(NAT), <strong>Milano</strong> (INV), Varese (INV).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, segnalata per la prima volta in Italia (Friuli-Venezia Giulia) da Melzer (1988), in Lombar<strong>di</strong>a<br />
da Banfi & Galasso (2005); in seguito Brusa & Galasso (2006) ne hanno precisato l’areale lombardo. Le prime osservazioni<br />
regionali risalgono al 2002.<br />
Modalità d’introduzione: Accidentale.<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: Potenzialmente.<br />
Impatto: Deprime la bio<strong>di</strong>versità delle cenosi in cui si inse<strong>di</strong>a, a scapito delle specie autoctone.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: Le uniche azioni proponibili rientrano nel quadro <strong>di</strong> un recupero generale degli ambienti umi<strong>di</strong>.<br />
Note: Specie allotetraploide e morfologicamente variabile, al cui interno gli autori nordamericani hanno spesso accettato 3-4 varietà, che risultano<br />
tuttavia basate su caratteri non costanti (sia fra le popolazioni sia al loro interno) e quin<strong>di</strong> sistematicamente non significative (Hinds & Freeman,<br />
2005). Può essere confusa con l’autoctona P. lapathifolia (L.) Delarbre, dalla quale si <strong>di</strong>stingue agevolmente per i fiori più gran<strong>di</strong>, le infiorescenze<br />
pressoché erette e la presenza <strong>di</strong> evidenti peli ghiandolari (col peduncolo > del <strong>di</strong>ametro della ghiandola) sulla parte superiore del fusto, sui rami<br />
dell’infiorescenza e sui pe<strong>di</strong>celli fiorali; inoltre i tepali esterni hanno nervature non prominenti e non terminanti ad ancora.<br />
In Lombar<strong>di</strong>a è stata osservata come casuale P. orientalis (L.) Spach (= Polygonum o. L.; poligono orientale), coltivata per ornamento e avventizia<br />
presso le abitazioni, che si <strong>di</strong>stingue per le foglie ovate, larghe 3-17 cm, con l’ocrea all’apice espansa in un’ala fogliacea verde. Nel limitrofo Veneto è<br />
presente anche P. bungeana (Turcz.) Nakai (= Polygonum b. Turcz.; poligono <strong>di</strong> Bunge), infestante le colture <strong>di</strong> mais, caratterizzata dal fusto provvisto<br />
<strong>di</strong> spinule ricurve (Galasso & Tomasi, 2007).<br />
Bibliografia: Banfi & Galasso, 2005; Brusa & Galasso, 2006; Galasso, 2009; Galasso & Tomasi, 2007; Hinds & Freeman, 2005; Melzer, 1988<br />
poligono<br />
<strong>di</strong> boemia<br />
Famiglia: Polygonaceae<br />
Nome scientifico: Reynoutria bohemica Chrtek & Chrtková, pro hybr.<br />
Nome volgare: poligono <strong>di</strong> Boemia<br />
Sinonimo: Fallopia bohemica (Chrtek & Chrtková) J.P.Bailey, pro hybr.<br />
Polygonum bohemicum (Chrtek & Chrtková) Zika & Jacobson, pro hybr.<br />
Reynoutria ×vivax auct., non J.Schmitz & Strank<br />
Fallopia japonica × sachalinensis<br />
Tipo biologico: Grhiz<br />
Descrizione: Pianta erbacea perenne, rizomatosa, alta fino a 2-3(-3.5) m, con fusti eretti e ramificati. Foglie alterne con ocrea<br />
(guaina tubolare derivata dalla fusione delle stipole, tipica delle Polygonaceae) lunga 4-6(-10) mm, bruna, obliqua all’apice,<br />
non fimbriata; lamina ovata, (15-)20-25(-30)×12-20(-23) cm, leggermente cordata o cordato-troncata alla base e lungamente<br />
acuminata all’apice, non o solo leggermente cuspidato-caudata; nervature della pagina inferiore con peli unicellulari, corti e<br />
rigi<strong>di</strong>, ingrossati alla base; nervature terziarie e quaternarie poco visibili sulla pagina superiore; picciolo <strong>di</strong> 1-3 cm, alla base con<br />
una fossetta nettarifera sul lato esterno. Infiorescenze panicoliformi, lunghe 4-12 cm, ascellari e terminali; fiori funzionalmente<br />
unisessuali (su una stessa pianta possono essere presenti entrambi i tipi <strong>di</strong> fiori o soltanto quelli femminili); tepali 5, bianchi<br />
o bianco-verdastri, i 3 esterni leggermente alati e accrescenti nel frutto; stami 8, sporgenti dai tepali (nei fiori maschili) o più<br />
brevi e ridotti a stamino<strong>di</strong> (in quelli femminili). Il frutto è un achenio marrone scuro, trigono, lungo 2.6-3.2 mm, liscio e lucido.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: luglio-ottobre.<br />
Area d’origine: Sconosciuta, probabilmente orticola (in Europa).<br />
Habitat: Fiumi, margini, incolti.<br />
Distribuzione nel territorio: Lombar<strong>di</strong>a occidentale, nelle fasce planiziale e collinare (50-600 m s.l.m.). Monza e Brianza<br />
(INV), <strong>Milano</strong> (INV), Pavia (INV), Varese (INV).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, introdotta od originatasi in Europa a fine Ottocento: esiste un campione raccolto in<br />
Inghilterra nel 1872 (Bailey & Conolly, 2000). In Italia è naturalizzata forse già dal 1933, anche se i primi campioni d’erbario visti<br />
sono del 1977; i primi campioni lombar<strong>di</strong> sono del 2006 (Vaccaneo 1933, Padula et al., 2008). Segnalata per la prima volta in<br />
Italia (e in Lombar<strong>di</strong>a) da Garibol<strong>di</strong> et al., (2007) e Padula et al. (2008).<br />
Modalità d’introduzione: Deliberata, per floricoltura.<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: Sì.<br />
Impatto: I popolamenti densi che forma costituiscono ovunque una minaccia per le flore e le vegetazioni in<strong>di</strong>gene,<br />
causando una per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> bio<strong>di</strong>versità. È specie inclusa nella lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto <strong>di</strong> monitoraggio,<br />
contenimento o era<strong>di</strong>cazione, allegata alla l.r. 10/2008 della Lombar<strong>di</strong>a.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: È specie <strong>di</strong>fficile da eliminare, in quanto ogni pianta produce rizomi in un raggio <strong>di</strong> 7 m e fino a<br />
una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> 3 m. Bisogna cercare innanzitutto <strong>di</strong> non <strong>di</strong>ffondere i rizomi: piccoli frammenti possono dare vita a nuovi<br />
in<strong>di</strong>vidui. Tutte le parti della pianta devono essere incenerite, in nessun caso compostate. Secondo quanto riportato sul sito<br />
svizzero CPS (http://www.cps-skew.ch/), le strategie per impe<strong>di</strong>re l’espansione dei poligoni comprendono la lotta meccanica<br />
(con tagli mensili per almeno 5 anni consecutivi che indeboliscano i rizomi), il pascolo caprino e ovino, la lotta chimica.<br />
Note: Il genere Reynoutria è estremamente variabile per morfologia e numero cromosomico, originando così una confusione tassonomica e<br />
una <strong>di</strong>fficoltà nel determinare i limiti tra le specie; inoltre l’ibridazione infraspecifica è relativamente comune. Il carattere <strong>di</strong>acritico principale<br />
per il riconoscimento delle specie è quello relativo alla forma delle lamine delle foglie me<strong>di</strong>ane del fusto, che purtroppo solo raramente sono<br />
raccolte e conservate negli erbari. Inoltre può essere presa in considerazione la pelosità della pagina inferiore, mentre quella della superiore e<br />
dei margini non è <strong>di</strong>agnostica. I peli possono essere osservati agevolmente fin verso metà settembre, soprattutto lungo le nervature della metà<br />
inferiore della lamina; in seguito tendono a cadere. Tuttavia, in alcuni casi (probabilmente nelle aree meno piovose o maggiormente soleggiate)<br />
questa caduta è molto precoce, realizzandosi già all’inizio <strong>di</strong> agosto. Questa entità è generalmente considerata un ibrido. In effetti deriva da R.<br />
japonica × sachalinensis e si riproduce prevalentemente per via vegetativa (fusti e rizomi) essendo per lo più sterile; tuttavia ha ormai raggiunto<br />
un comportamento autonomo completamente svincolato dalle specie parentali e maggiormente invadente <strong>di</strong> esse nelle comunità naturali,<br />
mostrando quin<strong>di</strong> le caratteristiche <strong>di</strong> una vera e propria specie.<br />
Bibliografia: Bailey, 2008; Bailey & Conolly, 2000; Barney et al., 2006; Beerling et al., 1994; Garibol<strong>di</strong> et al., 2007; Padula et al., 2008; Vaccaneo, 1933<br />
180 181