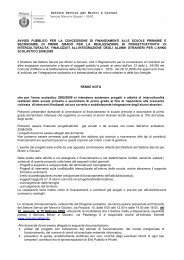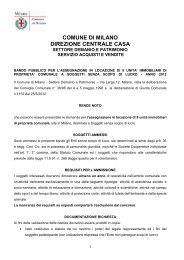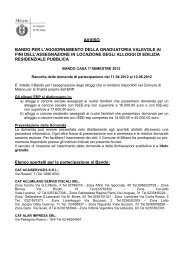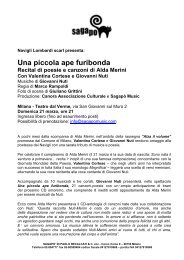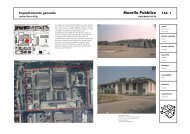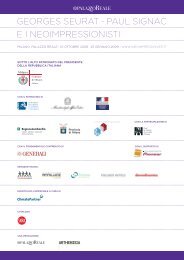LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
acetosella<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>llenius<br />
Tipo biologico: Hscap<br />
Descrizione: Pianta erbacea perenne <strong>di</strong> breve durata, con fusti esili, cespitosi, alti fino a 20(-30) cm, ascendenti, provvisti<br />
<strong>di</strong> peli unicellulari, spesso ginocchiati ma non ra<strong>di</strong>canti ai no<strong>di</strong>. Stipole presenti, oblunghe, caduche; foglie verde chiaro,<br />
prevalentemente opposte o in verticilli, con picciolo <strong>di</strong> 10-25 mm e lamina <strong>di</strong>visa in 3 segmenti largamente obcordati, <strong>di</strong> 10-<br />
13×7-9 mm, spesso ripiegati in basso verso il picciolo. Infiorescenza (cima) umbellata; peduncoli fiorali lunghi 1-2 cm, patenti<br />
o eretti, allungantisi nel frutto; brattee <strong>di</strong> 0.8-2 mm; calice <strong>di</strong> 5 sepali lanceolati, lunghi 4 mm; petali 5, gialli, obovato-spatolati,<br />
lunghi 4-8 mm; stami 10 in due verticilli; ovario supero, 5-loculare. I frutti sono capsule (deiscenza esplosiva) prismatiche, a<br />
sezione pentagonale, <strong>di</strong> 8-20×2-3 mm, erette all’estremità <strong>di</strong> peduncoli ripiegati verso il basso, con cui si articolano ad angolo<br />
acuto; semi con 8-10 creste trasversali segnate da una linea bianca.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: aprile-ottobre.<br />
Area d’origine: Nordamerica orientale.<br />
Habitat: Incolti erbosi, campi, orti, margini, ruderati, marciapie<strong>di</strong> ecc.<br />
Distribuzione nel territorio: Ovunque, nelle fasce planiziale e collinare. Bergamo (INV), Brescia (INV), Como (INV), Cremona<br />
(NAT), Lecco (INV), Lo<strong>di</strong> (NAT), Monza e Brianza (INV), <strong>Milano</strong> (INV), Mantova (INV), Pavia (INV), Sondrio (NAT), Varese (INV).<br />
[O. stricta: Bergamo (INV), Brescia (INV), Como (NAT), Cremona (NAT), Lecco (NAT), Lo<strong>di</strong> (NAT), Monza e Brianza (NAT), <strong>Milano</strong><br />
(NAT), Mantova (NAT), Pavia (INV), Sondrio (NAT), Varese (NAT).]<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, introdotta in Italia in un periodo non noto in quanto spesso confusa con O. stricta<br />
(conosciuta in Italia dal Cinquecento). Segnalata per la prima volta in Lombar<strong>di</strong>a da Zucchetti et al. (1986).<br />
Modalità d’introduzione: Accidentale.<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: No.<br />
Impatto: Infestante delle colture sarchiate e negli orti.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: Eventuale <strong>di</strong>serbo nelle colture.<br />
Note: Questa specie è stata spesso confusa, anche sul piano nomenclaturale, con l’acetosella minore, O. stricta L. (= O. fontana Bunge,<br />
= O. europaea Jord.), anch’essa invasiva in Lombar<strong>di</strong>a e proveniente dalla stessa area geografica <strong>di</strong> partenza. Si <strong>di</strong>stingue inequivocabilmente per<br />
i seguenti piccoli, ma consistenti caratteri (Young, 1958; Stace, 1997): 1) stipole assenti (osservare sempre esemplari giovani!); 2) alcuni peli del<br />
fusto settati (pluricellulari); 3) infiorescenza cimosa, non umbellata; 4) peduncoli fruttiferi e capsule in asse (articolazione a 180° o poco meno),<br />
generalmente eretti o patenti, mai riflessi; 5) creste trasversali dei semi senza o con debole linea bianca; 6) presenza facoltativa <strong>di</strong> stoloni sotterranei<br />
biancastri molto fragili; 7) fusti facoltativamente ra<strong>di</strong>canti ai no<strong>di</strong>. Per la corretta applicazione dell’epiteto <strong>di</strong>llenii si veda Watson (1989).<br />
Bibliografia: Conti et al., 2007; Stace, 1997; Watson, 1989; Young, 1958; Zucchetti et al., 1986<br />
Famiglia: Oxalidaceae<br />
Nome scientifico: Oxalis <strong>di</strong>llenii Jacq.<br />
Nome volgare: acetosella <strong>di</strong> Dillenius<br />
Sinonimi: Acetosella stricta auct., non (L.) Kuntze<br />
Oxalis corniculata L. var. <strong>di</strong>llenii (Jacq.) Trel.<br />
Oxalis corniculata L. subsp. navierei (Jord.) Tourlet<br />
Oxalis <strong>di</strong>ffusa Boreau, non Boenn. / Oxalis boreaui P.Fourn.<br />
Oxalis navierei Jord.<br />
Oxalis stricta auct., non L.<br />
Xanthoxalis <strong>di</strong>llenii (Jacq.) Holub<br />
Xanthoxalis stricta auct., non (L.) Small<br />
acaliFa<br />
meri<strong>di</strong>onale<br />
Tipo biologico: Tscap<br />
Descrizione: Pianta erbacea annuale alta 20-50 cm, con fusto eretto e rametti pelosi. Foglie con stipole lanceolate, lunghe<br />
1.5-2 mm; picciolo <strong>di</strong> 2-6 cm; lamina da oblungo-ovata a ovato-rombica o anche largamente lanceolata, <strong>di</strong> 3-9×1-5 cm,<br />
pelosa lunga le nervature abassialmente, adassialmente glabra, con base cuneata (raramente ottusa), margine crenato e apice<br />
brevemente acuminato. Fiori unisessuali (pianta monoica) in infiorescenze bisessuali <strong>di</strong> norma ascellari, lunghe 1.5-5 cm, su<br />
peduncoli <strong>di</strong> 0.5-3 cm; brattee femminili 1-2(-4), prossimali, ovate, cordate, accrescenti nel frutto fino a 1.4-2.5×1-2 cm, pelose,<br />
con margine crenato, ciascuna sottendente 1-3 fiori sessili a 3 sepali strettamente ovati, pelosi e ovario triloculare, peloso, con<br />
3 stili lunghi circa 2 mm, sfrangiati in 5-7 lacinie; brattee maschili condensate nella porzione <strong>di</strong>stale, ovate, piccole (0.5 mm),<br />
ognuna sottendente 5-7 fiori su peduncoli <strong>di</strong> 0.5 mm; fiori maschili a 4 sepali <strong>di</strong> circa 0.5 mm e (7-)8 stami. Il frutto è una<br />
capsula triloculare, globosa, del <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> circa 4 mm, pelosa e tubercolata; semi subovoi<strong>di</strong>, lisci, <strong>di</strong> 1.5-2 mm.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: aprile-<strong>di</strong>cembre.<br />
Area d’origine: Asia orientale.<br />
Habitat: Margini erbosi, marciapie<strong>di</strong>, zone ruderali.<br />
Distribuzione nel territorio: Presenze spora<strong>di</strong>che in ambito planiziale. Brescia (NAT), Cremona (NAT), Lecco (NAT), Monza e<br />
Brianza (NAT), <strong>Milano</strong> (NAT), Pavia (NAT).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, segnalata per la prima volta in Italia a Genova (Minuto, 1993b). In Lombar<strong>di</strong>a è stata<br />
segnalata per la prima volta da Banfi & Galasso (1998) come A. in<strong>di</strong>ca e con questo nome errato (in seguito rettificato da Banfi<br />
& Galasso, 2005; Zanotti, 2008) in<strong>di</strong>cata anche da Tagliaferri (2000) per il bresciano; la prima raccolta (sia lombarda che italiana)<br />
è del 1985 a Monza (campione conservato nell’erbario del Museo <strong>di</strong> Storia Naturale <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>, MSNM).<br />
Modalità d’introduzione: Accidentale (probabilmente con l’attività vivaistica).<br />
Status: Naturalizzata.<br />
Dannosa: No.<br />
Impatto: Irrilevante.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: Al momento non necessarie.<br />
Note: Si <strong>di</strong>stingue da A virginica (ve<strong>di</strong> scheda) per le brattee femminili intere, solamente crenate.<br />
Bibliografia: Banfi & Galasso, 1998, 2005; Minuto, 1993b; Tagliaferri, 2000; Zanotti, 2008<br />
Famiglia: Euphorbiaceae<br />
Nome scientifico: Acalypha australis L.<br />
Nome volgare: acalifa meri<strong>di</strong>onale<br />
Sinonimi: Acalypha in<strong>di</strong>ca auct., non L.<br />
136 137