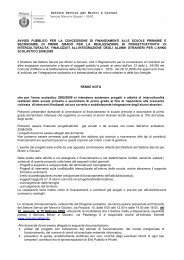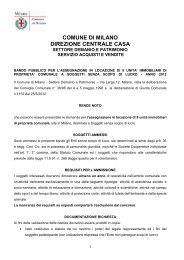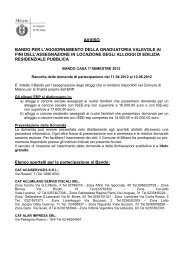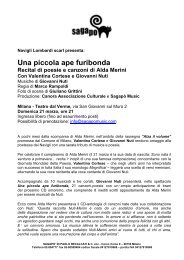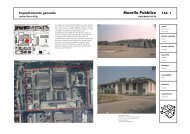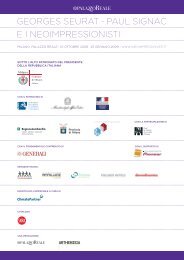LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
poligono<br />
cespitoso<br />
Tipo biologico: Tcaesp<br />
Descrizione: Pianta erbacea annuale, alta 30-80 cm, densamente cespitosa, con fusti ramificati dalla base, glabri, con rami<br />
decombenti e ascendenti, ra<strong>di</strong>canti ai no<strong>di</strong> basali. Foglie alterne con ocrea (guaina tubolare derivata dalla fusione delle<br />
stipole, tipica delle Polygonaceae) lunga 5-12 mm, ialina o bruno chiara, troncata all’apice, fimbriata; lamina a forma <strong>di</strong> rombo<br />
allungato, 2-8×1-3 cm, pagina inferiore senza ghiandole e superiore senza macchia nera, subsessile o con breve picciolo<br />
lungo fino a 0.1-0.3(-0.6) cm. Infiorescenze spiciformi, terminali e ascellari, lasse e interrotte, lunghe 1-4(-8) cm; perianzio rosa.<br />
Il frutto è un achenio trigono, lungo 1.6-2.3 mm, marrone scuro o nero, lucido.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: maggio-ottobre.<br />
Area d’origine: Asia orientale.<br />
Habitat: Margini <strong>di</strong> sentieri boschivi.<br />
Distribuzione nel territorio: Brianza (150-300 m s.l.m.). Monza e Brianza (NAT).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, introdotta in Italia in periodo imprecisato, probabilmente verso la fine del XX secolo.<br />
Segnalata per la prima volta in Italia e in Lombar<strong>di</strong>a da Galasso (2007), i primi campioni raccolti in natura sono del 2006.<br />
Modalità d’introduzione: Accidentale.<br />
Status: Naturalizzata.<br />
Dannosa: No.<br />
Impatto: Data la modesta <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> questa specie, l’impatto è attualmente trascurabile.<br />
Note: Simile alle autoctone P. dubia, P. hydropiper e P. minor, si <strong>di</strong>stingue agevolmente da queste per l’assenza <strong>di</strong> ghiandole sui tepali e per essere<br />
densamente cespitosa e ramificata, con lunghi rami prostrati e ra<strong>di</strong>canti ai no<strong>di</strong> basali.<br />
Bibliografia: Galasso, 2007, 2009<br />
Famiglia: Polygonaceae<br />
Nome scientifico: Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag.<br />
Nome volgare: poligono cespitoso<br />
Basionimo: Polygonum longisetum Bruijn<br />
Sinonimi: Persicaria blumei (Meisn. ex Miq.) H.Gross<br />
Persicaria caespitosa (Blume) Nakai<br />
var. longiseta (Bruijn) C.F.Reed<br />
Persicaria longiseta (Bruijn) Moldenke, comb. superfl.<br />
Polygonum blumei Meisn. ex Miq.<br />
Polygonum caespitosum Blume<br />
var. longisetum (Bruijn) Steward<br />
poligono<br />
del nepal<br />
Tipo biologico: Tcaesp<br />
Descrizione: Pianta erbacea annuale, alta 5-40 cm, con fusti prostrato-<strong>di</strong>ffusi e ascendenti, ramosissimi, spesso ra<strong>di</strong>canti alla<br />
base. Foglie alterne con ocrea (guaina tubolare derivata dalla fusione delle stipole, tipica delle Polygonaceae) lunga 4-10 mm,<br />
bruna o ialina, cartacea, obliqua all’apice, non fimbriata; lamina triangolare-ovata, 1.5-5×1-4 cm, punteggiata <strong>di</strong> ghiandole<br />
sulla pagina inferiore; foglie inferiori con picciolo lungo fino a 3 cm, alato e auricolato alla base, le superiori subsessili o<br />
abbraccianti il fusto. Infiorescenze capitate, terminali e ascellari, sottese da una brattea fogliacea; perianzio bianco, rosa o<br />
rosso. Il frutto è un achenio biconvesso, lungo 1.5-2 mm, opaco.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: agosto-settembre.<br />
Area d’origine: Asia.<br />
Habitat: Margini <strong>di</strong> sentieri freschi, greti.<br />
Distribuzione nel territorio: Prealpi occidentali (varesino, 200-300 m s.l.m.). Varese (INV).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, introdotta in Italia in periodo imprecisato, probabilmente nel XX secolo. Segnalata per la<br />
prima volta in Italia e in Lombar<strong>di</strong>a da Becherer (1966), che l’ha raccolta nel 1964 sulle rive del Lago <strong>di</strong> Varese; sebbene nel<br />
1972 fosse qui in regresso (Stucchi, 1972) oggi è <strong>di</strong>venuta invasiva in gran parte del varesino.<br />
Modalità d’introduzione: Probabilmente deliberata, per floricoltura.<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: Sì.<br />
Impatto: Forma popolamenti quasi monofitici, lunghi centinaia <strong>di</strong> metri ma soltanto ai margini dei sentieri boschivi e dei<br />
torrenti.<br />
Note: Raramente è coltivata P. microcephala (D.Don) H.Gross (= Polygonum m. D.Don), perenne, più alta e con foglie più lunghe; in commercio è<br />
<strong>di</strong>ffusa la cultivar ‘Red Dragon’ con foglie rosse. Sinora non ha mostrato tendenza ad avventiziare.<br />
Simile è anche P. capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross (= Polygonum c. Buch.-Ham. ex D.Don; poligono capitato). È una pianta perenne, legnosa<br />
alla base, con pagina inferiore delle foglie provvista <strong>di</strong> peli ghiandolari e con acheni trigoni, luci<strong>di</strong>; coltivata per ornamento, è naturalizzata sulla riva<br />
piemontese del Lago Maggiore ma non è stata ancora osservata in Lombar<strong>di</strong>a.<br />
Bibliografia: Becherer, 1966; Galasso, 2009; Stucchi, 1972<br />
Famiglia: Polygonaceae<br />
Nome scientifico: Persicaria nepalensis (Meisn.) H.Gross<br />
Nome volgare: poligono del Nepal<br />
Basionimo: Polygonum nepalense Meisn.<br />
178 179