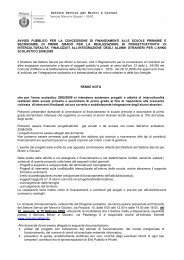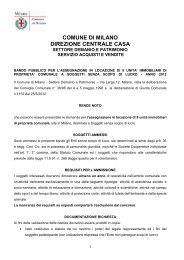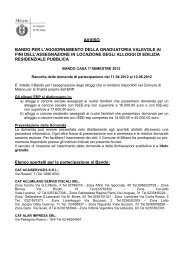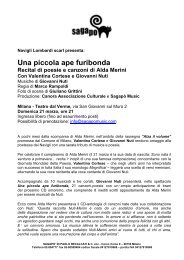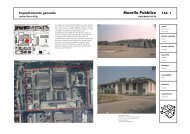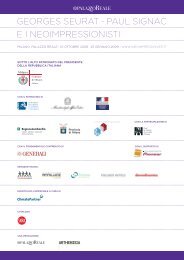LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
astro<br />
squamoso<br />
Famiglia: Asteraceae<br />
Nome scientifico: Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom<br />
Nome volgare: astro squamoso<br />
Basionimo: Conyza squamata Spreng.<br />
Sinonimi: Aster squamatus (Spreng.) Hieron.<br />
Aster subulatus auct., non Michx.<br />
Conyzanthus squamatus (Spreng.) Tamamsch.<br />
Mesoligus subulatus auct., non (Michx.) Raf.<br />
Symphyotrichum subulatum (Michx.) G.L.Nesom<br />
subsp. squamatum (Spreng.) S.D.Sundb.<br />
Symphyotrichum subulatum auct., non (Michx.) G.L.Nesom<br />
Tripolium subulatum auct., non (Michx.) DC.<br />
Tipo biologico: Tscap<br />
Descrizione: Pianta erbacea annuale, alta sino a circa 1 m, con fusti eretti e ramificati. Foglie inferiori assenti alla fioritura, <strong>di</strong><br />
forma lanceolato-lineare, fino a 9×1.4 cm, acute; foglie dei rami fiorali ridotte, lineari-lesiniformi, (20-)100-200×1.5-10(-20)<br />
mm. Capolini aventi un <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> circa 8 mm, portati numerosissimi su rami corimbosi; involucro conico, lungo 5-7(-8)<br />
mm; squame lesiniformi, in numero <strong>di</strong> 18-24(-30), con una porzione verde scuro <strong>di</strong> forma ampiamente lanceolata e non<br />
raggiungente la base della squama; fiori del raggio 21-28(-38) in (2-)3 serie, ligulati e <strong>di</strong> colore biancastro (poi violetto); fiori<br />
del <strong>di</strong>sco (3-)7-14, tubulosi e giallastri. Frutto costituito da un achenio lungo 1.5-2.5 mm, sormontato da un pappo roseo <strong>di</strong><br />
4-5 mm.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: settembre-ottobre.<br />
Area d’origine: Sudamerica.<br />
Habitat: Sponde erbose, ambienti ruderali, umi<strong>di</strong> almeno nella prima parte della stagione.<br />
Distribuzione nel territorio: Distribuito in quasi tutta la Lombar<strong>di</strong>a (50-800 m s.l.m., soprattutto nelle fascia planiziale.<br />
Bergamo (NAT), Brescia (INV), Como (NAT), Cremona (NAT), Lecco (NAT), Lo<strong>di</strong> (NAT), Monza e Brianza (NAT), <strong>Milano</strong> (NAT),<br />
Mantova (NAT), Pavia (NAT).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, conosciuta sin dal 1908 nel giar<strong>di</strong>no dell’Istituto Botanico <strong>di</strong> Panisperma a Roma, dove<br />
mostrava la tendenza a <strong>di</strong>ffondersi nei luoghi più umi<strong>di</strong>; raccolta in natura per la prima volta nel 1927, sempre nel Lazio<br />
(Chiovenda, 1930, 1931; Fiori, 1931). In Lombar<strong>di</strong>a è conosciuta come naturalizzata almeno dal 1985 (Crescini, 1987).<br />
Modalità d’introduzione: Deliberata, in Orto botanico.<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: No.<br />
Impatto: Scarso.<br />
Note: Entità tetraploide (2n = 20) affine alla <strong>di</strong>ploide S. subulatum, alla quale è a volte subor<strong>di</strong>nata come varietà (Sundberg, 2004; Brouillet et al.,<br />
2006); al contrario, Nesom (1994, 2005) preferisce il rango specifico. Considerata la <strong>di</strong>versità del numero cromosomico, la separazione morfologica<br />
e geografica e la elevata sterilità degli ibri<strong>di</strong> artificiali optiamo per la trattazione <strong>di</strong> Nesom.<br />
Bibliografia: Aeschimann et al., 2004; Banfi & Galasso, 1998; Bonali, 2000; Bonali et al., 2006a; Brouillet et al., 2006; Chiovenda, 1930, 1931;<br />
Consonni, 1997; Crescini, 1987; Fiori, 1931; Frattini, 1993; Guarino, 1995; Nesom, 1994, 2005; Sundberg, 2004; Zanotti, 1991b<br />
nappola<br />
comune<br />
Famiglia: Asteraceae<br />
Nome scientifico: Xanthium italicum Moretti<br />
Nome volgare: nappola comune<br />
Sinonimi: Xanthium cavanillesii Schouw<br />
Xanthium echinatum Murray subsp. italicum (Moretti) O.Bolòs & Vigo<br />
Xanthium macrocarpum DC. subsp. italicum (Moretti) Nyman<br />
Xanthium nigri Ces., Pass. & Gibelli<br />
Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter<br />
Xanthium saccharatum Wallr.<br />
Xanthium saccharatum Wallr. subsp. italicum (Moretti) Hayek<br />
Xanthium strumarium L. subsp. cavanillesii (Schouw) D.Löve & Dans.<br />
Xanthium strumarium L. subsp. italicum (Moretti) D.Löve<br />
Tipo biologico: Tscap<br />
Descrizione: Pianta erbacea annuale, abbastanza robusta, alta 30-120 cm, ruvida su fusto e foglie; fusti eretti, ramosissimi alla<br />
base e formanti un cespuglio emisferico, talora arrossati. Foglie con picciolo <strong>di</strong> 5-15 cm e lamina triangolare <strong>di</strong> 7-12×8-12 cm,<br />
palmato-trinervia, dentata e crenata sul bordo, troncato-cuneata alla base. Fiori in infiorescenze particolari (ve<strong>di</strong> scheda <strong>di</strong> X.<br />
spinosum), le maschili <strong>di</strong> 6-8 mm su brevi peduncoli, le femminili biflore, delimitate da un involucro indurito e irto <strong>di</strong> spine<br />
retrorsamente dentellate; spine apicali (becchi) ripiegate a uncino e formanti quasi un semicerchio; tutte le spine con setole e<br />
peli ghiandolari alla base. Frutto (<strong>di</strong>sseminulo) costituito dall’involucro persistente e indurito contenente 2 semi <strong>di</strong> cui 1 solo<br />
normalmente funzionale.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: luglio-ottobre.<br />
Area d’origine: America.<br />
Habitat: Incolti, ruderi, greti fluviali (spesso su sabbia), infestante le colture estive.<br />
Distribuzione nel territorio: Diffusa in tutta la regione, soprattutto nella fascia planiziale. Bergamo (INV), Brescia (INV),<br />
Como (NAT), Cremona (INV), Lecco (INV), Lo<strong>di</strong> (INV), Monza e Brianza (INV), <strong>Milano</strong> (INV), Mantova (INV), Pavia (INV), Sondrio<br />
(NAT), Varese (INV). [X. orientale: Bergamo (DUB), Pavia (DUB).]<br />
Periodo d’introduzione: Neofita (a <strong>di</strong>spetto dell’epiteto specifico), conosciuta in Italia almeno dal 1745.<br />
Modalità d’introduzione: Accidentale: queste piante si <strong>di</strong>ffondono con grande efficienza tele<strong>di</strong>spersiva grazie alla facilità con cui<br />
i loro frutti restano saldamente e, spesso, inosservatamente attaccati al pelo degli animali e ai tessuti in genere (per es. sulla yuta<br />
dei sacchi, sulla lana degli ovini, sul pelo dei cani ecc.). Pertanto, al <strong>di</strong> là del problema <strong>di</strong> dove si sia originata la specie in oggetto, è<br />
ovvio che l’introduzione iniziale degli Xanthium è il risultato <strong>di</strong> contaminazioni casuali e ripetute attraverso gli scambi commerciali<br />
transoceanici, che -lo ricor<strong>di</strong>amo- <strong>di</strong>vennero particolarmente significativi in epoca coloniale, a cavallo tra i secoli XVII e XIX.<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: Sì.<br />
Impatto: Ha un impatto negativo sulla bio<strong>di</strong>versità, in quanto, <strong>di</strong>ffondendosi ampiamente lungo i greti fluviali, ne determina<br />
un deterioramento floristico a scapito delle specie autoctone; qui infatti essa forma comunità in cui <strong>di</strong>venta dominante<br />
(associazione Polygono-Xanthietum italici)(Pirola & Rossetti, 1974). È inoltre una infestante delle colture estive.<br />
Note: Il genere Xanthium subgen Xanthium è composto da entità prevalentemente autogame, sud<strong>di</strong>visibili in due gruppi principali:<br />
X. strumarium L. s.l. autoctono: <strong>di</strong>sseminulo <strong>di</strong> 12-17×10-14 mm (incluse le spine), con spine <strong>di</strong> 2-3 mm e due becchi brevi (2-3 mm), ± dritti<br />
ed espansi alla base (2 mm); foglie generalmente con 3-5 lobi ben marcati; pianta non o debolmente aromatica;<br />
X. orientale L. s.l. esotico: <strong>di</strong>sseminulo <strong>di</strong> 20-26×15-21 mm (incluse le spine), con spine <strong>di</strong> 4-5 mm e due becchi lunghi (5-6 mm), arcuati e poco<br />
<strong>di</strong>latati alla base; foglie con 3(-5) lobi poco marcati; pianta aromatica.<br />
Questi due gruppi sono alla base <strong>di</strong> numerose razze morfologiche che persistono localmente per lungo tempo; tuttavia, a causa delle attività<br />
umane o per motivi naturali, ogni tanto avviene la fecondazione incrociata tra due razze e i caratteri si rimescolano. I caratteri <strong>di</strong> strumarium e<br />
orientale (incl. X. italicum) sono quelli che persistono maggiormente (Löve & Dansereau, 1959; Wisskirchen, 1995; Jeanmonod, 1998a, 1998b).<br />
Alcuni autori, soprattutto europei, considerano numerose specie; Strother (2006) una sola entità, <strong>di</strong> rango specifico, Löve (1974, 1976) due entità,<br />
<strong>di</strong> rango sottospecifico, Wisskirchen (1995) e Jeanmonod (1998a, 1998b) considerano un numero limitato <strong>di</strong> specie. Noi qui consideriamo solo tre<br />
entità, X. strumarium (autoctono), X. orientale s.s. (esotico) e X. italicum (esotico, prudentemente mantenuto <strong>di</strong>stinto da X. orientale).<br />
Bibliografia: Jeanmonod, 1998a, 1998b; Löve, 1974, 1976; Löve & Dansereau, 1959; Pirola & Rossetti, 1974; Strother, 2006; Widder, 1923; Wisskirken, 1995<br />
254 255