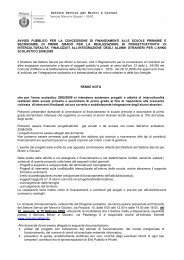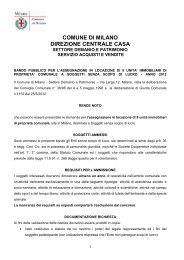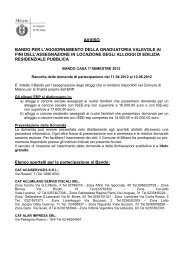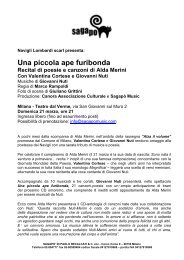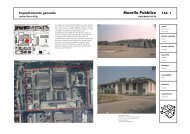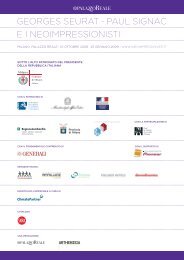LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
amaranto<br />
dei campi<br />
Tipo biologico: Tscap<br />
Descrizione: Pianta erbacea annuale alta, 30-200(-250) cm, con fusto eretto, verde o raramente rosso-porpora, semplice o<br />
ramoso, glabro o subglabro, a volte in alto leggermente pubescente da giovane. Foglie ovate, ovato-rombiche o lanceolate,<br />
(2-)4-15×(1-)2-6 cm, all’apice acute od ottuse, mucronate, con margine intero; picciolo lungo la metà della lamina o quanto<br />
essa. Pianta monoica con fiori unisessuali <strong>di</strong>sposti in infiorescenze terminali ai rami e ascellari, ver<strong>di</strong>, a volte con sfumature<br />
argentee o porporine, generalmente lasse e con rami <strong>di</strong>varicati e flessuosi. Fiori femminili con brattee da lanceolato-lineari a<br />
subulate, lunghe 1.2-2 volte il perianzio, 2.5-4(-6) mm, spinescenti all’apice; tepali 5, tra loro subeguali o <strong>di</strong>seguali, lanceolati<br />
o lanceolato-lineari, lunghi 1.5-3 mm, acuti o acuminati all’apice, gradualmente ristretti in una punta aristata. Frutto a capsula<br />
deiscente (pissi<strong>di</strong>o), obovato od ovato-allungato, 1.5-2.5 mm, più breve dei tepali, liscio alla base e verrucoso o rugoso<br />
nell’opercolo.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: luglio-settembre.<br />
Area d’origine: Nordamerica orientale, Mesoamerica.<br />
Habitat: Ruderi, incolti, greti fluviali e infestante le colture.<br />
Distribuzione nel territorio: Diffusa in tutto il territorio. Bergamo (INV), Brescia (INV), Como (NAT), Cremona (INV), Lecco<br />
(INV), Lo<strong>di</strong> (INV), Monza e Brianza (NAT), <strong>Milano</strong> (INV), Mantova (NAT), Pavia (NAT), Sondrio (NAT), Varese (NAT).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, giunta in Italia in periodo imprecisabile, a causa della confusione con le specie simili.<br />
Modalità d’introduzione: Accidentale.<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: Sì.<br />
Impatto: Minaccia la bio<strong>di</strong>versità delle comunità in cui si stabilisce; inoltre è una temibile infestante delle colture estive.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: Diserbo nei coltivi.<br />
Note: Il gruppo <strong>di</strong> Amaranthus hybridus comprende <strong>di</strong>verse specie spontanee molto simili tra loro, dalle quali sono derivate <strong>di</strong>verse entità coltivate per<br />
la granella o come ornamentali. Oltre ad A. retroflexus, le entità spontanee sono A. hybridus, A. powellii (incl. A. bouchonii) e A. quitensis Kunth (assente<br />
in Italia), mentre quelle domesticate (tutte con brattee brevi) sono A. caudatus, A. cruentus e A. hypochondriacus, i cui rapporti filogenetici sono stati<br />
messi in luce da Xu & Sun (2001). Le segnalazioni relative alle specie cultigene sono in genere da riferirsi esclusivamente ad avventiziati effimeri,<br />
se non (in particolare per A. cruentus) a errori <strong>di</strong> determinazione (Costea et al., 2001; Mosyakin & Robertson, 2003) e/o <strong>di</strong> applicazione dei nomi. In<br />
particolare si ricorda che all’interno <strong>di</strong> A. hybridus vi è una variabilità continua, priva <strong>di</strong> valore sistematico, tra forme con brattee lunghe il doppio dei<br />
tepali e infiorescenze dense e ramificate (A. hybridus s.s.) e altre con brattee lunghe 1-1.5 volte i tepali e infiorescenze più lasse e meno ramificate<br />
(chiamate A patulus); al contrario, il vero A. cruentus è caratterizzato da un’infiorescenza molto densa e riccamente ramificata, spesso vivacemente<br />
colorata, da brattee strettamente spatolate, lunghe 2-3 mm, cioè quanto il perianzio o poco più, e da semi generalmente chiari (scuri in A. hybridus).<br />
Per la determinazione delle specie è utile la chiave della flora del Nordamerica (Mosyakin & Robertson, 2003).<br />
Bibliografia: Costea et al., 2001; Costea & Tar<strong>di</strong>f, 2003; Mosyakin & Robertson, 2003; Xu & Sun, 2001<br />
Famiglia: Amaranthaceae<br />
Nome scientifico: Amaranthus hybridus L.<br />
Nome volgare: amaranto dei campi<br />
Sinonimo: Amaranthus chlorostachys Willd.<br />
Amaranthus cruentus auct., non L.<br />
Amaranthus patulus Bertol.<br />
amaranto<br />
<strong>di</strong> powell<br />
Famiglia: Amaranthaceae<br />
Nome scientifico: Amaranthus powellii S.Watson<br />
Nome volgare: amaranto <strong>di</strong> Powell<br />
Sinonimo: Amaranthus bouchonii Thell.<br />
Amaranthus chlorostachys auct., non Willd.<br />
Amarantus chlorostachys Willd. var. powellii (S.Watson) Priszter<br />
Amaranthus hybridus auct., non L.<br />
Amaranthus hypochondriacus auct., non L.<br />
Amarantus hybridus L. subsp. bouchonii (Thell.) O.Bolòs & Vigo<br />
Amarantus hybridus L. subsp. powellii (S.Watson) Karlsson<br />
Amarantus hybridus L. var. bouchonii (Thell.) Lambinon<br />
Amarantus hypochondriacus L. var. powellii (S.Watson) Pedersen<br />
Amarantus powellii S.Watson subsp. bouchonii (Thell.) Costea & Carretero<br />
Amarantus retroflexus L. var. powellii (S.Watson) B.Boivin<br />
Tipo biologico: Tscap<br />
Descrizione: Pianta erbacea annuale, alta 30-150(-200) cm, con fusto eretto, verde o raramente rosso-porpora, quasi<br />
semplice o ramoso, soprattutto in alto, da glabro a moderatamente pubescente verso l’apice, glabrescente a maturità. Foglie<br />
ovato-rombiche o largamente lanceolate, 4-8×2-3 cm, occasionalmente maggiori in piante robuste, all’apice cuneate, ottuse<br />
o subsmarginate, mucronate, con margine intero; picciolo generalmente lungo quanto la lamina o maggiore. Pianta monoica<br />
con fiori unisessuali <strong>di</strong>sposti in infiorescenze terminali ai rami (prevalentemente) e ascellari, ver<strong>di</strong> o verde-argento, a volte con<br />
sfumature rossastre, generalmente dense e con rami eretti e rigi<strong>di</strong>. Fiori femminili con brattee da lanceolato a subulato-lineari,<br />
lunghe 2-3(-4) volte il perianzio, 4.5-6(-8) mm, rigide; tepali 3-5, tra loro <strong>di</strong>seguali, gli esterni strettamente ovato-ellittici o<br />
ellittici, lunghi 1.5-3.5 mm, aristati. Il frutto è un pissi<strong>di</strong>o a deiscenza ritardata (A. powellii s.s.) o un otricello indeiscente (nelle<br />
forme chiamate A. bouchonii), subgloboso od ovato-compresso, 2-3 mm, eguagliante i tepali o più breve, liscio o leggermente<br />
verrucoso o rugoso nell’opercolo.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: giugno-ottobre.<br />
Area d’origine: Nordamerica sudoccidentale e limitrofo Messico.<br />
Habitat: Ruderi, macerie, greti fluviali e infestante le colture.<br />
Distribuzione nel territorio: Diffusa in tutto il territorio. Bergamo (INV), Brescia (INV), Como (INV), Cremona (INV), Lecco<br />
(NAT), Lo<strong>di</strong> (NAT), Monza e Brianza (NAT), <strong>Milano</strong> (INV), Mantova (NAT), Pavia (INV), Varese (INV).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, osservata per la prima volta in Lombar<strong>di</strong>a nel 1979 nel pavese da Soldano (1980a).<br />
Modalità d’introduzione: Accidentale.<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: Sì.<br />
Impatto: Minaccia la bio<strong>di</strong>versità delle comunità in cui si stabilisce; inoltre è una temibile infestante delle colture estive.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: Diserbo nei coltivi.<br />
Note: Le popolazioni attribuite al taxon A. bouchonii sarebbero il semplice risultato <strong>di</strong> una mutazione monoallelica (pissi<strong>di</strong>ootricello)<br />
<strong>di</strong> A. powellii, per altro priva <strong>di</strong> valore sistematico (cfr. Carretero, 1990; Wilkin, 1992; Aellen & Akeroyd, 1993; Mosyakin & Robertson, 2003).<br />
Si veda inoltre la nota ad A. hybridus.<br />
Bibliografia: Aellen & Akeroyd, 1993; Aeschimann et al., 2004; Bonali, 2000; Bonali et al., 2006a; Carretero, 1990; Costea et al., 2001; Costea & Tar<strong>di</strong>f,<br />
2003; Giordana, 1995; Mosyakin & Robertson, 2003; Soldano, 1980a; Wilkin, 1992; Zanotti, 1990<br />
188 189