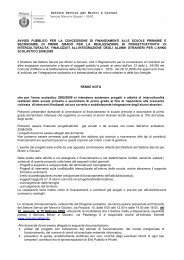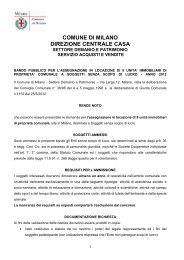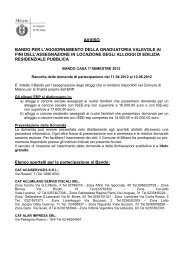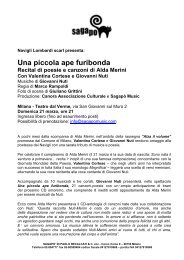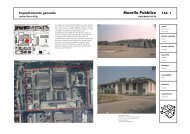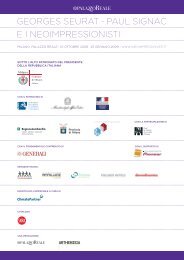LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
osa<br />
polianta<br />
Famiglia: Rosaceae<br />
Nome scientifico: Rosa multiflora Thunb.<br />
Nome volgare: rosa polianta<br />
Sinonimi: Rosa polyantha Siebold & Zucc.,<br />
non Rössig, nom. illeg.<br />
Tipo biologico: Plian<br />
Descrizione: Arbusto lianoso che può raggiungere un’altezza <strong>di</strong> circa 10 m utilizzando gli alberi come supporto; fusto con<br />
aculei (comunemente noti come spine) robusti, lunghi sino a 6 mm. Foglie decidue, alterne, lunghe 5-10 cm, composte da<br />
(3-)5-9 foglioline, queste obovate, ovate od oblunghe, <strong>di</strong> 1-5×1-3 cm, con margine seghettato e apice acuto oppure ottuso;<br />
stipole caratteristicamente sfrangiate sul margine. Fiori profumati portati in cime corimbiformi; pe<strong>di</strong>celli lunghi 1.5-2.5 cm;<br />
sepali 5, decidui, lanceolati, con margine intero o con 2 lobi me<strong>di</strong>ani; petali generalmente 5, bianchi, obovati, con apice<br />
smarginato; stili fusi in una colonna emergente. Frutto consistente in un pometo (tra<strong>di</strong>zionalmente noto come cinorro<strong>di</strong>o)<br />
rosso-bruno, subgloboso, <strong>di</strong> 6-8 mm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro, costituito da un involucro carnoso <strong>di</strong> origine ricettacolare (ipanzio) e da una<br />
cavità interna ospitante numerosi pericarpi legnosi, monospermi, immersi in una “imbottitura” <strong>di</strong> peli setoliformi.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: maggio-giugno.<br />
Area d’origine: Asia orientale (Cina, Corea e Giappone).<br />
Habitat: Boschi degradati, in particolare <strong>di</strong> tipo mesofilo; presso gli abitati.<br />
Distribuzione nel territorio: Non molto frequente, ma localmente spesso abbondante ed esuberante, dalla fascia planiziale<br />
sino a quella prealpina (100-550 m s.l.m.). Bergamo (NAT), Brescia (NAT), Como (INV), Lecco (NAT), Monza e Brianza (INV),<br />
<strong>Milano</strong> (NAT), Varese (INV).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, introdotta in Europa nel 1862. Segnalata per la prima volta in Italia e in Lombar<strong>di</strong>a da Banfi<br />
& Costalonga (1984) al Parco delle Groane.<br />
Modalità d’introduzione: Deliberata (floricoltura).<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: Sì.<br />
Impatto: È in grado <strong>di</strong> formare estese coperture monofitiche, ricoprendo il terreno e avvinghiandosi tipicamente ad alberi<br />
e arbusti sino a notevoli altezze. Espleta quin<strong>di</strong> un notevole impatto per quanto riguarda la per<strong>di</strong>ta in bio<strong>di</strong>versità, nonché<br />
produce mo<strong>di</strong>ficazioni paesaggistiche a carico delle formazioni boschive invase.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: Taglio selettivo, ripetuto per alcuni anni e/o coa<strong>di</strong>uvato dall’impiego <strong>di</strong> erbici<strong>di</strong>, quin<strong>di</strong> provvedere<br />
all’impianto <strong>di</strong> arbusti autoctoni ad elevata capacità ricoprente. Evitare assolutamente la fruttificazione. Pronta rimozione delle<br />
giovani piante in aree <strong>di</strong> neo-invasione.<br />
Note: R. multiflora è facilmente riconoscibile dalle rose autoctone in quanto possiede caratteristiche stipole sfrangiate. Occorre sottolineare come<br />
spesso venga coltivata per le esuberanti e profumate fioriture, che, tra le non rifiorenti, ne fanno una delle rose <strong>di</strong> maggior pregio ornamentale.<br />
Bibliografia: Banfi & Costalonga, 1984; Banfi & Galasso, 1998; Danini et al., 2004; Macchi, 2005<br />
lampone<br />
asiatico<br />
Tipo biologico: nPcaesp<br />
Descrizione: Arbusto alto 1-2 m; fusti arcuati, con sparse spine esili, setole e caratteristici peli ghiandolari rossi, presenti<br />
anche nell’infiorescenza e sul picciolo fogliare. Foglie caduche, alterne, composte da 3(-5) foglioline, le laterali subsessili, la<br />
terminale (spesso lobata) con peduncolo <strong>di</strong> 2-3 cm; lamina delle foglioline ovale o rombica, <strong>di</strong> 4-8×2-5 cm, apice acuto o<br />
acuminato, base arrotondata o subcordata, margine irregolarmente seghettato, pagina inferiore grigio-tomentosa, pagina<br />
superiore glabra o sparsamente pubescente, <strong>di</strong> colore verde; stipole lineari, <strong>di</strong> 5-8 mm. Infiorescenza composta da racemi<br />
terminali o ascellari, lunghi 6-10 cm; brattee 5-8 mm; pe<strong>di</strong>celli 0.5-1.5 cm; fiori 6-10 mm in <strong>di</strong>ametro; sepali eretti dopo la<br />
fioritura, lanceolati; petali biancastri, obovato-spatolati. Il frutto, subgloboso, del <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> circa 1 cm, rosso scuro a piena<br />
maturazione e ricoperto <strong>di</strong> peli ghiandolari, è costituito da un’aggregazione <strong>di</strong> piccole drupe (drupeto), ognuna derivante da<br />
un carpello <strong>di</strong> un ovario multicarpellare.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: maggio-giugno.<br />
Area d’origine: Asia orientale (Cina, Corea e Giappone).<br />
Habitat: Boschi, spesso abbondante in quelli acidofili <strong>di</strong> pino e castagno (es. Terrazzo <strong>di</strong> Brenna, CO) e nelle faggete (es. Monte<br />
Sette Termini, VA). Cresce, come altre specie congeneri, soprattutto dove il bosco è meno fitto. Inoltre si rinviene ai margini<br />
stradali oppure nei pressi <strong>di</strong> vecchie baite, probabilmente come residuo <strong>di</strong> precedenti coltivazioni.<br />
Distribuzione nel territorio: Non molto frequente, ma localmente spesso abbondante ed esuberante, dalla fascia planiziale<br />
sino a quella montana (200-850 m s.l.m.). Bergamo (CAS), Brescia (NAT), Como (INV), Lecco (INV), Monza e Brianza (NAT),<br />
Varese (INV).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, introdotta in Europa nel 1876. In Italia segnalata per il Friuli-Venezia Giulia da Melzer &<br />
Bregant (1992), che la raccolsero nel 1990; in Lombar<strong>di</strong>a segnalata per la prima volta da Aeschimann et al. (2004).<br />
Modalità d’introduzione: Deliberata, per frutticoltura.<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: Sì.<br />
Impatto: È in grado <strong>di</strong> formare estese coperture monofitiche, ricoprendo il terreno e quin<strong>di</strong> reprimendo la crescita del<br />
sottobosco. Non è ancora nota la competitività <strong>di</strong> questa pianta rispetto alle specie autoctone <strong>di</strong> Rubus presenti sul territorio.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: Taglio selettivo, ripetuto per alcuni anni e/o coa<strong>di</strong>uvato dall’impiego <strong>di</strong> erbici<strong>di</strong>, quin<strong>di</strong> impianto<br />
<strong>di</strong> arbusti autoctoni ad elevata capacità ricoprente. Evitare assolutamente la fruttificazione. Pronta rimozione delle giovani<br />
piante in aree neo-invase.<br />
Note: Può essere confusa con altre specie <strong>di</strong> rovi, dai quali però <strong>di</strong>fferisce vistosamente per la fitta copertura rossastra <strong>di</strong> peli ghiandolari, più lunghi<br />
delle spine, su quasi tutta la pianta. Oltre a ciò, come nelle altre specie della sect. Idaeobatus Focke (tra cui, per esempio, il comune lampone, R.<br />
idaeus L.), il frutto si stacca facilmente dal ricettacolo. Diffusamente coltivata per i frutti commestibili, che però risultano meno sapi<strong>di</strong> <strong>di</strong> quelli <strong>di</strong><br />
R. idaeus e insolitamente glutinosi a causa del rivestimento ghiandolare. In campo orticolo la specie ha assunto un’importanza particolare nella<br />
produzione dei ceppi coltivati <strong>di</strong> lampone, ottenuti in prevalenza dall’ibridazione tra R. phoenicolasius e R. idaeus, ma anche del primo con specie<br />
affini, sia eurasiatiche sia americane.<br />
Bibliografia: Aeschimann et al., 2004; Melzer & Bregant, 1992<br />
Famiglia: Rosaceae<br />
Nome scientifico: Rubus phoenicolasius Maxim.<br />
Nome volgare: lampone asiatico<br />
118 119