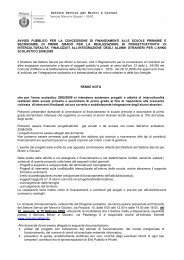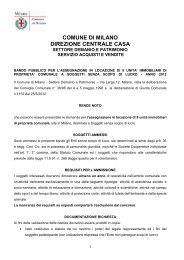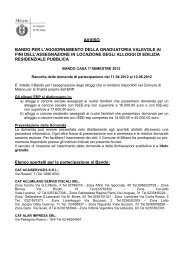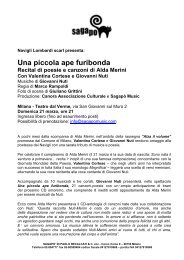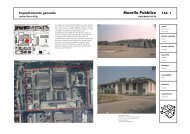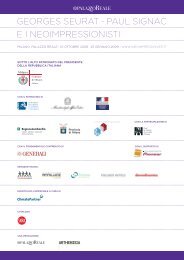LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
pianta<br />
della seta<br />
Tipo biologico: Hscap<br />
Descrizione: Pianta perenne erbacea, alta 100-150 cm, con rizoma strisciante e fusti <strong>di</strong>ffusi, eretti, semplici, glaucescenti.<br />
Foglie opposte, con picciolo <strong>di</strong> 1 cm e lamina ellittica o lanceolata <strong>di</strong> 15-23×5-9 cm, acuminata, alla base arrotondata, grigiotomentosa<br />
sulla faccia abassiale. Ombrelle fiorifere contratte, su peduncoli ascellari <strong>di</strong> 5-10 cm, formate da fiori lunghi 6-8<br />
mm sorretti da pe<strong>di</strong>celli <strong>di</strong> 3-6 cm, con corolla roseo-porporina a 5 lobi riflessi all’antesi e corona interna <strong>di</strong> 5 segmenti liberi,<br />
ognuno provvisto <strong>di</strong> appen<strong>di</strong>ce adassiale centrale ricurva sopra un’antera (5 stami); ovario supero, bicarpellare, con 2 stili<br />
inferiormente liberi, uniti per gli stigmi. Frutti: follicoli fusiformi <strong>di</strong> 8-11×2-3 cm, biancastro-pubescenti, solcati, spinosi; semi<br />
bruni, appiattiti, ovoidali, con un ciuffo <strong>di</strong> lunghi peli argentei all’apice.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: giugno-agosto.<br />
Area d’origine: Nordamerica orientale.<br />
Habitat: Boschi umi<strong>di</strong> ripariali e siepi, più raramente margini dei campi e incolti.<br />
Distribuzione nel territorio: In pianura, soprattutto lungo il Ticino e spora<strong>di</strong>camente lungo il Po e altri fiumi. Brescia (NAT),<br />
Cremona (NAT), Lo<strong>di</strong> (NAT), Monza e Brianza (NAT), <strong>Milano</strong> (NAT), Pavia (NAT), Sondrio (NAT), Varese (NAT).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, coltivata in Italia sin dalla prima metà del secolo XVII; in Lombar<strong>di</strong>a segnalata lungo il Ticino<br />
presso Pavia da Fiori & Paoletti (1902).<br />
Modalità d’introduzione: Deliberata, per la fibra tessile estratta dai fusti quale surrogato della seta (era il periodo delle morie<br />
del baco da seta).<br />
Status: Naturalizzata, localmente abbondante.<br />
Dannosa: Potenzialmente sì.<br />
Impatto: Lungo le sponde del Ticino, nel suo corso inferiore e alla confluenza con il fiume Po, forma popolamenti fitti ed<br />
estesi <strong>di</strong> un certo rilievo.<br />
Note: È una specie da tenere sotto controllo, inserita nella Watch List della Svizzera (http://www.cps-skew.ch/italiano/lista_nera.htm).<br />
Bibliografia: Fiori & Paoletti, 1902<br />
Famiglia: Apocynaceae<br />
Nome scientifico: Asclepias syriaca L.<br />
Nome volgare: pianta della seta, lino d’In<strong>di</strong>a<br />
Sinonimo: Asclepias cornuti Decne., nom. illeg.<br />
buglossa<br />
sempreverde<br />
Tipo biologico: Hscap<br />
Descrizione: Pianta erbacea perenne, alta 40-80 cm, con fusto ispido per setole <strong>di</strong> 1-2.5 mm. Foglie inferiori svernanti,<br />
provviste <strong>di</strong> picciolo lungo 2-15 cm e lamina ovata <strong>di</strong> 7-20×3-10 cm, intera; foglie superiori sessili e più piccole (lunghe 5-12<br />
cm). Infiorescenza terminale, costituita da cincinni peduncolati inseriti ciascuno all’ascella <strong>di</strong> una brattea; fiori pentameri, con<br />
calice a 5 denti lungo 2.5-5 mm; corolla azzurro chiaro, con tubo <strong>di</strong> 4-5×3.5-4.8 mm e lembo a 5 lobi, del <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> 8-10 mm,<br />
con fauce provvista <strong>di</strong> un’appen<strong>di</strong>ce linguiforme alla base <strong>di</strong> ogni lobo; stami 5, inseriti alternatamente alle appen<strong>di</strong>ci, <strong>di</strong> poco<br />
più brevi <strong>di</strong> queste; ovario supero a 4 loculi. Il frutto è un microbasario, cioè uno schizocarpo formato da 4 nucule (mericarpi)<br />
ovoi<strong>di</strong>, inserite obliquamente sulla base comune.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: maggio-giugno.<br />
Area d’origine: Europa sudoccidentale (atlantica).<br />
Habitat: Scarpate ombreggiate.<br />
Distribuzione nel territorio: Pianura comasca; l’unica stazione lombarda sinora conosciuta è sita a 270 m s.l.m. Como (NAT).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, coltivata in Italia dal Cinquecento, in natura raccolta con certezza, nel passato, solo sui<br />
Colli Euganei (Veneto) nel 1835 (Bertoloni, 1835) e 1842 (Trevisan, 1842), dove non è stata più ritrovata (Selvi & Bigazzi, 1998);<br />
recentemente osservata in Lombar<strong>di</strong>a, ove appare naturalizzata almeno dal 2003 (Galasso & Selvi, 2007).<br />
Modalità d’introduzione: Deliberata (interesse ornamentale).<br />
Status: Naturalizzata. Nel sito <strong>di</strong> ritrovamento si riproduce regolarmente, ma la sua permanenza è legata alla presenza <strong>di</strong> siepi<br />
ombreggianti; infatti dove queste sono state rimosse la pianta è scomparsa repentinamente.<br />
Dannosa: No.<br />
Impatto: Irrilevante.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: Finora non necessarie.<br />
Note: Neofita <strong>di</strong> recentissima segnalazione per il territorio lombardo, nel passato già nota per un altro sito dell’Italia settentrionale; non può<br />
essere confusa con boraginacee affini presenti in Lombar<strong>di</strong>a, per la combinazione unica dei caratteri, tra i quali spicca la persistenza invernale<br />
delle foglie basali.<br />
Bibliografia: Bertoloni, 1835; Galasso & Selvi, 2007; Selvi & Bigazzi, 1998; Trevisan, 1842<br />
Famiglia: Boraginaceae<br />
Nome scientifico: Pentaglottis sempervirens (L.)<br />
Tausch ex L.H.Bailey<br />
Nome volgare: buglossa sempreverde<br />
Basionimo: Anchusa sempervirens L.<br />
208 209