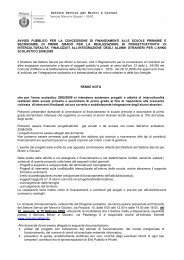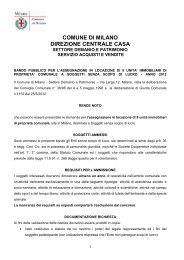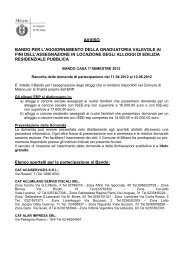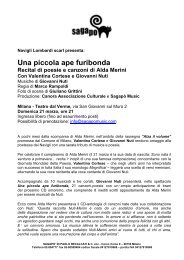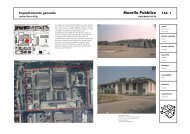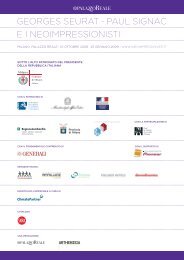LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
forbicina<br />
peduncolata<br />
Tipo biologico: Tscap<br />
Descrizione: Pianta erbacea annuale, alta fino a 150 cm, con fusto eretto o ascendente, liscio, cavo, ramificato, glabro ed<br />
oscuramente quadrangolare, spesso arrossato. Foglie picciolate, opposte, le basali semplici a contorno lanceolato, le cauline<br />
maggiori e <strong>di</strong>vise in 3 segmenti lanceolati, <strong>di</strong> cui il centrale sorretto da un piccioletto lungo fino a ½ della lamina; il margine<br />
dei segmenti è dentato, l’apice acuto. Capolini (calati<strong>di</strong>) con fillari (brattee) brevi, membranosi, non raggianti, delineanti un<br />
involucro ovato o cilindrico; i fiori hanno tutti corolla tubulosa, con 5 denti, giallo-aranciata. I frutti sono acheni nerastri <strong>di</strong> 6-12<br />
mm, strettamente rettangolari, a base attenuata, appiattiti, con setole erette ai margini e 2 reste apicali, a loro volta provviste<br />
<strong>di</strong> setole retrorse (per l’aggancio al vettore <strong>di</strong> <strong>di</strong>sseminazione).<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: luglio-ottobre.<br />
Area d’origine: Nordamerica.<br />
Habitat: Ambienti umi<strong>di</strong> secondari e <strong>di</strong> degrado, <strong>di</strong> norma su base fangosa, soggetti a inondazioni temporanee: fossi, alvei, sponde<br />
<strong>di</strong> cave e stagni, solchi umi<strong>di</strong> nei campi e nei prati, depressioni nei sentieri, strade rurali e urbane, pioppeti, boschi ripariali.<br />
Distribuzione nel territorio: <strong>Comune</strong> in tutta la regione, dalla fascia planiziale alla collinare. Bergamo (INV), Brescia (INV),<br />
Como (INV), Cremona (INV), Lecco (INV), Lo<strong>di</strong> (INV), Monza e Brianza (INV), <strong>Milano</strong> (INV), Mantova (INV), Pavia (INV), Sondrio<br />
(INV), Varese (INV).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, introdotta in Italia nel XVIII secolo, in Lombar<strong>di</strong>a è presente almeno dal 1943 (Stucchi, 1949b).<br />
Modalità d’introduzione: Volontaria (pianta coltivata in Orto botanico) e successiva <strong>di</strong>ffusione accidentale (adesione dei<br />
<strong>di</strong>sseminuli a qualsiasi tipo <strong>di</strong> tessuto o imballaggio).<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: Sì.<br />
Impatto: Elevata competitività vegetativa e riproduttiva (semi) caratterizzano il successo incon<strong>di</strong>zionato <strong>di</strong> questa aliena nelle aree<br />
umide <strong>di</strong>sturbate ed eutrofizzate. In particolare, i formidabili appigli del <strong>di</strong>sseminulo garantiscono alla pianta una <strong>di</strong>ffusione della<br />
massima efficienza, che si realizza per epizoocoria attraverso il pelo degli animali e gli abiti umani, oltre, naturalmente, a qualsiasi<br />
opportunità <strong>di</strong> trasferimento “non protocollare”, come l’acqua <strong>di</strong> ruscellazione piovana o quella dei corsi d’acqua, sulla quale i<br />
<strong>di</strong>sseminuli galleggiano (idrocoria). Nel complesso la specie con<strong>di</strong>ziona soprattutto la <strong>di</strong>versità floristica delle comunità vegetali<br />
igrofile, mentre è meno determinante sul paesaggio. Il peggior danno, dai più ignorato, la forbicina peduncolata, americana, l’ha<br />
perpetrato nei confronti della forbicina europea (B. tripartitus L.), spodestandola letteralmente dal suo habitat e relegandola a piccoli<br />
popolamenti residui, precari e sparpagliati (Gruberová et al., 2001; Gruberová & Prach, 2003). Il fenomeno ha registrato un’impennata<br />
a partire dagli anni ‘60 del passato secolo, in concomitanza con la fine dell’agroeconomia tra<strong>di</strong>zionale e l’espansione urbanisticoindustriale.<br />
Infine ricor<strong>di</strong>amo che i frutti <strong>di</strong> B. frondosus, analogamente a quelli <strong>di</strong> certe graminacee dei generi Anisantha, Hordeum,<br />
Stipa ecc., possono provocare infezioni dolorose nei cani (specialmente cani da caccia), infilandosi sotto la cute attraverso la pelliccia,<br />
nelle orecchie, nelle narici e anche in gola. È specie inclusa nella lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto <strong>di</strong> monitoraggio,<br />
contenimento o era<strong>di</strong>cazione, allegata alla l.r. 10/2008 della Lombar<strong>di</strong>a.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: Pensare <strong>di</strong> eliminare la pianta con interventi mirati come quelli generalmente suggeriti per le altre<br />
aliene è del tutto illusorio, perché B. frondosus è ormai integrata nelle comunità erbacee d’ambiente umido <strong>di</strong> tutto il territorio,<br />
in buona parte avendo preso il posto <strong>di</strong> B. tripartitus. Non resta che tentare <strong>di</strong> agire nel quadro <strong>di</strong> un recupero generale degli<br />
ambienti umi<strong>di</strong>, dove il miglior intervento proponibile non può che nascere da un insieme <strong>di</strong> azioni volte ad abbassare il<br />
grado <strong>di</strong> eutrofizzazione in <strong>di</strong>rezione delle comunità meso-oligotrofiche; questa nuova con<strong>di</strong>zione abbasserebbe anche la<br />
competitività dell’aliena, risolvendo il problema della sua invasività.<br />
Note: Relativamente al genere grammaticale del genere Bidens si veda la nota a B. bipinnatus.<br />
Famiglia: Asteraceae<br />
Nome scientifico: Bidens frondosus L.<br />
Nome volgare: forbicina peduncolata<br />
Basionimo: Bidens melanocarpus Wiegand<br />
cotula<br />
neozelandese<br />
Tipo biologico: Tscap<br />
Descrizione: Pianta erbacea annuale, alta fino a 20 cm, villoso-cenerina, con fusti eretti o decombenti. Foglie alterne,<br />
2-pennatifide. Capolini (calati<strong>di</strong>) terminali e ascellari, peduncolati, del <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> 4-5 mm; involucro con fillari (brattee) in<br />
2 serie; ricettacolo piano, privo <strong>di</strong> pagliette; fiori peduncolati (peduncoli persistenti sul ricettacolo dopo la caduta dei frutti),<br />
i periferici femminili, privi <strong>di</strong> corolla, portati da lunghi peduncoli, gli interni bisessuali o funzionalmente maschili, su brevi<br />
peduncoli, con corolla compresso-tubulosa a 4 denti. Acheni (cipsele) dei fiori femminili compressi, quelli dei fiori bisessuali<br />
piano-convessi; pappo assente.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: giugno-luglio.<br />
Area d’origine: Australia meri<strong>di</strong>onale, Nuova Zelanda.<br />
Habitat: Lastricati stradali.<br />
Distribuzione nel territorio: Fascia planiziale, termofila. Cremona (EST).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, arrivata in Italia probabilmente nel XX secolo. Segnalata in Lombar<strong>di</strong>a per il centro storico<br />
<strong>di</strong> Cremona da Galasso & Bonali (2008) e Bonali (2008); successivamente scomparsa in seguito ad azioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>serbo.<br />
Modalità d’introduzione: Ignota, probabilmente accidentale col commercio della lana.<br />
Status: Estinta.<br />
Dannosa: No.<br />
Impatto: Irrilevante.<br />
Note: In or<strong>di</strong>ne temporale è la seconda specie <strong>di</strong> Cotula naturalizzatasi in Italia, la prima essendo C. coronopifolia L. (Sudafrica), ben <strong>di</strong>stinta<br />
per l’altezza maggiore, per le foglie intere o con pochi denti o lobi e per i capolini più gran<strong>di</strong> (5-10 mm). Per fortuna quest’ultima non interessa<br />
nemmeno potenzialmente la Lombar<strong>di</strong>a, in quanto legata in modo significativo agli ambienti umi<strong>di</strong> subsalsi.<br />
Bibliografia: Bonali, 2008; Galasso & Bonali, 2008<br />
Famiglia: Asteraceae<br />
Nome scientifico: Cotula australis<br />
(Sieber ex Spreng.) Hook.f.<br />
Nome volgare: cotula neozelandese<br />
Basionimo: Anacyclus australis Sieber ex Spreng.<br />
Bibliografia: Giacomini, 1950; Gruberová et al., 2001; Gruberová & Prach, 2003; Stucchi, 1949b<br />
234 235