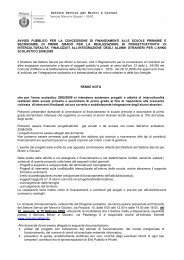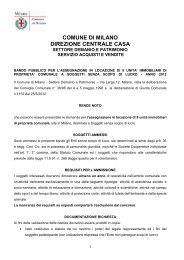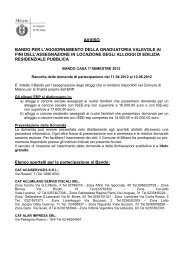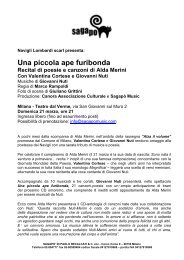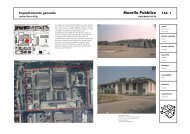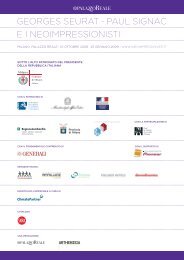LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
polanisia<br />
Tipo biologico: Tscap<br />
Descrizione: Pianta erbacea annuale, alta 30-50 cm, viscoso-appicicaticcia al tatto, con fusto violaceo, eretto, semplice o<br />
ramificato, densamente provvisto <strong>di</strong> peli ghiandolari. Foglie trifogliate con picciolo <strong>di</strong> 3-8 cm e segmenti ellittico-oblunghi<br />
o lanceolati, lunghi 3-7 cm, ottusi, spesso acuminati. Nervi chiari, sporgenti sulla faccia abassiale. Infiorescenza a racemo<br />
terminale allungato, provvisto <strong>di</strong> numerose brattee ellittiche, intere. Fiori su peduncoli eretti <strong>di</strong> 1-2 cm, con 4 sepali caduchi e<br />
4 petali bianco-rosei, spatolato-bifi<strong>di</strong>, lunghi 8-12 mm; stami 12-16; ovario supero, sessile o sorretto da un brevissimo ginoforo.<br />
I frutti sono capsule lineari od oblunghe, appiattite, spesso falcate, lunghe 30-70 mm, con valve reticolate; semi <strong>di</strong>scoidali,<br />
bruno-nerastri.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: luglio-ottobre.<br />
Area d’origine: Nordamerica.<br />
Habitat: Incolti, scarpate, greti sabbiosi dei fiumi.<br />
Distribuzione nel territorio: Dalla fascia planiziale a quella collinare (0-500 m s.l.m.), soprattutto lungo il Po e i suoi affluenti.<br />
Bergamo (CAS), Brescia (CAS), Cremona (NAT), Lo<strong>di</strong> (NAT), Pavia (NAT).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, segnalata per la prima volta in Lombar<strong>di</strong>a nel pavese da Pirola (1964a).<br />
Modalità d’introduzione: Deliberata (giar<strong>di</strong>naggio).<br />
Status: Naturalizzata.<br />
Dannosa: No.<br />
Impatto: Attualmente irrilevante, sebbene sussista il rischio <strong>di</strong> una certa concorrenza con le specie autoctone nei siti <strong>di</strong><br />
colonizzazione.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: Monitoraggio perio<strong>di</strong>co per valutare l’evoluzione demografica delle popolazioni sul territorio;<br />
rimozione manuale in caso <strong>di</strong> necessità.<br />
Bibliografia: Pirola, 1964a<br />
Famiglia: Cleomaceae<br />
Nome scientifico: Polanisia trachysperma Torr. & A.Gray<br />
Nome volgare: polanisia<br />
Sinonimi: Polanisia dodecandra (L.) DC.<br />
subsp. trachysperma (Torr. & A.Gray) Iltis<br />
Polanisia dodecandra (L.) DC.<br />
var. trachysperma (Torr. & A.Gray) Iltis<br />
borsa del<br />
pastore a<br />
fiori gran<strong>di</strong><br />
Tipo biologico: Tscap<br />
Descrizione: Pianta erbacea annuale, alta fino a 75 cm, con pelosità sparsa. Foglie basali in rosetta, con lamina intera, più<br />
o meno lirata o pennatifida; foglie cauline sagittato-amplessicauli. Fiori profumati in racemo terminale nudo, con 4 sepali<br />
eretti, non saccati, 4 petali bianchi, obovato-spatolati, lunghi 4-5 mm (2.5 volte i sepali); stami 6, tetra<strong>di</strong>nami (4 lunghi, 2<br />
brevi); ovario supero, bicarpellare. Il frutto è una siliqua angustisettata (a concamerazioni larghe quanto i semi), <strong>di</strong> forma<br />
triangolare-obcordata, a lati <strong>di</strong>ritti e lobi apicali arrotondati, all’apice profondamente smarginata (stilo lungo 0.25-0.7 mm),<br />
arrotondato-attenuata alla base.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: aprile-giugno.<br />
Area d’origine: Penisola Balcanica, Egeo (Albania, Grecia).<br />
Habitat: Incolti ari<strong>di</strong> su base calcarea.<br />
Distribuzione nel territorio: Pianura, soprattutto nella zona del Lago d’Iseo (BG e BS). Bergamo (INV), Brescia (INV), Lecco<br />
(CAS), <strong>Milano</strong> (NAT).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, segnalata per la prima volta in Italia a fine Ottocento in Friuli-Venezia Giulia; naturalizzata<br />
in Lombar<strong>di</strong>a almeno dal 1939 (Arietti, 1974; Arietti & Crescini, 1980).<br />
Modalità d’introduzione: Non conosciuta, probabilmente deliberata per fini ornamentali.<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: No.<br />
Impatto: Paesaggistico <strong>di</strong> rilevanza locale (vistosa fioritura bianca).<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: Finora non necessarie.<br />
Note: Nell’area d’origine, la nicchia primaria della specie è rappresentata da pen<strong>di</strong>i rocciosi calcarei, ma da qui essa si spinge in ambienti secondari<br />
antropogenici, quali incolti e ruderati. È grazie a tale adattabilità che la pianta ha potuto affermarsi nel nostro territorio, inserendosi in habitat<br />
secondari a bassa competizione. Dello stesso genere sono ben note le due specie autoctone C. bursa-pastoris (L.) Me<strong>di</strong>k. e C. rubella Reut., spesso<br />
<strong>di</strong>fficili da <strong>di</strong>stinguere tra loro e a volte poste in sinonimia, ma ben separabili dall’aliena per i fiori inodori, assai meno vistosi (petali <strong>di</strong> 1.5-3 mm,<br />
lunghi non più del doppio dei sepali) e per il frutto decisamente triangolare a base cuneata e lobi apicali da subacuti a ottusi, mai arrotondati, con<br />
smarginatura me<strong>di</strong>ana appena apprezzabile. Sono tutte entità ruderali.<br />
Bibliografia: Arietti, 1974; Arietti & Crescini, 1980<br />
Famiglia: Brassicaceae<br />
Nome scientifico: Capsella gran<strong>di</strong>flora (Fauché & Chaub.)<br />
Boiss.<br />
Nome volgare: borsa del pastore a fiori gran<strong>di</strong><br />
Basionimo: Thlaspi gran<strong>di</strong>florum Fauché & Chaub.<br />
168 169