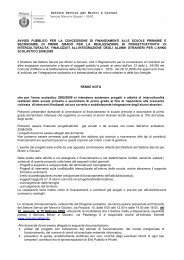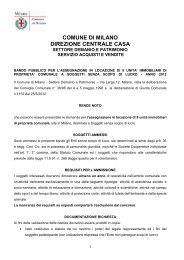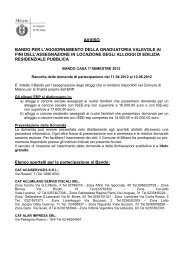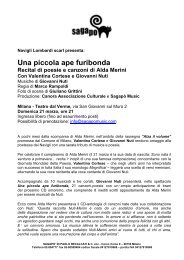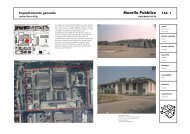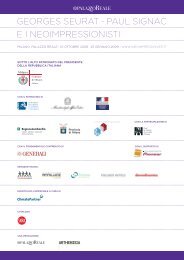LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
gIavone<br />
peloso<br />
Famiglia: Poaceae<br />
Nome scientifico: Echinochloa oryzicola<br />
(Vasinger) Vasinger<br />
Nome volgare: giavone peloso<br />
Basionimo: Panicum oryzicola Vasinger<br />
Sinonimi: Echinochloa crusgalli (L.) P.Beauv.<br />
var. oryzicola (Vasinger) Ohwi<br />
Echinochloa phyllopogon auct., non (Stapf) Stapf ex Kossenko<br />
Echinochloa phyllopogon (Stapf) Stapf ex Kossenko subsp.<br />
oryzicola (Vasinger) Kossenko<br />
Tipo biologico: Tscap<br />
Descrizione: graminacea annuale, alta 50-l50 cm., con ra<strong>di</strong>ce fibrosa e culmi eretti, robusti. guaina fogliare carenata e<br />
lamina larga 5-12 mm, scabra sul bordo; tra la guaina e la lamina, sul margine, si trovano caratteristici peli patenti allungati.<br />
Infiorescenza ricca, contratta, costituita <strong>di</strong> racemi <strong>di</strong>sposti alternatamente su un asse poco incurvato o quasi eretto, così da<br />
costituire una pannocchia lassamente piramidata; spighette con gluma inferiore lunga fino a 3 / 5 della spighetta, segnata<br />
alla base da 3 nervi cigliati, non visibili nella parte superiore; lemma sterile lungo 4 mm, con 2 serie <strong>di</strong> ciglia su ciascun lato e<br />
glabro al centro, con resta apicale breve o lunga. Il frutto è una cariosside brunastra, lunga 2-2.4 mm.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: luglio-settembre.<br />
Area d’origine: Paleotropica (oggi <strong>di</strong>ffusa dai tropici alle zone temperate <strong>di</strong> tutto il mondo).<br />
Habitat: Specchi <strong>di</strong> risaia.<br />
Distribuzione nel territorio: zona delle risaie nel pavese. Pavia (NAT). [E. colona: <strong>Milano</strong> (NAT).] [E. hispidula: Pavia (NAT),<br />
Varese (CAS).] [E. oryzoides: Pavia (NAT).]<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, introdotta in periodo indeterminato, probabilmente sin dal Cinquecento, insieme alla<br />
coltura del riso. Esiste anche un confusione tra le varie specie, per cui si può soltanto ricordare che Panicum oryzoides (=<br />
Echinocloa oryzoides) è stato descritto nel 1763 da Pietro Arduino su materiale dell’Italia settentrionale, mentre P. phyllopogon<br />
(sempre sinonimo <strong>di</strong> Echinochloa oryzoides) è stato descritto nel 1901 da Stapf su piante raccolte nelle risaie novaresi da<br />
Arcangeli nel 1896 e subito segnalato anche nel pavese (Fiori, 1905a; Farneti, 1911).<br />
Modalità d’introduzione: Accidentale, insieme alla coltura del riso, dall’Oriente (In<strong>di</strong>a e Cina tropicale).<br />
Status: Naturalizzata.<br />
Dannosa: Sì.<br />
Impatto: Infestante del riso.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: Diserbo in risaia.<br />
Note: Questa specie è molto somigliante alle altre congeneri presenti in Lombar<strong>di</strong>a. Tra <strong>di</strong> esse, l’unica veramente comune e ubiquitaria, perciò<br />
rilevante in termini <strong>di</strong> confusione, è il giavone comune (E. crusgalli (L.) P.Beauv.), l’unica autoctona infestante le colture irrigue, le vigne, le risaie,<br />
gli incolti, i ruderati umi<strong>di</strong>, le rive e gli alvei. Si <strong>di</strong>stingue facilmente per le spighette lunghe 2.8-3.4 mm, per la gluma inferiore lunga 1 / 4-1 / 3<br />
del lemma sterile, con 3-5 linee <strong>di</strong> setole in corrispondenza dei nervi e spesso con peli sparsi nello spazio internervale; infine per il lemma sterile<br />
lungo 3-3.5 mm e la cariosside <strong>di</strong> 1.4-1.9 mm. Altri tre giavoni esotici sono noti in Lombar<strong>di</strong>a, il maggiore E. oryzoides (Ard.) Fritsch (= E. phyllopogon<br />
(Stapf ) Stapf ex Kossenko, = E. hostii (M.Bieb.) Link, = Panicum oryzoides Ard.), il meri<strong>di</strong>onale E. colona (L.) Link (= Panicum colonum L.) e il cinese<br />
E. hispidula (Retz.) Nees ex Royle (= E. erecta (Pollacci) Pignatti, = Panicum hispidulum Retz.), i primi due paleotropici, il terzo dell’Estremoriente.<br />
Senza entrare in dettagli <strong>di</strong>agnostici, preciseremo che il giavone maggiore e il giavone cinese sono anch’essi commensali del riso, mentre il giavone<br />
meri<strong>di</strong>onale è pianta dei terreni fangosi in genere, anche se in Lombar<strong>di</strong>a è stato trovato in risaia. Tutte e tre le specie si mostrano rare nella zona<br />
risicola.<br />
Bibliografia: Banfi, 1985; Carretero, 1981; Costea & Tar<strong>di</strong>f, 2002; Farneti, 1911; Fiori, 1905a; Tabacchi et al., , 2006<br />
gramIgna<br />
IndIana<br />
Tipo biologico: Tscap<br />
Descrizione: graminacea annuale cespitosa, alta 10-30(-60) cm, con culmi abbastanza robusti, ma prostrato-<strong>di</strong>ffusi o<br />
ascendenti, ramificati alla base. Foglie generalmente pelose, con lamina larga 2-6(-7) mm, largamente cartilaginea al margine;<br />
ligula lunga 0.5 mm, cigliata. Infiorescenza costituita da (1-)2-8(-10) spighe <strong>di</strong> (1.5-)5-8(-12)×0.4-0.6(-0.8) cm, <strong>di</strong>gitate all’apice<br />
del culmo; spighette <strong>di</strong>sposte su due serie, 3-6flore, lunghe 4.5-6 mm; gluma inferiore lunga 1.5-2.5 mm, la superiore 2-4.5<br />
mm; lemma lungo 2.5-5 mm. Frutto a cariosside.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: luglio-agosto.<br />
Area d’origine: Paleotropica (oggi termocosmopolita).<br />
Habitat: Bor<strong>di</strong> <strong>di</strong> vie, marciapie<strong>di</strong> nelle superfici meno calpestate, in ambiente luminoso, in estate surriscaldato, arido e ricco<br />
<strong>di</strong> nitrati (escrementi). Nella vegetazione del Sisymbrion officinalis Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950 e del Polycarpion<br />
tetraphylli Rivas-Mart. 1975.<br />
Distribuzione nel territorio: Ovunque, dalla pianura alla fascia montana. Bergamo (INV), Brescia (INV), Como (INV), Cremona<br />
(INV), Lecco (INV), Lo<strong>di</strong> (INV), Monza e Brianza (INV), <strong>Milano</strong> (INV), Mantova (INV), Pavia (INV), Sondrio (INV), Varese (INV).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, coltivata in Italia dal Settecento. In Lombar<strong>di</strong>a segnalata per la prima volta da Arcangeli (1882a)<br />
a Sesto Calende (VA), dove era stata raccolta da De Notaris nel 1877 (anno della sua morte) o prima (cfr. anche goiran, 1890b).<br />
Modalità d’introduzione: Deliberata (orti botanici).<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: No.<br />
Impatto: Irrilevante.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: Non necessarie.<br />
Note: In Lombar<strong>di</strong>a si trova naturalizzata un’altra specie del genere Eleusine gaertn., E. tristachya (ve<strong>di</strong> scheda), che si <strong>di</strong>stingue soprattutto per<br />
l’infiorescenza costituita da sole 2(-3) spighe, <strong>di</strong> 1-2x0.8-1.2 cm.<br />
Bibliografia: Arcangeli, 1882a; goiran A., 1890b<br />
Famiglia: Poaceae<br />
Nome scientifico: Eleusine in<strong>di</strong>ca (L.) gaertn. subsp. in<strong>di</strong>ca<br />
Nome volgare: gramigna in<strong>di</strong>ana<br />
Basionimo: Cynosurus in<strong>di</strong>cus L.<br />
Sinonimi: Cynodon in<strong>di</strong>cus (L.) Raspail<br />
74 75