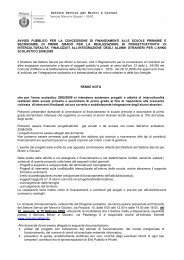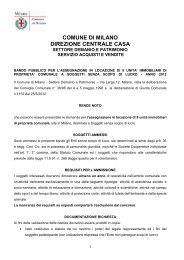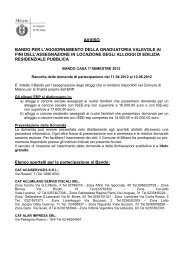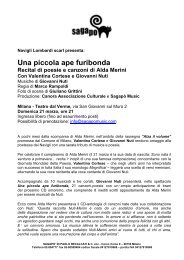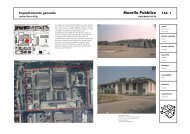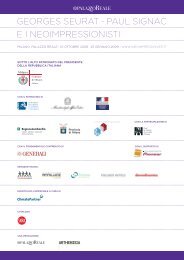LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
poligono<br />
del giappone<br />
Famiglia: Polygonaceae<br />
Nome scientifico: Reynoutria japonica Houtt.<br />
Nome volgare: poligono del Giappone<br />
Sinonimi: Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.<br />
Polygonum cuspidatum Siebold. & Zucc.<br />
Tipo biologico: Grhiz<br />
Descrizione: Pianta erbacea perenne, rizomatosa, alta 0.7-2(-2.5) m, con fusti eretti e ramificati. Foglie alterne con ocrea<br />
(guaina tubolare derivata dalla fusione delle stipole, tipica delle Polygonaceae) lunga 4-6(-10) mm, bruna, obliqua all’apice, non<br />
fimbriata; lamina ovata, 7-17(-18)×8-12 cm, troncata alla base, evidentemente cuspidato-caudata e lungamente acuminata<br />
all’apice; nervature della pagina inferiore glabre, minutamente scabre per la presenza <strong>di</strong> protuberanze tanto larghe quanto<br />
lunghe; nervature terziarie e quaternarie poco visibili sulla pagina superiore; picciolo <strong>di</strong> 1-3 cm, alla base con una fossetta<br />
nettarifera sul lato esterno. Infiorescenze panicoliformi, lunghe 4-12 cm, ascellari e terminali; fiori funzionalmente unisessuali<br />
(su una stessa pianta possono essere presenti entrambi i tipi <strong>di</strong> fiori o soltanto quelli femminili); tepali 5, bianchi o biancoverdastri,<br />
i 3 esterni leggermente alati e accrescenti nel frutto; stami 8, sporgenti dai tepali (nei fiori maschili) o più brevi e<br />
ridotti a stamino<strong>di</strong> (in quelli femminili). Il frutto è un achenio marrone scuro, trigono, lungo 2.3-3.6 mm, liscio e lucido.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: luglio-settembre.<br />
Area d’origine: Asia orientale.<br />
Habitat: Fiumi, margini, incolti.<br />
Distribuzione nel territorio: Diffusa in tutta la Lombar<strong>di</strong>a, dalla pianura sino alla fascia montana (0-1˙200 m s.l.m.). Bergamo<br />
(INV), Brescia (INV), Como (INV), Cremona (NAT), Lecco (INV), Lo<strong>di</strong> (NAT), Monza e Brianza (INV), <strong>Milano</strong> (INV), Mantova (NAT),<br />
Pavia (INV), Sondrio (INV), Varese (INV).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, introdotta in Europa (Gran Bretagna) nel 1825 (Bailey & Conolly, 2000); in Italia coltivata<br />
nel 1858 all’Orto botanico <strong>di</strong> Padova e naturalizzata a Torino in Piemonte nel 1891 (Vaccaneo, 1933). In Lombar<strong>di</strong>a è coltivata<br />
almeno dal 1921 e conosciuta in natura almeno dal 1932 (Padula et al., 2008); segnalata per la prima volta da Stucchi (1949b).<br />
Modalità d’introduzione: Deliberata, per floricoltura.<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: Sì.<br />
Impatto: Il poligono del Giappone è inscritto nella lista delle 100 specie esotiche più invasive e più dannose del mondo (lista<br />
dell’IUCN, Unione Internazionale per la Conservazione della Natura). I popolamenti densi che forma costituiscono ovunque<br />
una minaccia per le flore e le vegetazioni in<strong>di</strong>gene, causando una per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> bio<strong>di</strong>versità. È specie inclusa nella lista nera delle<br />
specie alloctone vegetali oggetto <strong>di</strong> monitoraggio, contenimento o era<strong>di</strong>cazione, allegata alla l.r. 10/2008 della Lombar<strong>di</strong>a.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: È specie <strong>di</strong>fficile da eliminare, in quanto ogni pianta produce rizomi in un raggio <strong>di</strong> 7 m e fino a<br />
una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> 3 m. Bisogna cercare innanzitutto <strong>di</strong> non <strong>di</strong>ffondere i rizomi: piccoli frammenti possono dare vita a nuovi<br />
in<strong>di</strong>vidui. Tutte le parti della pianta devono essere incenerite, in nessun caso compostate. Secondo quanto riportato sul sito<br />
svizzero CPS (http://www.cps-skew.ch/), le strategie per impe<strong>di</strong>re l’espansione dei poligoni comprendono la lotta meccanica<br />
(con tagli mensili per almeno 5 anni consecutivi che indeboliscano i rizomi), il pascolo caprino e ovino, la lotta chimica.<br />
Note: Si confonde facilmente anche con le altre specie del genere Reynoutria, dalle quali si <strong>di</strong>stingue per i caratteri delle foglie me<strong>di</strong>ane del<br />
fusto (ve<strong>di</strong> la nota a R. bohemica). Specie fortemente vigorosa e produttiva, tollera la presenza <strong>di</strong> metalli pesanti nel suolo e alte concentrazioni<br />
atmosferiche <strong>di</strong> SO2; i suoi tessuti sono straor<strong>di</strong>nariamente ricchi <strong>di</strong> resveratrolo, una fitoalessina dotata <strong>di</strong> potente attività antiossidante,<br />
antitumorale e car<strong>di</strong>oprotettiva, contenuta in quantità 400 volte superiori a quelle dell’uva e dei sui derivati. Raramente si coltiva R. compacta<br />
(Hook.f.) Nakai (= Polygonum c. Hook.f., = Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. var. c. (Hook.f.) J.P.Bailey, = Reynoutria japonica Houtt. var. c. (Hook.f.)<br />
Moldenke, = Reynoutria japonica Houtt. var. c. (Hook.f.) Buchheim, comb. superfl.; poligono compatto), più piccola (alta 0.5-1.3 m), con lamine<br />
fogliari minori e tondeggianti (5-7×5-7 cm), troncate o leggermente cuneate alla base, fiori femminili rossastri e fiori maschili generalmente<br />
biancastri; è stata osservata casuale nel varesino (Padula et al., 2008).<br />
poligono<br />
<strong>di</strong> sakhalin<br />
Tipo biologico: Grhiz<br />
Descrizione: Pianta erbacea perenne, rizomatosa, alta fino oltre 4 m, con fusti eretti e ramificati. Foglie alterne con ocrea<br />
(guaina tubolare derivata dalla fusione delle stipole, tipica delle Polygonaceae) lunga 6-12 mm, bruna, obliqua all’apice, non<br />
fimbriata; lamina da strettamente ovata a ellittico-oblunga, 25-35(-40)×(10-)20-25 cm, profondamente cordata alla base<br />
e assottigliata in un apice smussato o brevemente acuto; pagina superiore verde-grigiastro; pagina inferiore verde pallido,<br />
con peli pluricellulari flessuosi lunghi fino a 1 mm, soprattutto lungo le nervature; queste ultime spesso arrossate, quelle<br />
terziarie e quaternarie ben visibili sulla pagina superiore; picciolo <strong>di</strong> 1-4 cm, alla base con una fossetta nettarifera sul lato<br />
esterno. Infiorescenze panicoliformi, lunghe 3-8 cm, ascellari e terminali; fiori funzionalmente unisessuali (su una stessa pianta<br />
possono essere presenti entrambi i tipi <strong>di</strong> fiori o soltanto quelli femminili); tepali 5, bianco-verdastri, i 3 esterni leggermente<br />
alati e accrescenti nel frutto; stami 8, sporgenti dai tepali (nei fiori maschili) o più brevi e ridotti a stamino<strong>di</strong> (in quelli femminili).<br />
Il frutto è un achenio marrone, trigono, lungo 2.8-4.5 mm, liscio e lucido.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: luglio-ottobre.<br />
Area d’origine: Asia orientale (Isola <strong>di</strong> Sakhalin, Giappone, Corea).<br />
Habitat: Margini boschivi, incolti.<br />
Distribuzione nel territorio: Prealpi occidentali (province <strong>di</strong> Varese e Como). Como (NAT), Varese (NAT).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, introdotta in Europa al Giar<strong>di</strong>no botanico <strong>di</strong> San Pietroburgo in tre volte successive, nel 1855,<br />
nel 1861 e nel 1864 (Bailey & Conolly, 2000). In Italia raccolta nel 1897 a Castel <strong>di</strong> Guido in comune <strong>di</strong> Roma (presumibilmente<br />
coltivata, Padula et al., 2008) e nel 1903 a Gries in comune <strong>di</strong> Bolzano (in natura, Padula et al., 2008), sicuramente naturalizzata<br />
almeno dal 1969 in Toscana (Campolmi & Lanza, 1990). Segnalata per la prima volta in Italia da Abbà (1983), in Lombar<strong>di</strong>a da<br />
Padula et al. (2008), dove è presente da prima del 2006.<br />
Modalità d’introduzione: Deliberata, per floricoltura.<br />
Status: Naturalizzata.<br />
Dannosa: Potenzialmente.<br />
Impatto: Sinora in Italia non si è ancora mostrata invasiva; è comunque inclusa nella lista nera delle specie alloctone vegetali<br />
oggetto <strong>di</strong> monitoraggio, contenimento o era<strong>di</strong>cazione, allegata alla l.r. 10/2008 della Lombar<strong>di</strong>a.<br />
Note: Si confonde facilmente con le altre specie del genere Reynoutria, dalle quali si <strong>di</strong>stingue per i caratteri delle foglie me<strong>di</strong>ane del fusto (ve<strong>di</strong><br />
la nota a Reynoutria bohemica).<br />
La segnalazione <strong>di</strong> Macchi per il varesino (2005) corrisponde a R. bohemica (Padula et al., 2008).<br />
Bibliografia: Abbà, 1983; Bailey & Conolly, 2000; Campolmi & Lanza, 1990; Macchi, 2005; Padula et al., 2008<br />
Famiglia: Polygonaceae<br />
Nome scientifico: Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt)<br />
Nakai<br />
Nome volgare: poligono <strong>di</strong> Sakhalin, poligono gigante<br />
Basionimo: Polygonum sachalinense F.Schimdt<br />
Sinonimo: Fallopia sachalinensis (F.Schmidt) Ronse Decr.<br />
Polygonum ×vivax J.Schmitz & Strank, nom. inval.<br />
Reynoutria ×vivax J.Schmitz & Strank, nom. inval.<br />
Bibliografia: Bailey, 2008; Bailey & Conolly, 2000; Barney et al., , 2006; Beerling et al., 1994; Frattini, 1988; Padula et al., 2008; Stucchi, 1949b;<br />
Vaccaneo, 1933<br />
182 183