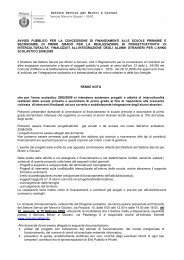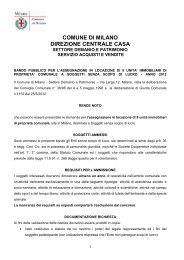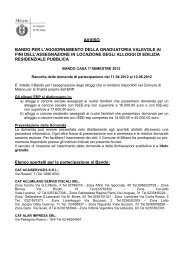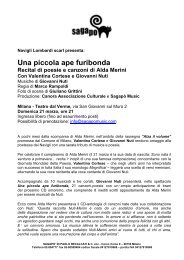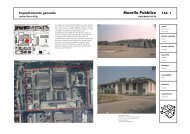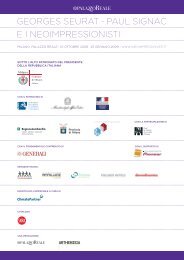LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
veronica<br />
filiforme<br />
Tipo biologico: Hscap<br />
Descrizione: Pianta erbacea perenne, alta generalmente sino a 20 cm, con fusti prostrati e ra<strong>di</strong>canti, formanti un denso<br />
tappeto. Foglie alterne, brevemente picciolate; lamina subrotonda, 5-13 mm, sparsamente pelosa, margine crenato con<br />
piccoli denti ottusi, base cordata, apice arrotondato. Fiori singoli all’ascella <strong>di</strong> brattee simili alle foglie; alla fioritura pe<strong>di</strong>celli<br />
lunghi almeno il doppio della corrispondente foglia bratteale; calice con 4 lobi; corolla azzurra o lilla-biancastra, rotata, <strong>di</strong> 5-14<br />
mm. Frutto raro, costituito da una capsula obcordata, compressa, più ampia che lunga.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: marzo-maggio.<br />
Area d’origine: Asia occidentale (Iran, Turchia e Caucaso) ed Europa orientale (Russia e Ucraina).<br />
Habitat: Cresce tipicamente in prati regolarmente falciati, in particolare se moderatamente ombreggiati, e su suoli con buona<br />
<strong>di</strong>sponibilità idrica.<br />
Distribuzione nel territorio: Presenza frammentaria su tutto il territorio regionale, soprattutto nella fascia planiziale (con<br />
l’esclusione della bassa pianura) e collinare (100-650 m s.l.m.); sembra più frequente nella Lombar<strong>di</strong>a occidentale. Bergamo<br />
(NAT), Brescia (NAT), Como (NAT), Cremona (NAT), Lecco (NAT), Monza e Brianza (NAT), <strong>Milano</strong> (INV), Sondrio (NAT), Varese (INV).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, raccolta per la prima volta in Italia e in Lombar<strong>di</strong>a (Monte Resegone nel lecchese e Varese)<br />
da Viola (1955) nel 1954.<br />
Modalità d’introduzione: Deliberata, per floricoltura.<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: No.<br />
Impatto: Pur essendo localmente piuttosto <strong>di</strong>ffusa e con popolazioni consistenti (invasiva), la sua presenza non sembra<br />
attualmente destare particolari preoccupazioni.<br />
Note: Coltivata come tappezzante e per le attraenti fioriture. Può essere confusa con V. persica (ve<strong>di</strong> scheda), che però è una pianta annuale, con<br />
fusti ascendenti, foglie spesso <strong>di</strong> forma ovale e con denti più incisi e acuti, e pe<strong>di</strong>celli lunghi alla fioritura al massimo poco più della corrispondente<br />
foglia bratteale.<br />
Bibliografia: Viola, 1955<br />
Famiglia: Plantaginaceae<br />
Nome scientifico: Veronica filiformis Sm.<br />
Nome volgare: veronica filiforme<br />
Sinonimo: Veronica tournefortii C.C.Gmel., non Vill., nom. illeg.<br />
occhi della<br />
madonna<br />
Tipo biologico: Trept<br />
Descrizione: Pianta erbacea annuale a fusti lunghi 5-50 cm, prevalentemente decombenti e ra<strong>di</strong>canti ai no<strong>di</strong>. Foglie alterne,<br />
da ovate a subrotonde, <strong>di</strong> 10-20×9-18 mm, con margine piano, crenato-seghettato, da brevemente picciolate a subsessili,<br />
verde chiaro, le superiori ± bruscamente ridotte. Fiori solitari, ascellari, su peduncoli allungantisi fino a 22 mm nel frutto,<br />
superanti le brattee; calice profondamente <strong>di</strong>viso in 4(-5) lacinie ovato-lanceolate lunghe (4-)6-7 mm; corolla debolmente<br />
zigomorfa, <strong>di</strong> 8-12 mm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro, a 4 lobi azzurro-cielo con fauce sbiancata e venature più scure; stami 2, sporgenti e<br />
<strong>di</strong>vergenti; ovario supero. Il frutto è una capsula loculicida bilobata, <strong>di</strong> 4-5×7-10 mm, a lobi molto <strong>di</strong>vergenti separati da<br />
un seno largo e poco profondo, fortemente carenata; stilo <strong>di</strong> 2.5-3 mm, visibilmente sporgente dal seno; semi appiattiti,<br />
largamente ellittici, concavi su una faccia.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: (febbraio)-marzo-ottobre.<br />
Area d’origine: Asia sudoccidentale.<br />
Habitat: Margini erbosi, incolti, prati <strong>di</strong>sturbati, aiuole, campi, colture (eliofila).<br />
Distribuzione nel territorio: Ovunque, dalla fascia planiziale a quella montana. Bergamo (INV), Brescia (INV), Como (INV),<br />
Cremona (INV), Lecco (INV), Lo<strong>di</strong> (INV), Monza e Brianza (INV), <strong>Milano</strong> (INV), Mantova (INV), Pavia (INV), Sondrio (INV), Varese (INV).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, conosciuta in Italia da metà del Cinquecento. In Europa osservata per la prima volta in<br />
natura nel 1805: sfuggita alla coltura nei <strong>di</strong>ntorni <strong>di</strong> Karlsruhe, si <strong>di</strong>ffuse nella gran parte dei paesi europei nella seconda metà<br />
dell’Ottocento. In Lombar<strong>di</strong>a già citata da Cesati (1844).<br />
Modalità d’introduzione: Deliberata (usi floricoli).<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: Relativamente.<br />
Impatto: Paesaggistico (gradevole), evidente nel periodo <strong>di</strong> massima fioritura. Inoltre con<strong>di</strong>ziona negativamente la<br />
bio<strong>di</strong>versità delle cenosi segetali legate alla vegetazione cerealicola, sottraendo spazio a molte specie della classe Stellarietea<br />
me<strong>di</strong>ae Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950 e degli or<strong>di</strong>ni Centaureetalia cyani Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950<br />
(su suoli ricchi in basi) e Chenopo<strong>di</strong>etalia albi Tüxen (1937) 1950 (su suoli poveri <strong>di</strong> basi).<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: Eventuale uso degli erbici<strong>di</strong> comunemente impiegati in agricoltura per l’eliminazione delle<br />
<strong>di</strong>cotiledoni annuali.<br />
Note: Può essere confusa con V. filiformis (ve<strong>di</strong> scheda), che però è una pianta perenne, con fusti prostrati formanti un denso tappeto, foglie<br />
subrotonde con piccoli denti ottusi e pe<strong>di</strong>celli lunghi alla fioritura almeno il doppio della corrispondente foglia bratteale.<br />
Bibliografia: Cesati, 1844<br />
Famiglia: Plantaginaceae<br />
Nome scientifico: Veronica persica Poir.<br />
Nome volgare: occhi della Madonna<br />
Sinonimo: Veronica buxbaumii Ten.,<br />
non F.W.Schmidt, nom. illeg.<br />
220 221