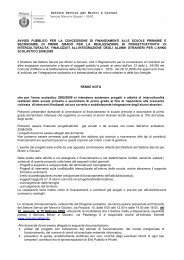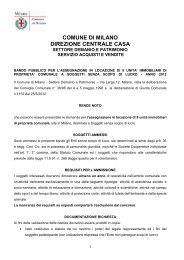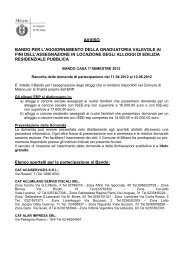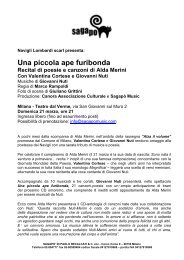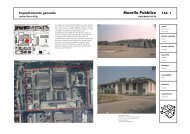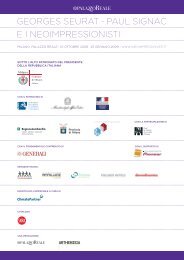LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
milleFoglio<br />
d’acqua<br />
Famiglia: Haloragaceae<br />
Nome scientifico: Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.<br />
Nome volgare: millefoglio d’acqua<br />
Basionimo: Enydria aquatica Vell.<br />
Sinonimi: Myriophyllum brasilense Cambess.<br />
Myriophyllum proserpinacoides Gillies ex Hook.& Arn.<br />
Tipo biologico: Hyrad<br />
Descrizione: Pianta erbacea acquatica con foglie sia aeree sia sommerse, <strong>di</strong>sposte in verticilli <strong>di</strong> 4-6 lungo il fusto. Foglie<br />
giallo-verde chiaro o verde glauco, pennatifide, le sommerse lunghe 1.5-3.5 cm con 20-30 segmenti filiformi per lamina;<br />
le aeree lunghe 2-5 cm con 6-18 segmenti. Fiori piccoli, unisessuali (pianta monoica), <strong>di</strong>sposti in spiga terminale all’ascella<br />
delle foglie aeree; i superiori maschili con 4 piccoli petali bianchi, caduchi e 4 o 8 stami; gli inferiori femminili, privi <strong>di</strong> corolla,<br />
con ovario a 4 loculi e 4 stimmi sessili o subsessili. Il frutto è uno schizocarpo <strong>di</strong> 4 otricelli separantisi longitu<strong>di</strong>nalmente.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: giugno-settembre.<br />
Area d’origine: Sudamerica (Rio delle Amazzoni).<br />
Habitat: Stagni, laghetti, canali.<br />
Distribuzione nel territorio: Sinora naturalizzata soltanto nella pianura bresciana. Brescia (NAT).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, introdotta in Italia nella seconda metà del secolo scorso. Segnalata per la prima volta in<br />
Italia da Minutillo & Moraldo (1994) che la raccolsero nel 1988 e nel 1992 nelle province <strong>di</strong> Latina e Caserta; in Lombar<strong>di</strong>a è<br />
stata rinvenuta nel 2003 da Frattini (Conti et al., 2007; Frattini, 2008).<br />
Modalità d’introduzione: Deliberata, per piante d’acquario.<br />
Status: Naturalizzata.<br />
Dannosa: Attualmente no.<br />
Impatto: Attualmente irrilevante.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: Poiché in alcuni stati risulta invasiva, va tenuta sotto controllo.<br />
Bibliografia: Conti et al., 2007; Frattini, 2008; Lastrucci et al., 2006; Minutillo & Moraldo, 1994<br />
vite del<br />
canada<br />
Famiglia: Vitaceae<br />
Nome scientifico: Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.<br />
Nome volgare: vite del Canada<br />
Basionimo: Hedera quinquefolia L.<br />
Sinonimi: Ampelopsis hederacea (Ehrh.) DC.<br />
Ampelopsis quinquefolia (L.) Michx.<br />
Cissus quinquefolia (L.) Borkh.<br />
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch<br />
Psedera quinquefolia (L.) Greene<br />
Vitis hederacea Ehrh. / Vitis inserta A.Kern.<br />
Vitis quinquefolia (L.) Lam.<br />
Tipo biologico: Plian<br />
Descrizione: Arbusto deciduo con fusti striscianti e rampicanti per mezzo <strong>di</strong> viticci (infiorescenze trasformate in organi <strong>di</strong><br />
adesione), lunghi fino a 10(-30!) m; ritidoma bruno-rossastro, non sfibrato in placche; viticci opposti alle foglie, <strong>di</strong>visi in 5-8<br />
ramificazioni più o meno evidentemente terminate da un <strong>di</strong>sco adesivo. Foglie <strong>di</strong>gitate, abassialmente da opaco-glaucescenti<br />
a verde lucido, arrossate d’estate, rosso scuro in autunno, glabre; segmenti in numero <strong>di</strong> (3-)5(-7), brevemente picciolettati e<br />
caduchi, obovato-oblanceolati, il maggiore (centrale) <strong>di</strong> 3-10×2-6 cm, con margine a denti irregolari, acuti; segmenti laterali<br />
minori e spesso asimmetrici. Fiori numerosi in pannocchie subemisferiche, terminali e opposte alle foglie; calice assente;<br />
corolla <strong>di</strong> 5 petali verdastri lunghi circa 3 mm, riflessi. Frutto a bacca nero-blu, pruinosa, subsferica, contenente 1-2 semi.<br />
Periodo <strong>di</strong> fioritura: maggio.<br />
Area d’origine: Nordamerica.<br />
Habitat: Ruderi, macerie, muri, bor<strong>di</strong> <strong>di</strong> sentieri, massicciate ferroviarie, boscaglie, boschi ecc.<br />
Distribuzione nel territorio: Ovunque, prevalentemente planiziale. Bergamo (INV), Brescia (INV), Como (INV), Cremona<br />
(INV), Lecco (INV), Lo<strong>di</strong> (INV), Monza e Brianza (INV), <strong>Milano</strong> (INV), Mantova (INV), Pavia (INV), Sondrio (INV), Varese (INV).<br />
Periodo d’introduzione: Neofita, introdotta in Italia nel Seicento, nel 1793 comunemente coltivata e consigliata a <strong>Milano</strong><br />
(Anonimo, 1793); nel 1863 naturalizzata nel trevigiano (Saccardo, 1863), nel 1884 sulle mura <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> (Omati, 1884), nel 1907<br />
nel bresciano (Ugolini, 1907).<br />
Modalità d’introduzione: Deliberata, con finalità orticolturale.<br />
Status: Invasiva.<br />
Dannosa: Sì.<br />
Impatto: Negli ambienti sinantropici determina un abbassamento della bio<strong>di</strong>versità in quanto soppianta rampicanti<br />
autoctone; in ambiente seminaturale/naturale la sua presenza è ancora contenuta, ma ugualmente minacciosa in relazione ai<br />
rischi <strong>di</strong> degrado e <strong>di</strong> sostituzione delle rampicanti autoctone.<br />
Azioni <strong>di</strong> contenimento: È una pianta che andrebbe eliminata dal mercato florovivaistico, dai parchi e dai giar<strong>di</strong>ni.<br />
Note: Le forme caratterizzate da faccia abassiale verde lucido nei segmenti fogliari, da viticci allungati a 3-5 ramificazioni prive <strong>di</strong> <strong>di</strong>sco adesivo<br />
(solo un ispessimento terminale fatto per agganciare l’interno delle fessure) e da infiorescenze mai terminali, più piccole e più ramificate, vengono<br />
da molti autori (es. Laguna Lumbreras, 2005) identificate con il binomio P. inserta. Può essere che questa entità, simpatrica con P. quinquefolia, in<br />
Nordamerica si mantenga in qualche modo <strong>di</strong>stinta, mentre in Europa, come osserva Webb (1968), almeno una parte delle popolazioni presenta<br />
caratteri promiscui, facendo pensare a un rimescolamento dei due genomi. D’altra parte nessun in<strong>di</strong>viduo con presunti caratteri <strong>di</strong> P. inserta<br />
(soprattutto i viticci senza <strong>di</strong>sco adesivo) presente nel nostro territorio può mai essere ricondotto sod<strong>di</strong>sfacentemente a tale taxon. Per questi<br />
motivi e in accordo con la recente checklist sinonimica della flora degli Stati Uniti (Kartesz, 1998), preferiamo considerare P. inserta sinonimo <strong>di</strong> P.<br />
quinquefolia.<br />
Bibliografia: Anonimo, 1793; Kartesz, 1998; Laguna Lumbreras, 2005; Omati, 1884; Saccardo, 1863; Ugolini, 1907; Webb, 1968<br />
96 97