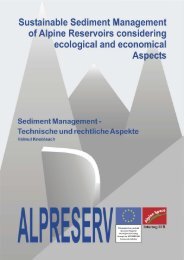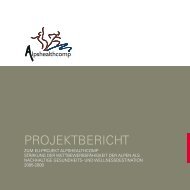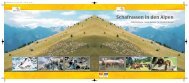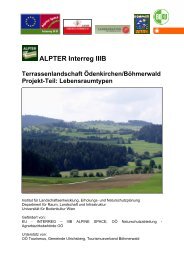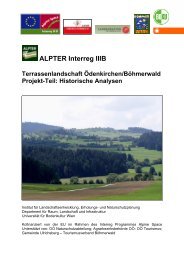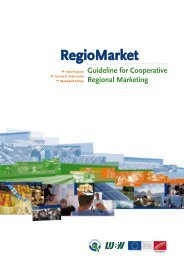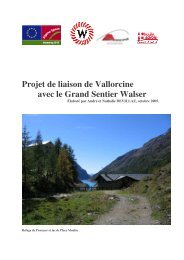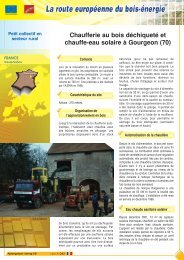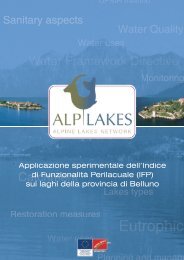WALSERSPRACHE - The four main objectives of the Alpine Space ...
WALSERSPRACHE - The four main objectives of the Alpine Space ...
WALSERSPRACHE - The four main objectives of the Alpine Space ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Enrico Rizzi<br />
recentissime. La prima è il progetto “Walser Alps”, che vede operare insieme<br />
partners appartenenti a sei stati diversi e a undici regioni alpine. La<br />
seconda è la proposta, già avanzata al governo italiano, di inserire la lingua<br />
e cultura Walser nella lista del patrimonio culturale immateriale<br />
dell’UNESCO, quale “patrimonio mondiale dell’umanità”. Un riconoscimento<br />
che accenderebbe un forte riflettore sui Walser e consentirebbe di<br />
raccogliere nuove risorse e favorire in molti modi la valorizzazione di una<br />
cultura che deve costituire il volano anche dello sviluppo economico<br />
delle comunità Walser, aiutandole a recuperare un patrimonio di civiltà<br />
così peculiare, ma di interesse universale, in chiave di turismo culturale.<br />
Sulla peculiarità di questa cultura (e di questa lingua) credo che occorra<br />
s<strong>of</strong>fermarsi anche in queste nostre giornate d’incontro. Ed io, svestiti i<br />
panni del testimone di un impegno che ha accumunato negli ultimi decenni<br />
molti di noi, panni fin qui indossati, torni ai miei di storico, anche se di<br />
storico della colonizzazione, non di storico della lingua. Ma i due aspetti,<br />
com’è evidente, sono tra loro intimamente legati.<br />
La lingua Walser – come abbiamo sostenuto anche nella proposta di<br />
candidatura all’UNESCO – rappresenta una delle lingue più arcaiche e<br />
contrassegna una civiltà, un modo di vita, un’economia dell’alta montagna<br />
senza uguali nella storia d’Europa. Perciò la scomparsa della lingua<br />
Walser – unica vera espressione e contrassegno di quel popolo – sarebbe<br />
una perdita per l’umanità.<br />
La lingua è infatti l’unico retaggio pregno di caratteristiche, il quale,<br />
malgrado tutte le mutilazioni e le mescolanze subìte nei secoli, nonostante<br />
le diversità locali e le varie interferenze estranee, ancora oggi distingue<br />
i Walser dai vicini allogeni. E quasi a compensare la straordinaria versatilità<br />
che li ha caratterizzati nella dura sfida alla montagna, il loro tenace<br />
attaccamento alla vecchia lingua ha sempre connotato la loro volontà di<br />
salvare la parte più pr<strong>of</strong>onda della cultura, quella che l’ambiente con le<br />
sue leggi ferree non è stata in grado di scalfire, e che ogni altra espressione<br />
della civiltà Walser ha saputo gelosamente racchiudere.<br />
Albert Schott, il primo germanista a intraprendere nel 1839 un viaggio<br />
a piedi nelle valli Walser a sud del Rosa, la definì pittorescamente “lingua<br />
silvestre”. In un’epoca in cui la vita negli “otto comuni tedeschi” alle falde<br />
del Rosa era ancora quella del Medioevo, Schott raccolse un’infinità di<br />
notizie sulla loro parlata: “una variante rurale dell’antico alemanno, miracolosamente<br />
salvata lassù”. Il tedesco migliore, secondo Schott, era quello<br />
di Gressoney, “con l’armonioso suo accento all’antica”, molto vicino al<br />
dialetto Walser dei Grigioni. Ad Alagna, Rima e Rimella, il dialetto era<br />
invece più ruvido, e aveva subìto maggiormente l’influsso italiano; a<br />
41