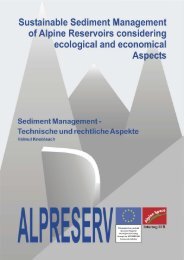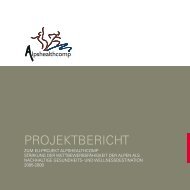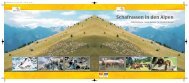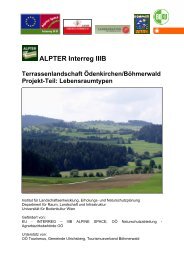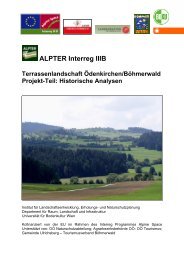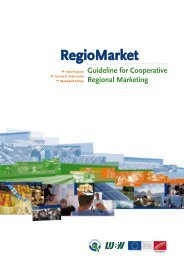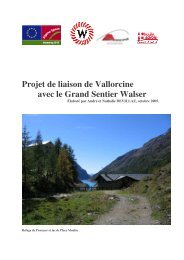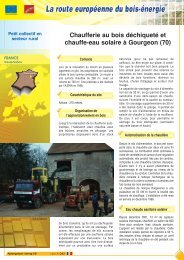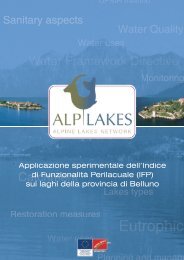WALSERSPRACHE - The four main objectives of the Alpine Space ...
WALSERSPRACHE - The four main objectives of the Alpine Space ...
WALSERSPRACHE - The four main objectives of the Alpine Space ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
72<br />
GLI STUDI SUI DIALETTI WALSER IN ITALIA: BILANCIO E PROSPETTIVE<br />
di mettere in atto strategie di sopravvivenza molto interessanti. Il repertorio<br />
linguistico, grandemente arricchitosi di prestiti e ne<strong>of</strong>ormazioni, mostra<br />
allo stesso tempo una notevole capacità di integrazione degli stessi e di<br />
espressione di risorse autonome da parlata a parlata. Si veda solo qualche<br />
esempio significativo: il ‘rubinetto’ è rubinaèt a Rimella, rubinetto a<br />
Macugnaga, spiine a Formazza, ma z rùbinet (integrato, con ritrazione dell’accento<br />
tonico) a Issime, contro la persistenza del termine originario hane<br />
a Gressoney e ancora hone,e (a)rerra a Rimella 5 ; la ‘federa del cuscino’ è<br />
foderétta a Issime, ma (t) fudréto a Macugnaga e (ts) fédrin ad Alagna 6 , con<br />
evidenti marche di integrazione; la ‘caramella’ è karamèlla a Formazza, ma<br />
kòrmelle a Rimella, karamèlo a Macugnaga, contro l’uso di termine Walser<br />
in altri casi, cfr. tsìkkerli, -ini ad Alagna 7 . Tra le varie modalità di integrazione<br />
spicca senza dubbio proprio la ritrazione dell’accento tonico, di cui gli<br />
esempi sono numerosissimi: Al. bùketyi ‘boccata, sorso’, Alagna, Macugnaga<br />
bèrte(l)e ‘bretelle’, Issime z fòrnet ‘stufa’ (< fornèt), Rimella dùtrinu<br />
‘dottrina’.<br />
Molto resta e si può ancora fare per studiare le condizioni e le peculiarità<br />
di queste parlate alloglotte. Questo compito spetta agli studiosi, all’interessamento<br />
dei quali certamente si deve, almeno in parte, il fatto che le parlate<br />
stesse, ritenute in via di estinzione già molti decenni fa, abbiano sviluppato<br />
un senso di consapevolezza e autocoscienza che hanno fatto registrare un<br />
indubbio rallentamento del processo preannunciato. La parte principale spetta<br />
però a chi sul posto o nelle sedi amministrative adeguate può operare per<br />
il mantenimento di una consuetudine del dialetto parlato, che non si interrompa<br />
nel passaggio generazionale. Le iniziative che si vanno intraprendendo,<br />
sulle quali non spetta a me s<strong>of</strong>fermarmi, vanno in questo senso<br />
e sono tutte lodevoli.<br />
Riferimenti bibliografici<br />
• ALI – Atlante Linguistico Italiano, diretto da M. G. Bartoli, G. Vidossi,<br />
B. A. Terracini, G. Bonfante, C. Grassi, A. Genre, L. Massobrio, Istituto<br />
Poligrafico dello Stato, Roma 1995 sgg., vol. I 1995, vol. II 1996, vol.<br />
III 1997.<br />
• E. Balmer, Die Walser im Piemont, Bern 1949.<br />
• Greschoneytitsch. Vocabolario Italiano-Titsch / D’Eischemtöitschu.<br />
Vocabolario Italiano-Töitschu, a cura di A. Giacalone Ramat, P. Sibilla,<br />
P. Zürrer, Centro di Studi e Cultura Walser della Valle d’Aosta,<br />
Gressoney-Saint-Jean 1988.<br />
• M. Bauen, Sprachgemischter Mundartausdruck in Rimella (Valsesia,<br />
Piemont). Zur Syntax eines südwalserischen Dialekts im<br />
Spannungsfeld der italienischen Landes- und Kultursprache,<br />
BernStuttgart 1978.