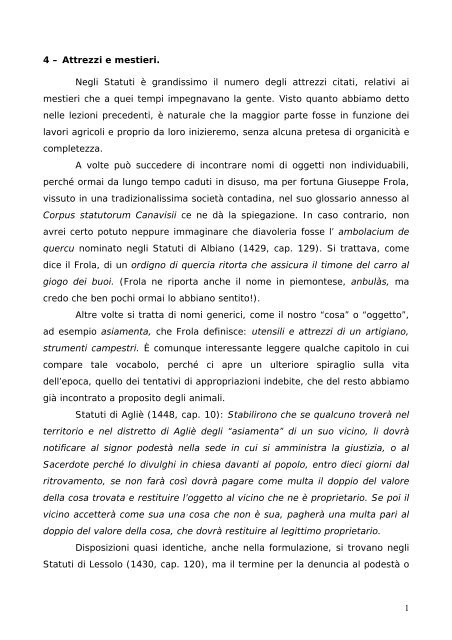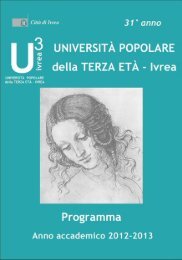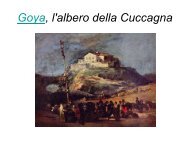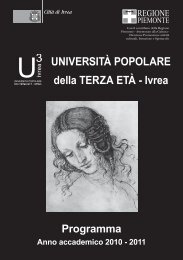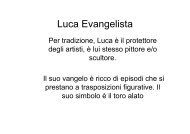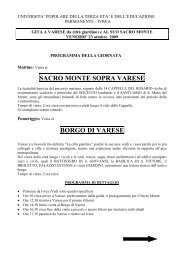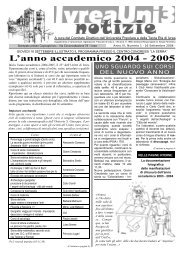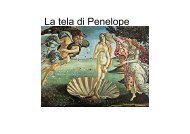Pagine di vita nel Canavese del basso Medioevo - Uni3 Ivrea
Pagine di vita nel Canavese del basso Medioevo - Uni3 Ivrea
Pagine di vita nel Canavese del basso Medioevo - Uni3 Ivrea
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4 – Attrezzi e mestieri.<br />
Negli Statuti è gran<strong>di</strong>ssimo il numero degli attrezzi citati, relativi ai<br />
mestieri che a quei tempi impegnavano la gente. Visto quanto abbiamo detto<br />
<strong>nel</strong>le lezioni precedenti, è naturale che la maggior parte fosse in funzione dei<br />
lavori agricoli e proprio da loro inizieremo, senza alcuna pretesa <strong>di</strong> organicità e<br />
completezza.<br />
A volte può succedere <strong>di</strong> incontrare nomi <strong>di</strong> oggetti non in<strong>di</strong>viduabili,<br />
perché ormai da lungo tempo caduti in <strong>di</strong>suso, ma per fortuna Giuseppe Frola,<br />
vissuto in una tra<strong>di</strong>zionalissima società conta<strong>di</strong>na, <strong>nel</strong> suo glossario annesso al<br />
Corpus statutorum Canavisii ce ne dà la spiegazione. In caso contrario, non<br />
avrei certo potuto neppure immaginare che <strong>di</strong>avoleria fosse l’ ambolacium de<br />
quercu nominato negli Statuti <strong>di</strong> Albiano (1429, cap. 129). Si trattava, come<br />
<strong>di</strong>ce il Frola, <strong>di</strong> un or<strong>di</strong>gno <strong>di</strong> quercia ritorta che assicura il timone <strong>del</strong> carro al<br />
giogo dei buoi. (Frola ne riporta anche il nome in piemontese, anbulàs, ma<br />
credo che ben pochi ormai lo abbiano sentito!).<br />
Altre volte si tratta <strong>di</strong> nomi generici, come il nostro “cosa” o “oggetto”,<br />
ad esempio asiamenta, che Frola definisce: utensili e attrezzi <strong>di</strong> un artigiano,<br />
strumenti campestri. È comunque interessante leggere qualche capitolo in cui<br />
compare tale vocabolo, perché ci apre un ulteriore spiraglio sulla <strong>vita</strong><br />
<strong>del</strong>l’epoca, quello dei tentativi <strong>di</strong> appropriazioni indebite, che <strong>del</strong> resto abbiamo<br />
già incontrato a proposito degli animali.<br />
Statuti <strong>di</strong> Agliè (1448, cap. 10): Stabilirono che se qualcuno troverà <strong>nel</strong><br />
territorio e <strong>nel</strong> <strong>di</strong>stretto <strong>di</strong> Agliè degli “asiamenta” <strong>di</strong> un suo vicino, li dovrà<br />
notificare al signor podestà <strong>nel</strong>la sede in cui si amministra la giustizia, o al<br />
Sacerdote perché lo <strong>di</strong>vulghi in chiesa davanti al popolo, entro <strong>di</strong>eci giorni dal<br />
ritrovamento, se non farà così dovrà pagare come multa il doppio <strong>del</strong> valore<br />
<strong>del</strong>la cosa trovata e restituire l’oggetto al vicino che ne è proprietario. Se poi il<br />
vicino accetterà come sua una cosa che non è sua, pagherà una multa pari al<br />
doppio <strong>del</strong> valore <strong>del</strong>la cosa, che dovrà restituire al legittimo proprietario.<br />
Disposizioni quasi identiche, anche <strong>nel</strong>la formulazione, si trovano negli<br />
Statuti <strong>di</strong> Lessolo (1430, cap. 120), ma il termine per la denuncia al podestà o<br />
1