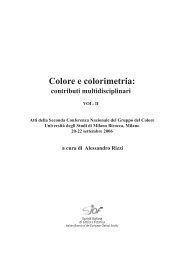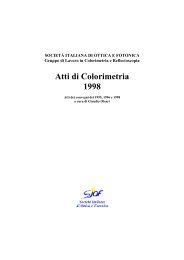Scarica gli atti - Gruppo del Colore
Scarica gli atti - Gruppo del Colore
Scarica gli atti - Gruppo del Colore
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
(figura 2 e 3), ma entrambi capaci di misurare il fattore spettrale di riflessione di<br />
una superficie.<br />
In realtà i due strumenti misurano direttamente il coefficiente spettrale di radianza<br />
q, definito come rapporto tra la radianza (in una data direzione di osservazione) di<br />
una superficie e l’irradiamento sulla stessa. Questo parametro, indicato spesso con<br />
l’acronimo BRDF (BidiRectional Reflectance Function), è quello usato<br />
nell’algoritmo IEN per la progettazione <strong>del</strong>l’impianto di illuminazione.<br />
Se necessario, il fattore di riflessione ρ, definito come rapporto tra il flusso<br />
energetico riflesso e quello incidente, può essere facilmente calcolato, noto q, se si<br />
ipotizza o si conosce come la superficie riflette la radiazione incidente nelle<br />
diverse direzioni <strong>del</strong>lo spazio (ad esempio se la superficie può essere considerata<br />
una superficie di Lambert).<br />
I risultati sono memorizzati in una matrice a tre dimensioni: righe, colonne e fo<strong>gli</strong>.<br />
Righe e colonne corrispondono alle dimensioni lineari <strong>del</strong>la superficie misurata, il<br />
fo<strong>gli</strong>o contiene le informazioni spettrali a una data lunghezza d’onda. In altri<br />
termini ogni fo<strong>gli</strong>o contiene una “immagine” dei valori <strong>del</strong> coefficiente di radianza<br />
<strong>del</strong>la superficie misurata a una determinata lunghezza d’onda.<br />
Completano il MIR un dispositivo per generare un riferimento dimensionale e due<br />
proiettori con lampade ad incandescenza per l’illuminazione <strong>del</strong>l’opera da<br />
misurare<br />
2.1 Il primo sottosistema<br />
Il primo sottosistema indicato per brevità col nome di “gruppo monocromatore” è<br />
composto da:<br />
– uno spettrografo a immagine con obiettivo fotografico di 50 mm di lunghezza<br />
focale;<br />
– un sensore CCD di tipo scientifico, di 256 x1024 pixel, raffreddato ad azoto con<br />
un’otturatore elettromagnetico radiale, per regolare i tempi di esposizione;<br />
– uno specchio, montato su tavole goniometriche motorizzate, in grado di ruotare<br />
su due assi tra loro perpendicolari e con il centro di rotazione sull’asse ottico<br />
<strong>del</strong>lo spettrografo.<br />
L’obiettivo fotografico focalizza l’immagine inquadrata sul piano <strong>del</strong>la fenditura<br />
d’ingresso <strong>del</strong>lo spettrografo mentre la superficie sensibile dal sensore CCD<br />
coincide con il piano focale di uscita. La zona di superficie da misurare,<br />
corrispondente alla zona inquadrata, viene determinata, previo un allineamento non<br />
critico <strong>del</strong> sistema rispetto all’opera, con la rotazione <strong>del</strong>lo specchio. Per<br />
particolari esigenze di campo inquadrato e di distanza superficie-rivelatore,<br />
l’obbiettivo può essere sostituito con uno di lunghezza focale opportuna, previa<br />
ritaratura <strong>del</strong> sistema.<br />
Lo strumento risultante ha un’elevata risoluzione spettrale, essendo basato su uno<br />
spettrografo a immagine a doppio reticolo (1200 linee/mm e 600 linee/mm) e<br />
permette di coprire tutto il campo <strong>del</strong> visibile e <strong>del</strong> vicino infrarosso. Normalmente<br />
le misurazioni sono eseguite con risoluzione di 1 nm, integrando la lettura di più<br />
183