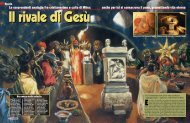Matematica curiosa - Martufi, Gabriele - Altervista
Matematica curiosa - Martufi, Gabriele - Altervista
Matematica curiosa - Martufi, Gabriele - Altervista
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
"Non ci si può illudere di poter partire dalla disciplina già confezionata, cioè da teorie e da<br />
concetti già elaborati e scritti, senza prendersi cura dei processi costruttivi che li riguardano. E'<br />
invece importante partire da situazioni didattiche che favoriscano l'insorgere di problemi<br />
matematizzabili, la pratica di procedimenti euristici per risolverli, la genesi dei concetti e delle<br />
teorie, l'approccio a sistemi assiomatici e formali. Le fonti naturali di queste situazioni sono il<br />
mondo reale, la stessa matematica e tutte le altre scienze.<br />
Il problema didattico centrale che si pone al docente nell'attuazione dei programmi risiede nella<br />
scelta di situazioni particolarmente idonee a far insorgere in modo naturale congetture, ipotesi,<br />
problemi."<br />
"Nel corso delle verifiche scritte è giustificato l'uso degli stessi sussidi didattici utilizzati<br />
nell'attività di insegnamento-apprendimento (calcolatori tascabili, strumenti da disegno, e, se<br />
ritenuto opportuno, manuali e testi scolastici)." Dalle Indicazioni metodologiche dei programmi<br />
Brocca<br />
L'indicazione metodologica più importante è quindi quella di "calare" i metodi matematici nel<br />
mondo reale, senza comunque trascurare l'aspetto formale.<br />
Sono particolarmente utili le tecniche del "problem solving" e cioè partire da situazioni<br />
problematiche concrete e facilmente intuibili dallo studente per arrivare all'individuazione e<br />
definizione dello strumento matematico utilizzabile per la risoluzione del problema. Le situazioni<br />
problematiche devono essere comprensibili e controllabili dagli studenti. L'obiettivo è quello di<br />
portare gli studenti alla costruzione di definizioni, enunciati e congetture da inquadrare<br />
successivamente da parte dell'insegnante in una teoria. La funzione dell'insegnante non è più quella<br />
di spiegare la disciplina vista come una costruzione statica, ma l'insegnante diventa il tutor degli<br />
studenti. Si passa dalla comunicazione unidirezionale al dialogo, alla creazione di situazioni<br />
didattiche, da un percorso lineare ad un percorso a rete. La lezione non è più preconfezionata, ma<br />
può prendere diverse direzioni. L'insegnante stimola gli studenti con un problema e<br />
successivamente osserva e interagisce con loro; gli input non possono essere prestabiliti ma sono<br />
funzione delle risposte degli studenti. Questo non significa che le lezioni non debbano essere<br />
preparate, anzi richiedono un lavoro di progettazione lungo e meticoloso.<br />
I programmi tradizionali erano basati soprattutto sull'algebra e sulla geometria e una grossa parte<br />
del biennio era dedicata all'apprendimento di tecniche di calcolo, i "compiti in classe" prevedevano<br />
il calcolo di espressioni o risoluzione di equazioni magari di una certa complessità.