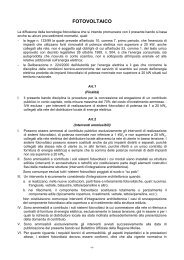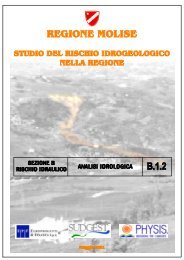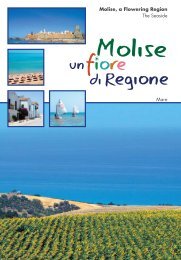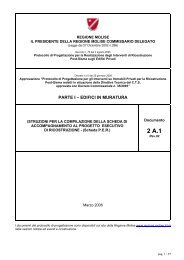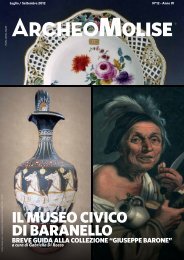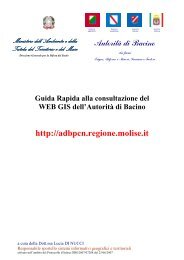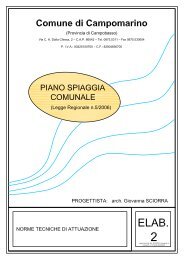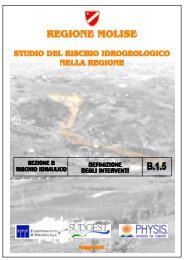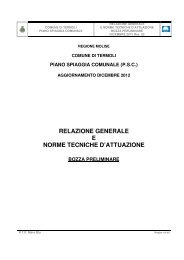Il fiume Fortore - Studi preliminari al piano di gestione dei SIC
Il fiume Fortore - Studi preliminari al piano di gestione dei SIC
Il fiume Fortore - Studi preliminari al piano di gestione dei SIC
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Il</strong> Fiu m e Fo r t o r e: s t u d i <strong>preliminari</strong> a l p ia n o d i g e s t io n e d e i <strong>SIC</strong><br />
162<br />
LA FORMA DEL TERRITORIO<br />
E LA SUA CIVILTÀ*<br />
Nell’antichità, come oggi, il corso del <strong>fiume</strong> <strong>Fortore</strong><br />
(il latino Fertor, flumen portuosum, come lo definiva<br />
Plinio nella sua Natur<strong>al</strong>is historia, III 103) segnava in<br />
parte il confine amministrativo tra le due regioni augustee<br />
corrispondenti in linea <strong>di</strong> massima <strong>al</strong> Molise e <strong>al</strong>la<br />
Puglia, rispettivamente la IV e la II. Non tutti gli storici<br />
antichi erano concor<strong>di</strong> però nel tracciare t<strong>al</strong>e confine in<br />
maniera così precisa e spesso oggi non siamo in grado<br />
<strong>di</strong> loc<strong>al</strong>izzare siti frentani o dauni nominati d<strong>al</strong>le fonti<br />
e non ancora identificati, poiché i <strong>di</strong>versi autori li posizionano<br />
nella IV o nella II regio augustea il cui confine<br />
può essere perciò posizionato anche più a nord rispetto<br />
<strong>al</strong> corso del <strong>Fortore</strong>. Come detto possiamo ritenere<br />
che più della frattura territori<strong>al</strong>e ciò che emerge è la<br />
rete <strong>di</strong> comunicazioni stabilita tra le due regioni, facente<br />
soprattutto perno sui Tratturi.<br />
Età del Bronzo<br />
Usando la rete trattur<strong>al</strong>e gli It<strong>al</strong>ici si <strong>di</strong>ffusero in tutta<br />
l’It<strong>al</strong>ia centro-meri<strong>di</strong>on<strong>al</strong>e attraverso la pratica ritu<strong>al</strong>e e<br />
<strong>di</strong> contenimento demografico del ver sacrum, ovvero<br />
una migrazione <strong>di</strong> parte della popolazione delle comunità<br />
<strong>di</strong> pastori-guerrieri dell’Appennino che perio<strong>di</strong>camente<br />
si ripeteva quando la comunità <strong>di</strong> partenza<br />
pativa un accrescimento demografico t<strong>al</strong>e da rendere<br />
insufficienti le risorse. T<strong>al</strong>e fenomeno migratorio si protrasse<br />
per centinaia <strong>di</strong> anni, costituendo una forma più<br />
o meno pacifica <strong>di</strong> assestamento <strong>dei</strong> popoli in ambiti<br />
territori<strong>al</strong>i definitivi.<br />
Età arcaica: VI - V sec. a. C.<br />
In seguito a queste migrazioni, assistiamo <strong>al</strong>la definizione<br />
e <strong>al</strong> ra<strong>di</strong>camento nel territorio <strong>dei</strong> <strong>di</strong>versi popoli<br />
<strong>di</strong> età storica, nel nostro caso Sanniti (Pentri e Frentani)<br />
e Apuli (Dauni, Peucezi e Messapi), ben <strong>di</strong>stinti<br />
tra loro d<strong>al</strong> momento del loro definitivo inse<strong>di</strong>amento<br />
in un preciso ambito. La rete <strong>dei</strong> tratturi rappresentò<br />
per questo fenomeno una base importante per molte<br />
scelte inse<strong>di</strong>ative.<br />
I dati storici ci in<strong>di</strong>cano che t<strong>al</strong>i popolazioni occupavano<br />
il territorio abbastanza densamente con <strong>di</strong>versi tipi<br />
<strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti <strong>di</strong>ffusi (villaggi, fortificazioni d’<strong>al</strong>tura,<br />
santuari, necropoli, inse<strong>di</strong>amenti agricoli…). <strong>Il</strong> modello<br />
inse<strong>di</strong>ativo sannitico è quello abitu<strong>al</strong>mente definito<br />
dagli stu<strong>di</strong>osi “paganico-vicano” da pagus (<strong>di</strong>stretto<br />
territori<strong>al</strong>e) e vicus (inse<strong>di</strong>amento abitativo). Esso era<br />
impostato sul concetto <strong>di</strong> base che la comunità ed il<br />
suo territorio sono due entità inscin<strong>di</strong>bili, per cui la<br />
comunità non si identificava in una città capit<strong>al</strong>e che<br />
dominava un territorio ad essa sottoposto, ma in un<br />
intero <strong>di</strong>stretto territori<strong>al</strong>e nell’ambito del qu<strong>al</strong>e erano<br />
presenti capillarmente sparse tutte le necessarie forme<br />
inse<strong>di</strong>ative con rispettive funzioni: abitative, produttive,<br />
strategiche, sacr<strong>al</strong>i. T<strong>al</strong>e modello risulta pertanto<br />
generato ad un grado <strong>di</strong> sviluppo economico-soci<strong>al</strong>e<br />
pre-urbano.<br />
Nel corso del V sec. a.C. si assiste ad una decisa espansione<br />
territori<strong>al</strong>e <strong>dei</strong> Sanniti nella stessa <strong>di</strong>rettrice <strong>di</strong><br />
conquista seguita dai Romani, v<strong>al</strong>e a <strong>di</strong>re verso i territori<br />
fertili della Campania interna e della v<strong>al</strong>le del Liri.<br />
I Sanniti e i Romani entrano da questo momento in<br />
contatto e il loro incontro si tramuterà presto in un<br />
contrasto, le famose guerre sannitiche che, dopo <strong>al</strong>terne<br />
vicende, vedranno vincitrice Roma e segneranno<br />
chiaramente l’affermazione della “volontà <strong>di</strong> potenza”<br />
dell’espansionismo romano, prima nella penisola it<strong>al</strong>ica,<br />
poi in tutto il Me<strong>di</strong>terraneo.<br />
D<strong>al</strong> IV sec. a. C., la romanizzazione<br />
Dopo la fine delle guerre sannitiche, durate complessivamente<br />
d<strong>al</strong> 343 <strong>al</strong> 268 a.C., v<strong>al</strong>e a <strong>di</strong>re 75 anni, inizia<br />
un processo evolutivo che mo<strong>di</strong>ficò nettamente il paesaggio<br />
e l’economia. Nelle aree sannitiche cambia il<br />
modo <strong>di</strong> usare ed organizzare il territorio, si assiste ad<br />
un’evoluzione netta <strong>dei</strong> modelli inse<strong>di</strong>ativi tipici <strong>di</strong> tutta<br />
l’area appenninica. <strong>Il</strong> potere romano tende a cancellare<br />
i luoghi politicamente più significativi, i più popolosi ed<br />
importanti dello stato sannitico; tende ad eliminare gli<br />
inse<strong>di</strong>amenti fortificati d’<strong>al</strong>tura che durante le guerre<br />
sannitiche avevano avuto prettamente funzione militare<br />
e <strong>di</strong> controllo del territorio; tende a riorganizzare il<br />
territorio in funzione <strong>di</strong> un nuovo tipo <strong>di</strong> economia e <strong>di</strong><br />
amministrazione, imperniato sul tipo inse<strong>di</strong>ativo della<br />
città, immessa in un territorio che fino ad <strong>al</strong>lora non<br />
l’aveva conosciuto e non ne aveva sentito il bisogno.<br />
<strong>Il</strong> pagus lascia il posto <strong>al</strong>la civitas. Al modello autarchico<br />
in<strong>di</strong>stinto ed omnicomprensivo paganico-vicano,<br />
Roma sostituisce due entità <strong>di</strong>verse e definite, con funzioni<br />
nettamente <strong>di</strong>stinte: il municipium 2 e la villa rustica,<br />
l’uno con ruolo residenzi<strong>al</strong>e e politico, l’<strong>al</strong>tra con<br />
mansioni produttive speci<strong>al</strong>izzate per lo sfruttamento<br />
intensivo delle campagne più fertili. Questo genere <strong>di</strong><br />
organizzazione causò gravi danni <strong>al</strong> territorio, in particolare<br />
<strong>al</strong>le zone montane; i Sanniti, infatti, con il loro<br />
sistema <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti <strong>di</strong>ffusi, avevano occupato il<br />
territorio in maniera integr<strong>al</strong>e ed omogenea fin nelle<br />
zone apparentemente meno favorite e maggiormente<br />
<strong>di</strong>sagiate. Invece l’organizzazione romana che poneva<br />
la città in una posizione assolutamente centr<strong>al</strong>e, fece<br />
sì che questa <strong>di</strong>ventasse l’unico punto <strong>di</strong> riferimento<br />
per le questioni politiche, amministrative, economiche<br />
e religiose e favorì un processo <strong>di</strong> spopolamento e <strong>di</strong><br />
abbandono delle aree montane più interne.<br />
Diventati socii <strong>di</strong> Roma, i Sanniti vissero un periodo <strong>di</strong><br />
assestamento durante il qu<strong>al</strong>e subirono mo<strong>di</strong>ficazioni<br />
drastiche della loro identità cultur<strong>al</strong>e ma che trascorsero<br />
in una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> pace e <strong>di</strong> relativa prosperità<br />
economica. E’ noto che i Sanniti non si ribellarono neppure<br />
durante la campagna in It<strong>al</strong>ia <strong>di</strong> Annib<strong>al</strong>e della II<br />
2 Non sono noti d<strong>al</strong>le fonti municipia fondati nell’area del <strong>Fortore</strong>.