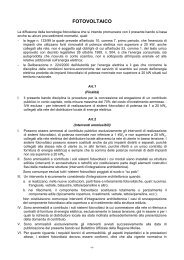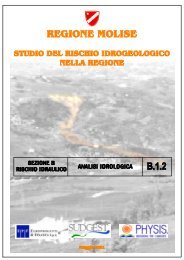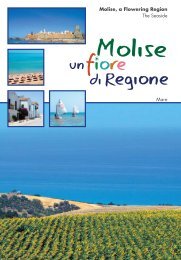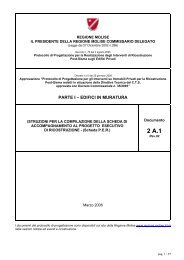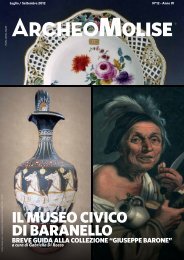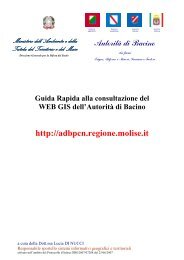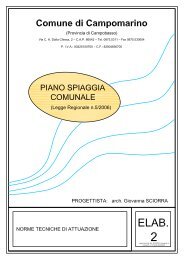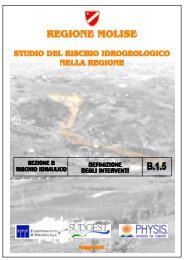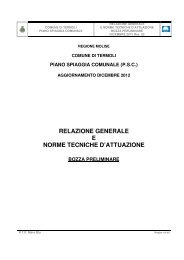Il fiume Fortore - Studi preliminari al piano di gestione dei SIC
Il fiume Fortore - Studi preliminari al piano di gestione dei SIC
Il fiume Fortore - Studi preliminari al piano di gestione dei SIC
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
An t o n e l l a Ar e n a<br />
CENSIMENTO STORICO ARTISTICO - PUGLIA<br />
Introduzione<br />
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura<br />
e la ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio<br />
storico e artistico della nazione”, questo<br />
enunciato è posto tra i principi fondament<strong>al</strong>i della<br />
Costituzione it<strong>al</strong>iana (art. 9), caratterizzando la<br />
Repubblica it<strong>al</strong>iana come uno Stato <strong>di</strong> cultura. Nonostante<br />
le intenzioni fossero serie ed accorate, il<br />
periodo storico, con l’urgenza della ricostruzione<br />
post-bellica, trascurò quelli che erano gli obblighi<br />
istituzion<strong>al</strong>i nei confronti <strong>di</strong> uno <strong>dei</strong> patrimoni più<br />
ricchi <strong>al</strong> mondo.<br />
Un passaggio importante fu l’apertura <strong>dei</strong> lavori della<br />
Commissione Franceschini (Legge 26 aprile 1964,<br />
n. 310), una commissione d’indagine per la tutela<br />
e la v<strong>al</strong>orizzazione delle cose <strong>di</strong> interesse storico,<br />
archeologico, artistico e del paesaggio. La commissione<br />
svolse, con la presentazione della relazione<br />
“Per la s<strong>al</strong>vezza <strong>dei</strong> beni cultur<strong>al</strong>i in It<strong>al</strong>ia”, un lavoro<br />
encomiabile che segn<strong>al</strong>ava sia le insufficienze della<br />
<strong>gestione</strong> pubblica del patrimonio cultur<strong>al</strong>e sia gli in<strong>di</strong>rizzi<br />
fondament<strong>al</strong>i per una nuova legge <strong>di</strong> tutela<br />
storico-artistica e paesaggistica.<br />
<strong>Il</strong> merito princip<strong>al</strong>e della commissione parlamentare<br />
è quello <strong>di</strong> aver per la prima volta in<strong>di</strong>viduato<br />
il concetto <strong>di</strong> bene cultur<strong>al</strong>e e ambient<strong>al</strong>e, concetto<br />
esplicitato nel volume <strong>di</strong> Andrea Emiliani “Una<br />
nuova politica <strong>dei</strong> beni cultur<strong>al</strong>i”: viene così definito<br />
il principio che tutte le aree natur<strong>al</strong>i in cui il bene<br />
cultur<strong>al</strong>e si colloca (“Sono beni cultur<strong>al</strong>i le cose immobili<br />
e mobili appartenenti <strong>al</strong>lo Stato, <strong>al</strong>le regioni,<br />
agli <strong>al</strong>tri enti pubblici territori<strong>al</strong>i, nonché ad ogni <strong>al</strong>tro<br />
ente ed istituto pubblico e a persone giuri<strong>di</strong>che<br />
private senza fine <strong>di</strong> lucro, che presentano interesse<br />
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”,<br />
art. 10, comma 1, D.Lvo. n. 42/2004) sono beni<br />
pubblici nei cui confronti lo Stato deve esercitare la<br />
sua sovranità e tutela. L’inter<strong>di</strong>pendenza tra fattori<br />
storico-soci<strong>al</strong>i-natur<strong>al</strong>i sollecita a considerare in<br />
modo legittimo come beni cultur<strong>al</strong>i sia i beni natur<strong>al</strong>i<br />
“fondament<strong>al</strong>i” (terra, acqua, aria, flora, fauna),<br />
sia i beni storici, interpretati come segni delle civiltà<br />
che si sono succedute nel territorio.<br />
<strong>Il</strong> corso ‘pugliese’ del <strong>fiume</strong> <strong>Fortore</strong>, appunto, è un<br />
ricco ed intricato p<strong>al</strong>insesto <strong>di</strong> testimonianze storico-artistiche,<br />
la cui eccezion<strong>al</strong>ità ricade non tanto<br />
nell’essere stati <strong>di</strong>mora <strong>di</strong> antiche popolazioni o potenti<br />
re ed imperatori, quanto piuttosto nell’essere<br />
sopravvissuti <strong>al</strong>la <strong>di</strong>sumana noncuranza dell’uomo<br />
moderno e contemporaneo, nonché, e per <strong>al</strong>cuni<br />
manufatti in particolare, per essere stati costantemente<br />
<strong>di</strong>menticati d<strong>al</strong>le amministrazioni, territori<strong>al</strong>mente<br />
competenti, che a tutt’oggi ancora non assumono<br />
adeguati strumenti conservativi.<br />
La ricognizione <strong>dei</strong> beni storico-artistici presenti nel<br />
<strong>SIC</strong> “V<strong>al</strong>le <strong>Fortore</strong> Lago <strong>di</strong> Occhito” procederà su basi<br />
cronologiche, riguardando le princip<strong>al</strong>i emergenze<br />
architettoniche ed archeologiche, frutto della storia<br />
<strong>di</strong> cui questi luoghi sono stati teatro.<br />
Antiche civiltà<br />
L’acqua è da sempre stata la prima fonte <strong>di</strong> vita ed<br />
è proprio nei suoi pressi, sulla riva destra del <strong>fiume</strong><br />
<strong>Fortore</strong> (l’antico Frento) a 19 km d<strong>al</strong>la sua foce ed<br />
a 4 a nord dell’attu<strong>al</strong>e San Paolo <strong>di</strong> Civitate, in una<br />
posizione <strong>di</strong> gran<strong>di</strong>ssima importanza strategica, che<br />
l’antica civiltà dauna fece sorgere l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong><br />
Tiati-Teanum Apulum. Dai colli su cui sorgeva, Tiati<br />
dominava la v<strong>al</strong>le del <strong>fiume</strong> <strong>Fortore</strong>, guadabile proprio<br />
nel punto ubicato ai pie<strong>di</strong> dell’antico inse<strong>di</strong>amento,<br />
in corrispondenza dell’attu<strong>al</strong>e ponte della<br />
strada stat<strong>al</strong>e San Paolo Civitate-Serracapriola. Inoltre<br />
Tiati dominava la costa adriatica fino <strong>al</strong>le Isole Tremiti,<br />
controllando così gli accessi da nord e da ovest, nonché<br />
la pianura orient<strong>al</strong>e che si estende fino <strong>al</strong>le pen<strong>di</strong>ci<br />
del promontorio garganico. Qu<strong>al</strong>e punto nod<strong>al</strong>e<br />
e passaggio obbligato per l’ingresso <strong>al</strong>la pianura del<br />
tavoliere, Tiati fondò il suo sviluppo e la sua importanza<br />
nell’antichità.<br />
Convenzion<strong>al</strong>mente Tiati-Teanum Apulum è considerato<br />
un centro della Daunia; la civiltà daunia fiorì nella<br />
Puglia settentrion<strong>al</strong>e tra il IX e il IV secolo a.C.. L’area<br />
abitata dai Dauni coincide con l’attu<strong>al</strong>e provincia <strong>di</strong><br />
Foggia, ma con estensioni nel Melfese e nella v<strong>al</strong>le<br />
dell’Ofanto. Le fonti antiche non sono tutte concor<strong>di</strong><br />
nella definizione <strong>dei</strong> confini settentrion<strong>al</strong>i della Daunia<br />
e t<strong>al</strong>e incertezza è data d<strong>al</strong> movimento delle popolazioni<br />
osco-sannitiche, d<strong>al</strong>la dors<strong>al</strong>e appenninica<br />
molisana, irpina e lucana verso est, che portò ad oscillazioni<br />
della linea <strong>di</strong> confine tra Daunia e popolazioni<br />
sannitiche, pertanto, l’area compresa tra i fiumi Biferno<br />
e <strong>Fortore</strong> ha presentato sempre, nel corso della<br />
storia, tutte le caratteristiche proprie <strong>di</strong> una zona <strong>di</strong><br />
confine.<br />
La scelta del luogo in cui l’uomo doveva vivere stabilmente<br />
è sempre stato, per gli uomini primitivi, un<br />
problema <strong>di</strong> essenzi<strong>al</strong>e importanza, strettamente legato<br />
<strong>al</strong>la propria sopravvivenza. Mentre gli uomini del<br />
p<strong>al</strong>eolitico antico abitarono, in prev<strong>al</strong>enza, le impervie<br />
zone del Gargano, poiché ricco <strong>di</strong> caccia, quelli del<br />
p<strong>al</strong>eolitico me<strong>di</strong>o e superiore preferirono stabilirsi in<br />
prossimità <strong>di</strong> coste e laghi, mentre gli uomini neolitici,<br />
de<strong>di</strong>ti <strong>al</strong>l’agricoltura e <strong>al</strong>l’<strong>al</strong>levamento, si stanziarono<br />
in luoghi asciutti, con un interland molto ampio<br />
e fertile.<br />
Presentando molti <strong>di</strong> questi requisiti, il Tavoliere fu il<br />
territorio più abitato e più frequentato nel periodo<br />
neolitico.<br />
A tutt’oggi si conoscono circa duemila inse<strong>di</strong>amenti<br />
neolitici, cosiddetti “villaggi trincerati”, quasi tutti po-<br />
197