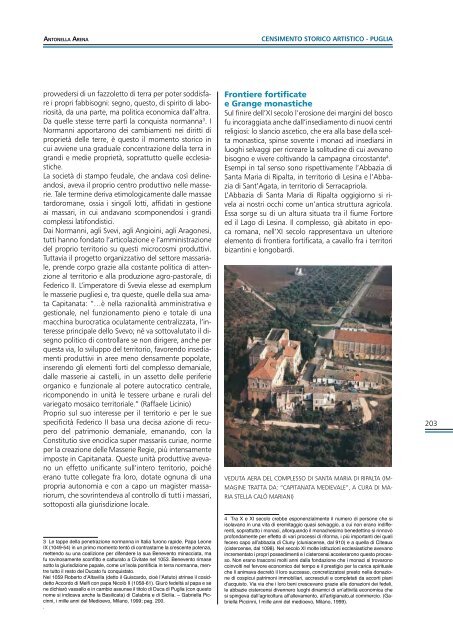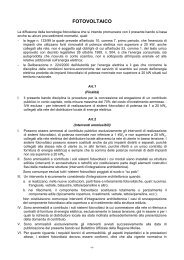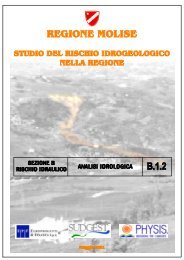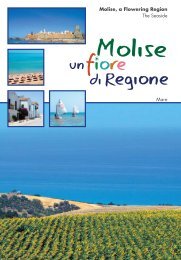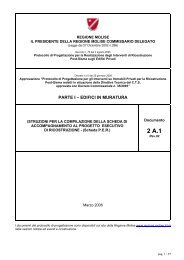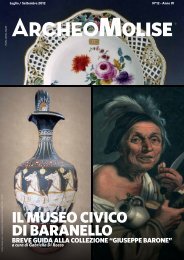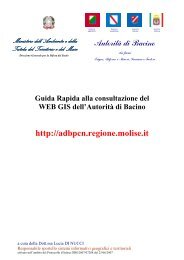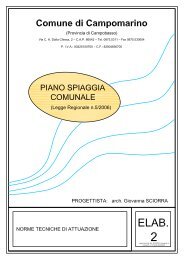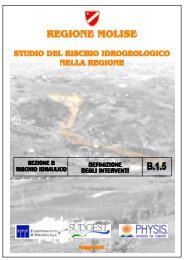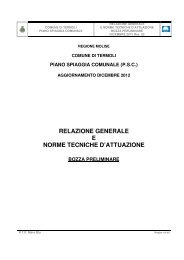Il fiume Fortore - Studi preliminari al piano di gestione dei SIC
Il fiume Fortore - Studi preliminari al piano di gestione dei SIC
Il fiume Fortore - Studi preliminari al piano di gestione dei SIC
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
An t o n e l l a Ar e n a<br />
CENSIMENTO STORICO ARTISTICO - PUGLIA<br />
provvedersi <strong>di</strong> un fazzoletto <strong>di</strong> terra per poter sod<strong>di</strong>sfare<br />
i propri fabbisogni: segno, questo, <strong>di</strong> spirito <strong>di</strong> laboriosità,<br />
da una parte, ma politica economica d<strong>al</strong>l’<strong>al</strong>tra.<br />
Da quelle stesse terre partì la conquista normanna 3 . I<br />
Normanni apportarono <strong>dei</strong> cambiamenti nei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong><br />
proprietà delle terre, è questo il momento storico in<br />
cui avviene una gradu<strong>al</strong>e concentrazione della terra in<br />
gran<strong>di</strong> e me<strong>di</strong>e proprietà, soprattutto quelle ecclesiastiche.<br />
La società <strong>di</strong> stampo feud<strong>al</strong>e, che andava così delineandosi,<br />
aveva il proprio centro produttivo nelle masserie.<br />
T<strong>al</strong>e termine deriva etimologicamente d<strong>al</strong>le massae<br />
tardoromane, ossia i singoli lotti, affidati in <strong>gestione</strong><br />
ai massari, in cui andavano scomponendosi i gran<strong>di</strong><br />
complessi latifon<strong>di</strong>stici.<br />
Dai Normanni, agli Svevi, agli Angioini, agli Aragonesi,<br />
tutti hanno fondato l’articolazione e l’amministrazione<br />
del proprio territorio su questi microcosmi produttivi.<br />
Tuttavia il progetto organizzativo del settore massari<strong>al</strong>e,<br />
prende corpo grazie <strong>al</strong>la costante politica <strong>di</strong> attenzione<br />
<strong>al</strong> territorio e <strong>al</strong>la produzione agro-pastor<strong>al</strong>e, <strong>di</strong><br />
Federico II. L’imperatore <strong>di</strong> Svevia elesse ad exemplum<br />
le masserie pugliesi e, tra queste, quelle della sua amata<br />
Capitanata: “…è nella razion<strong>al</strong>ità amministrativa e<br />
gestion<strong>al</strong>e, nel funzionamento pieno e tot<strong>al</strong>e <strong>di</strong> una<br />
macchina burocratica oculatamente centr<strong>al</strong>izzata, l’interesse<br />
princip<strong>al</strong>e dello Svevo; né va sottov<strong>al</strong>utato il <strong>di</strong>segno<br />
politico <strong>di</strong> controllare se non <strong>di</strong>rigere, anche per<br />
questa via, lo sviluppo del territorio, favorendo inse<strong>di</strong>amenti<br />
produttivi in aree meno densamente popolate,<br />
inserendo gli elementi forti del complesso demani<strong>al</strong>e,<br />
d<strong>al</strong>le masserie ai castelli, in un assetto delle periferie<br />
organico e funzion<strong>al</strong>e <strong>al</strong> potere autocratico centr<strong>al</strong>e,<br />
ricomponendo in unità le tessere urbane e rur<strong>al</strong>i del<br />
variegato mosaico territori<strong>al</strong>e.” (Raffaele Licinio)<br />
Proprio sul suo interesse per il territorio e per le sue<br />
specificità Federico II basa una decisa azione <strong>di</strong> recupero<br />
del patrimonio demani<strong>al</strong>e, emanando, con la<br />
Constitutio sive enciclica super massariis curiae, norme<br />
per la creazione delle Masserie Regie, più intensamente<br />
imposte in Capitanata. Queste unità produttive avevano<br />
un effetto unificante sull’intero territorio, poiché<br />
erano tutte collegate fra loro, dotate ognuna <strong>di</strong> una<br />
propria autonomia e con a capo un magister massariorum,<br />
che sovrintendeva <strong>al</strong> controllo <strong>di</strong> tutti i massari,<br />
sottoposti <strong>al</strong>la giuris<strong>di</strong>zione loc<strong>al</strong>e.<br />
3 Le tappe della penetrazione normanna in It<strong>al</strong>ia furono rapide. Papa Leone<br />
IX (1049-54) in un primo momento tentò <strong>di</strong> contrastarne la crescente potenza,<br />
mettendo su una co<strong>al</strong>izione per <strong>di</strong>fendere la sua Benevento minacciata, ma<br />
fu rovinosamente sconfitto e catturato a Civitate nel 1053. Benevento rimase<br />
sotto la giuris<strong>di</strong>zione pap<strong>al</strong>e, come un’isola pontificia in terra normanna, mentre<br />
tutto il resto del Ducato fu conquistato.<br />
Nel 1059 Roberto d’Altavilla (detto il Guiscardo, cioè l’Astuto) strinse il cosiddetto<br />
Accordo <strong>di</strong> Melfi con papa Nicolò II (1058-61). Giurò fedeltà <strong>al</strong> papa e se<br />
ne <strong>di</strong>chiarò vass<strong>al</strong>lo e in cambio assunse il titolo <strong>di</strong> Duca <strong>di</strong> Puglia (con questo<br />
nome si in<strong>di</strong>cava anche la Basilicata) <strong>di</strong> C<strong>al</strong>abria e <strong>di</strong> Sicilia. – Gabriella Piccinni,<br />
i mille anni del Me<strong>di</strong>oevo, Milano, 1999; pag. 200.<br />
.<br />
Frontiere fortificate<br />
e Grange monastiche<br />
Sul finire dell’XI secolo l’erosione <strong>dei</strong> margini del bosco<br />
fu incoraggiata anche d<strong>al</strong>l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> nuovi centri<br />
religiosi: lo slancio ascetico, che era <strong>al</strong>la base della scelta<br />
monastica, spinse sovente i monaci ad inse<strong>di</strong>arsi in<br />
luoghi selvaggi per ricreare la solitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> cui avevano<br />
bisogno e vivere coltivando la campagna circostante 4 .<br />
Esempi in t<strong>al</strong> senso sono rispettivamente l’Abbazia <strong>di</strong><br />
Santa Maria <strong>di</strong> Rip<strong>al</strong>ta, in territorio <strong>di</strong> Lesina e l’Abbazia<br />
<strong>di</strong> Sant’Agata, in territorio <strong>di</strong> Serracapriola.<br />
L’Abbazia <strong>di</strong> Santa Maria <strong>di</strong> Rip<strong>al</strong>ta oggigiorno si rivela<br />
ai nostri occhi come un’antica struttura agricola.<br />
Essa sorge su <strong>di</strong> un <strong>al</strong>tura situata tra il <strong>fiume</strong> <strong>Fortore</strong><br />
ed il Lago <strong>di</strong> Lesina. <strong>Il</strong> complesso, già abitato in epoca<br />
romana, nell’XI secolo rappresentava un ulteriore<br />
elemento <strong>di</strong> frontiera fortificata, a cav<strong>al</strong>lo fra i territori<br />
bizantini e longobar<strong>di</strong>.<br />
Veduta aera del complesso <strong>di</strong> Santa Maria <strong>di</strong> Rip<strong>al</strong>ta (immagine<br />
tratta da: “Capitanata me<strong>di</strong>ev<strong>al</strong>e”, a cura <strong>di</strong> Maria<br />
Stella C<strong>al</strong>ò Mariani)<br />
4 Tra X e XI secolo crebbe esponenzi<strong>al</strong>mente il numero <strong>di</strong> persone che si<br />
isolavano in una vita <strong>di</strong> eremitaggio quasi selvaggio, a cui non erano in<strong>di</strong>fferenti,<br />
soprattutto i monaci, <strong>al</strong>lorquando il monachesimo benedettino si rinnovò<br />
profondamente per effetto <strong>di</strong> vari processi <strong>di</strong> riforma, i più importanti <strong>dei</strong> qu<strong>al</strong>i<br />
fecero capo <strong>al</strong>l’abbazia <strong>di</strong> Cluny (cluniacense, d<strong>al</strong> 910) e a quella <strong>di</strong> Citeaux<br />
(cistercense, d<strong>al</strong> 1098). Nel secolo XI molte istituzioni ecclesiastiche avevano<br />
incrementato i propri posse<strong>di</strong>menti e i cistercensi accelerarono questo processo.<br />
Non erano trascorsi molti anni d<strong>al</strong>la fondazione che i monaci si trovarono<br />
coinvolti nel fervore economico del tempo e il prestigio per la carica spiritu<strong>al</strong>e<br />
che li animava decretò il loro successo, concretizzatosi presto nella donazione<br />
<strong>di</strong> cospicui patrimoni immobiliari, accresciuti e completati da accorti piani<br />
d’acquisto. Via via che i loro beni crescevano grazie <strong>al</strong>le donazioni <strong>dei</strong> fedeli,<br />
le abbazie cistercensi <strong>di</strong>vennero luoghi <strong>di</strong>namici <strong>di</strong> un’attività economica che<br />
si spingeva d<strong>al</strong>l’agricoltura <strong>al</strong>l’<strong>al</strong>levamento, <strong>al</strong>l’artigianato,<strong>al</strong> commercio. (Gabriella<br />
Piccinni, I mille anni del me<strong>di</strong>oevo, Milano, 1999).<br />
203