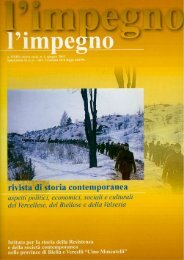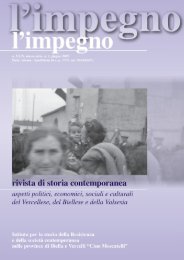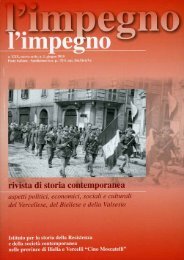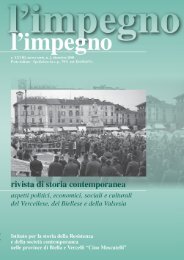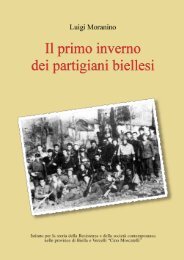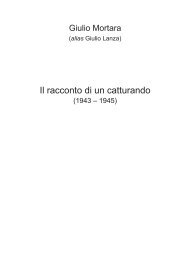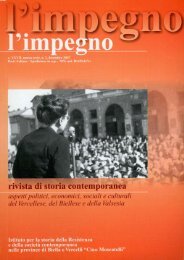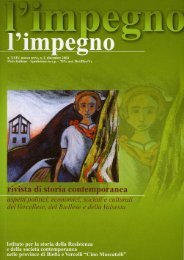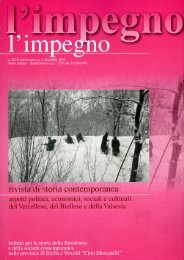"l'impegno" in formato pdf - Istituto per la storia della Resistenza e ...
"l'impegno" in formato pdf - Istituto per la storia della Resistenza e ...
"l'impegno" in formato pdf - Istituto per la storia della Resistenza e ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ste ultime più combattive <strong>in</strong> quanto consapevoli<br />
del<strong>la</strong> necessità e dell’<strong>in</strong>evitabilità<br />
dell’uso del<strong>la</strong> forza quale unico mezzo <strong>per</strong><br />
affrontare <strong>la</strong> reazione, caddero di fronte ai<br />
fascisti; dove questi <strong>in</strong>contravano resistenza<br />
<strong>in</strong>tervenne <strong>in</strong> aiuto <strong>la</strong> forza pubblica.<br />
Il Pcd’I, nei suoi documenti ufficiali, rimase<br />
fermo nell’idea che il fenomeno fascista<br />
non possedesse alcuna autonomia<br />
politica e non rappresentasse una peculiarità<br />
nazionale. La reazione italiana venne<br />
assimi<strong>la</strong>ta a quel<strong>la</strong> europea; il fascismo identificato<br />
“come uno dei mezzi più caratteristici<br />
del<strong>la</strong> presente reazione borghese”<br />
13 e conseguentemente accostato ai movimenti<br />
sorti <strong>in</strong> funzione antiproletaria <strong>in</strong><br />
F<strong>in</strong><strong>la</strong>ndia, Baviera, Ungheria e, più <strong>in</strong> generale,<br />
alle “guardie bianche”.<br />
Bordiga, il dirigente più <strong>in</strong>fluente del<br />
Federico Caneparo<br />
partito nei suoi primi anni di vita, sviluppò<br />
f<strong>in</strong>o alle estreme conseguenze questa posizione,<br />
<strong>in</strong>dividuando nel fascismo un elemento<br />
<strong>in</strong>tegratore dello stato democratico<br />
borghese e <strong>per</strong>ciò non antitetico 14 ad esso.<br />
Il dirigente napoletano fonda <strong>la</strong> sua analisi<br />
sul fascismo partendo dall’identificazione<br />
del<strong>la</strong> dittatura capitalistica con <strong>la</strong> democrazia,<br />
def<strong>in</strong>ita con toni sprezzanti quale<br />
“ottimo sfiatatoio del<strong>la</strong> pressione del suo<br />
[del<strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse o<strong>per</strong>aia, nda] meccanismo<br />
economico”; e non esita a spendere parole<br />
che, a tratti, paiono <strong>in</strong>dicare ammirazione<br />
<strong>per</strong> l’efficienza di c<strong>la</strong>sse del<strong>la</strong> democrazia.<br />
Successivamente riesce evidente al<strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse<br />
dom<strong>in</strong>ante che il regime democratico<br />
serve anche contro il proletariato come ottimo<br />
“sfiatatoio” del<strong>la</strong> eccessiva pressione<br />
del suo malcontento economico, e <strong>la</strong> bor-<br />
13 ANTONIO GRAZIADEI, Le es<strong>per</strong>ienze del fascismo, <strong>in</strong> “Ord<strong>in</strong>e Nuovo”, 23 maggio 1921.<br />
14 Il giudizio sul fenomeno fascista e sul<strong>la</strong> sua natura non fu univoco all’<strong>in</strong>terno del partito.<br />
Gramsci dedicò a questo tema buona parte dei suoi articoli, giungendo a conclusioni<br />
<strong>in</strong> parte autonome. Congiuntamente ad <strong>in</strong>terpretazioni che tendevano a contestualizzare<br />
il fenomeno fascista all’<strong>in</strong>terno di un orizzonte non prettamente nazionale, considerandolo<br />
fenomeno <strong>in</strong>ternazionale generato dalle conseguenze del conflitto e dal<strong>la</strong> <strong>in</strong>cipiente<br />
crisi del sistema capitalista (cfr. A. GRAMSCI, Italia e Spagna, cit.), coesisteva un tentativo<br />
di analizzare il fascismo a partire dal peculiare svilupparsi del processo di unificazione<br />
dello stato italiano e del<strong>la</strong> predisposizione psicologica delle c<strong>la</strong>ssi borghesi (cfr. ID, Forze<br />
elementari, <strong>in</strong> “Ord<strong>in</strong>e Nuovo”, 26 aprile 1921; ID, I due fascismi, <strong>in</strong> “Ord<strong>in</strong>e Nuovo”, 25<br />
agosto 1921). Le sue componenti sociali erano ravvisate nel<strong>la</strong> picco<strong>la</strong> borghesia urbana,<br />
uscita dal conflitto svuotata del potere decisionale e desiderosa di riappropriarsene (cfr.<br />
ID, Il popolo delle scimmie, <strong>in</strong> “Ord<strong>in</strong>e Nuovo”, 2 gennaio 1921) e <strong>la</strong> borghesia agraria,<br />
desiderosa di riacquisire il completo controllo sulle campagne. Lo sviluppo impetuoso<br />
del movimento nei primi mesi del 1921 contribuì a sviluppare <strong>in</strong> Gramsci l’idea del<strong>la</strong><br />
possibilità di un eventuale colpo di stato da parte dei fascisti (cfr. ID, Socialisti e fascisti,<br />
<strong>in</strong> “Ord<strong>in</strong>e Nuovo”, 11 giugno 1921; ID, Colpo di stato, <strong>in</strong> “Ord<strong>in</strong>e Nuovo”, 27 luglio 1921).<br />
Questa prospettiva era <strong>in</strong> contrasto con quel<strong>la</strong> paventata dal<strong>la</strong> maggior parte dei dirigenti<br />
del Pcd’I <strong>per</strong>ché ammetteva che il fascismo, lungi dall’essere esclusivamente uno strumento<br />
nelle mani delle c<strong>la</strong>ssi dirigenti potesse, <strong>in</strong> nome delle esigenze produttive del<strong>la</strong> borghesia<br />
media ed agraria, conquistare il potere ed abolire <strong>la</strong> legalità, <strong>in</strong>staurando un regime esplicitamente<br />
reazionario. Il distacco dalle concezioni bordighiane (l’esponente più <strong>in</strong>fluente<br />
nel partito) tende a scemare quando si prende <strong>in</strong> considerazione l’atteggiamento di Gramsci<br />
rispetto al Psi. Dopo <strong>la</strong> conclusione del patto di pacificazione e <strong>la</strong> nom<strong>in</strong>a dell’ex socialista<br />
Bonomi a capo del governo, anche <strong>per</strong> il nostro sembrò che si stesse <strong>per</strong> aprire una stagione<br />
socialdemocratica (cfr. ID, Bonomi, <strong>in</strong> “Ord<strong>in</strong>e Nuovo”, 5 luglio 1921)<br />
46 l’impegno