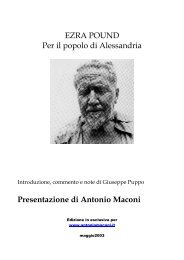Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
trascendenza, da Platone dualista, che crea i miti del Demiurgo e dell’anima mundi,<br />
e da Aristotele, monista dell’immanenza, che non conosce né miti né alcuna<br />
trascendenza” 45 .<br />
Di conseguenza non si può non convenire con il motivato giudizio di Fabro,<br />
secondo cui “l’Angelico ha prodotto una sintesi nuova in cui la nozione platonica di<br />
partecipazione incorpora la dottrina aristotelica dell’atto e <strong>della</strong> potenza in una<br />
sintesi originale e diventa ... la chiave per la soluzione dei problemi fondamentali<br />
come la creazione, la causalità, la composizione dell’ente finito, l’analogia. Verso<br />
la fine <strong>della</strong> vita san Tommaso poteva proclamare. Mediante un’esegesi unica in<br />
tutto il medioevo e che rappresenta il punto di vista superiore da lui raggiunto, che<br />
in questa prospettiva superiore <strong>della</strong> partecipazione Platone e Aristotele si trovano<br />
d’accordo” 46 .<br />
La contestazione <strong>della</strong> <strong>filosofia</strong> di san Tommaso produsse spontaneamente il<br />
disarmo degli intellettuali e l’allontanamento dall’orizzonte <strong>della</strong> metafisica. Il<br />
risultato del fideismo fu l’indirizzo <strong>della</strong> <strong>filosofia</strong> alla neutralità scettica e alla<br />
scienza secolarizzata.<br />
<br />
Ora l’opposizione al tomismo iniziò pochi anni dopo la morte di san Tommaso.<br />
Nel 1277, quarant’anni prima che il francescano Guglielmo Occam 47 desse inizio<br />
45 Id., id., pag. 57.<br />
46 Id., id., pag. 202. A questo proposito va sottolineata l’acuta interpretazione di Gilson, che ponendo il<br />
problema di “sapere come mai i filosofi che hanno scoperto quei princìpi abbiano potuto<br />
misconoscerne a tal punto le conseguenze necessarie” (che furono invece dedotte da san Tommaso)<br />
conclude che “ciò deriva dal fatto che Platone e Aristotele non sono riusciti a discernere il significato<br />
pieno delle nozioni che sono stati i primi a definire, perché non hanno approfondito il problema<br />
dell’essere sino al punto nel quale, superando il piano dell’intelligibilità, esso raggiunge quello<br />
dell’esistenza”. San Tommaso, invece in quelle formule si trovò a suo agio, “perché poteva leggervi<br />
parecchie verità ch’esse contengono, sebbene né Platone né Aristotele stesso ve le abbiano decifrate.<br />
... Platone e Aristotele erano sulla buona via, e appunto perché erano sulla buona via, superarli fu un<br />
progresso” Cfr. “Lo spirito <strong>della</strong> <strong>filosofia</strong> medioevale”, op. cit., pag. 100-101.<br />
47 Guglielmo di Occam (1290-1349) dopo essere entrato nell’ordine francescano, nel 1310 iniziò lo<br />
studio <strong>della</strong> teologia a Oxford, dove tra il 1315 e il 1317 tenne corsi sulla Bibbia e sulle Sentenze. Nel<br />
1328, in conseguenza dei suoi attacchi alle costituzioni papali sulla povertà evangelica e delle tesi<br />
eterodosse sui rapporti tra potere ecclesiastico e potere politico, fu scomunicato da Giovanni XXII.<br />
Insieme con altri esponenti dell’ordine francescano, fra i quali Marsilio da Padova, Occam si rifugiò<br />
allora a Pisa sotto la protezione dell’imperatore Ludovico il Bavaro. I medievalisti concordano<br />
nell’attribuire ad Occam il proclama di Francoforte (8 agosto 1338) nel quale si sosteneva che l’autorità<br />
imperiale deriva direttamente da Dio. Nel 1340, dopo il declino <strong>della</strong> fortuna politica di Ludovico il<br />
Bavaro, Occam tentò di riconciliarsi con il papato. Morì durante l’epidemia di peste del 1350. La sua<br />
<strong>filosofia</strong> è generalmente interpretata come il risultato di una scorretta difesa dell’onnipotenza di Dio e<br />
di un’animosa opposizione a Duns Scoto e al realismo esagerato (la dottrina che affermava l’esistenza<br />
di cose universali corrispondenti ai termini universali). La contestazione occamista del realismo<br />
esagerato, tuttavia, coinvolse anche il realismo moderato di san Tommaso, secondo cui Dio crea le cose<br />
appartenenti alla stessa specie secondo un’idea <strong>della</strong> mente divina. Sulla complessa questione<br />
19