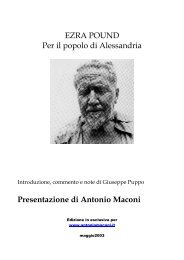Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Gentile incontrò una difficoltà insormontabile: identificare l’essere con l’atto del pensare<br />
significa, infatti, definire un atto vuoto di contenuto. Nelle riforma gentiliana, l’idealismo<br />
sopravviveva alle interne contraddizioni riducendosi a culto storicistico 24 . Sciacca<br />
sosteneva pertanto che la riduzione dell’idea alla soggettività dell’atto “portò il Gentile ad<br />
identificare la <strong>filosofia</strong> con la storia e con questa tutto il reale in un immanentismo, che è<br />
positivismo e non più idealismo autentico; e se non lo è fino in fondo si deve alla felice<br />
contraddizione che il pensiero pensante trascende tutto il pensiero pensato e perciò la<br />
storia. E’ approfondendo questo punto, fino a capovolgere le premesse e le conclusioni, che<br />
l’attualismo può farsi fecondo ai fini di un ripensamento dell’idealismo classico 25 .<br />
<br />
Prima del fondamentale articolo scritto da Sciacca per l’Enciclopedia cattolica, la traccia<br />
<strong>della</strong> felice contraddizione dell’attualismo, era stato intravista e denunciata da un valoroso,<br />
solitario e perciò mai adeguatamente apprezzato, pensatore cattolico, il palermitano Pietro<br />
Mignosi 26 .<br />
Nella prima giovinezza, Mignosi, seguendo l’esempio di Francesco Acri, si era ribellato<br />
al plumbeo potere <strong>della</strong> <strong>filosofia</strong> positiva, nella quale vedeva l’espressione ufficiale di un<br />
rozzo pregiudizio antimetafisico, oltre che la manifestazione del disprezzo risorgimentale<br />
per la cultura del Meridione 27 .<br />
24 Michele Federico Sciacca attribuiva a Gentile la sequela di un dogma che identificava modernità e<br />
immanentismo, cfr. “Studi sulla <strong>filosofia</strong> moderna”, Marzorati, Milano 1968, pag. 321. Maria Adelaide Raschini<br />
osservava acutamente che Gentile credette di avere in tal modo unificato i due autori <strong>della</strong> storia vichiana, Dio e<br />
l’uomo. Cfr. “Gentile e il neoidealismo”, op. cit., pag. 101.<br />
25 Cfr. la voce Gentile, nell’Enciclopedia cattolica.<br />
26 Pietro Mignosi, Palermo 1895, Milano 1937. Dopo un avventuroso periodo di escursioni attraverso le filosofie<br />
moderne (dal cogito di Cartesio allo slancio vitale di Bergson, dal positivismo di Cosmo Guastella all’attualismo<br />
di Giovanni Gentile, ritrovò la fede cattolica e, in essa, diede inizio ad un movimento inteso a rinnovare la<br />
tradizione platonica. Convinto che la rivelazione del Dio personale abbia segnato una svolta nella storia <strong>della</strong><br />
<strong>filosofia</strong> occidentale, oltre che in quella delle religioni, Mignosi rimproverava agli idealisti di aver dimenticato il<br />
ruolo che ebbe, appunto, l’intuizione <strong>della</strong> personalità di Dio. Intorno a questa intuizione egli costituì e condusse<br />
l’animosa rivista <strong>“La</strong> Tradizione”, concepita per avviare, temperando l’intollerante verità con la tollerantissima<br />
misericordia, il dibattito tra cattolici e idealisti. Di qui fraintendimenti ingiustificati e sordi risentimenti, che,<br />
come ricordò mons, Giuseppe Petralia, si tradussero in “una ben riuscita congiura del silenzio, cui, sembra<br />
incredibile parteciparono cattolici e acattolici insieme”. Solo Armando Carlini, accolse l’invito al dialogo di<br />
Mignosi. Dal canto suo, Carmelo Ottaviano affermò che Mignosi fu vittima delle baronie universitarie cresciute<br />
alle spalle di Gentile: “se qualcuno chiedesse se mai il Mignosi abbia avuto tra noi quel pratico riconoscimento<br />
a cui il suo ingegno gli dà pieno diritto, la risposta non potrebbe che essere negativa. Il dominio degli idealisti<br />
nella cultura italiana si è tradotto in pratica nella più aperta partigianeria e nel più sfacciato vilipendio di quel<br />
principio che deve regolare e guidare chiunque sia veramente geloso del progresso culturale e scientifico di un<br />
popolo: la serena, oggettiva valutazione dei valori”. Cfr. “Pietro Mignosi”, nella rivista “Sophia”. 1936, III<br />
fasc., pag. 406. Su Pietro Mignosi cfr. inoltre: Ugo Redanò, “Pietro Mignosi”, nella rivista “Bilychnis, sett.<br />
1925; Michele Federico Sciacca, “Libri di estetica”, in “Dall’attualismo allo spiritualismo”, op. cit., pag. 30;<br />
Giuseppe Petralia, “Mignosi ovvero <strong>della</strong> trascendenza”, Palermo 1935; Aa. Vv. (Armando Carlini, Giovanni<br />
Papini, Emilio Fenu, ecc.), numero speciale <strong>della</strong> “Fiera letteraria”, 21 nov. 1954; Tommaso Romano, Pietro<br />
Mignosi: ricognizioni sulla vita e l’opera”, ISSPE, Palermo 1989, <strong>Piero</strong> <strong>Vassallo</strong>, “Pietro Mignosi”, ISSPE,<br />
Palermo 1989 (con una interessanti note introduttive di Vittorio Vettori e Giuseppe Tricoli).<br />
27 Un collaboratore <strong>della</strong> rivista di Mignosi, Pietro Maltese, sosterrà che, fatta l’Italia, “le nostre scuole, le nostre<br />
università furono invase da professori che, venivano dal continente con la convinzione di trovare in Sicilia un<br />
97