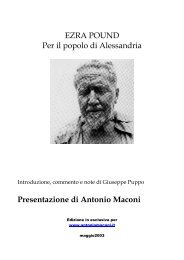Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Il paradosso è la categoria fondamentale dell’esistenzialismo cristiano.<br />
Kierkegaard lo definisce passione temeraria, che incita il pensiero a superare il<br />
proprio limite: “Il paradosso è la passione del pensiero, e i pensatori privi del<br />
paradosso sono come amanti senza passione: mediocri compagni di gioco. Ma il<br />
potenziamento estremo di ogni passione è sempre di volere la propria fine: così la<br />
passione più alta <strong>della</strong> ragione è di volere l’urto, benché l’urto possa in qualche<br />
modo segnare la sua fine. E’ questo allora il supremo paradosso del pensiero, di<br />
voler scoprire qualcosa ch’esso non può pensare. Questa passione del pensiero è in<br />
fondo presente dovunque nel pensiero, anche in quello del singolo, fin quando egli,<br />
col pensare, non si riduce a se stesso” 144 . Kierkegaard, pur non essendosi<br />
completamente liberato dall’influenza del pietismo 145 e del pessimismo luterano<br />
intorno alla ragione umana 146 , elaborò una versione dei preambula fidei aggiornata<br />
ai problemi posti dalla <strong>filosofia</strong> di Hegel.<br />
Le due opere teoretiche ora citate, infatti, sono intese a dimostrare, sulla scorta<br />
delle intuizioni di Trendelenburg e Jacobi, l’impossibilità di risolvere e superare il<br />
paradosso seguendo le orme del razionalismo moderno e di Hegel: se la ragione<br />
inciampa nel paradosso, vuol dire che non è stata la ragione ad inventare il<br />
paradosso, ma che il paradosso costituisce il limite per la ragione 147 .<br />
Nella “Postilla non scientifica”, Kierkegaard, imitando lo stile anticonformista<br />
d’un suo insegnante, Poul Möller 148 e traducendo in chiave umoristica le obiezioni<br />
riguardo la pagina del Diario, op. cit., vol. I, pag. 544, in cui si rimprovera a Kant di non aver compreso<br />
che il paradosso è una categoria, “una determinazione ontologica, che esprime il rapporto tra uno<br />
spirito esistente, conoscente, e la verità eterna”.<br />
144 “Briciole di <strong>filosofia</strong>”, op. cit., vol. I pag. 127.<br />
145 Secondo Cornelio Fabro il pietismo è “la chiave di volta del tanto discusso itinerario spirituale di<br />
Kierkegaard: qui fanno capo tanto i suoi ardimenti vertiginosi come la sorprendente inconclusività<br />
<strong>della</strong> sua opera e <strong>della</strong> sua vita”. Cfr. l’Introduzione al Diario, op. cit. pag. 66-74.Fabro però aggiunge:<br />
“Non bisogna dimenticare che in Kierkegard c’è anche dell’altro. C’è il ricorso alla classicità e<br />
all’umanità di Socrate, c’è la robusta problematica filosofica e teologica, dove non va trascurato il<br />
ricorso così poco pietista al problema di Lessing, c’è un senso vivo e mai smentito <strong>della</strong> realtà del<br />
divino e dell’umano e di un valore dell’azione che trascende l’angustia <strong>della</strong> spiritualità pietista e che<br />
è invece in funzione antipietista”.<br />
146 Cornelio Fabro avvertendo che, nell’opera di Kierkegaard, le tracce del pessimismo antropologico<br />
luterano non sono infrequenti, dichiara: “Io non sono kierkegaardiano e sento di dover fare molte e<br />
sostanziali riserve alle sue posizioni così in <strong>filosofia</strong> come in teologia. Cfr. l’Introduzione al Diario, op.<br />
cit., vol. I, pag. 81. E’ senza dubbio il pessimismo antropologico che induce Kierkegaard ad affermare,<br />
ad esempio, che il criterio <strong>della</strong> verità consiste nella resistenza che essa incontra quando è presentata<br />
agli uomini: “Il fatto che il segno è la resistenza, in fondo non fa se non esprimere l’interiorità <strong>della</strong><br />
convinzione che consiste nello sperare contro la speranza e nel credere contro ragione ecc.”. Cfr.<br />
Diario, op. cit., vol. I, pag. 732.<br />
147 Kierkegaard ha trattato umoristicamente l’opinione secondo cui “la <strong>filosofia</strong> in questo mondo non è<br />
mai stata come adesso così vicina ad assolvere il suo compito – di spiegare tutti gli enigmi”. Cfr. ad<br />
esempio Diario, op. cit., vol. I, pag. 396.<br />
148 Durante l’anno accademico 1835-1836, Kierkegaard seguì le lezioni tenute dal filologo danese Poul<br />
Möller (1794-1838) sul De anima aristotelico. Kierkegaard ammirava il suo professore e, nella Postilla<br />
lo ricorda con affetto: “Poul Möller, mentre l’hegelismo furoreggiava, era di altro parere: anzitutto<br />
47